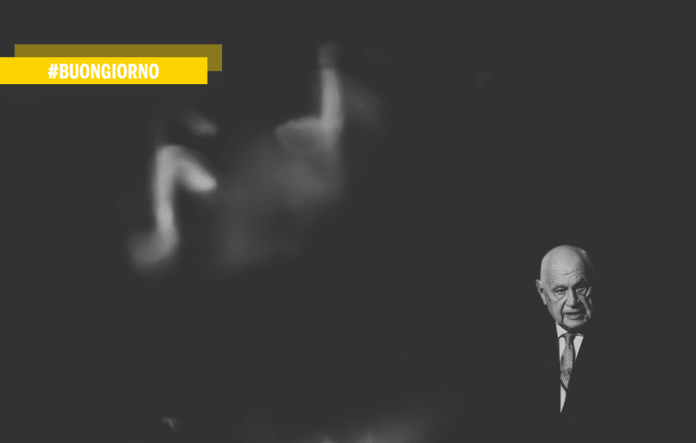L’Avana – Abbiamo cominciato a osservare Melissa il 21 ottobre. Si profilava come semplice tempesta tropicale, un grado inferiore a quello di uragano, che secondo la categoria Saffir-Simpson va da 1 a 5. Tuttavia sapevamo che il fatto che fosse così lenta non lasciava presagire niente di buono. Molto presto abbiamo capito che non si trattava di pronosticare se sarebbe passata per Cuba, ma solo di comprendere nella maniera più dettagliata possibile dove.
Mi occupo di prevenzione e gestione del rischio di disastri da quindici anni, sette di questi trascorsi a Cuba. Conosco i protocolli e so benissimo qual è il mio ruolo in una situazione del genere. Ho studiato per anni il sistema di preparazione messo a punto dall’EMNDC (Estado Mayor de la Defensa Civil) a Cuba, che molti nel mondo ammirano, e che ha permesso a questo piccolo Paese nel mar dei Caraibi di sopravvivere al rapido succedersi di uragani e tempeste dal trionfo della Rivoluzione in poi.
Tuttavia vivo qui e so che, al di là della propaganda di Stato e dei suoi mille detrattori, Cuba non è più quello che fu. Come a molti, mi brucia ancora il ricordo dell’uragano Oscar, che un anno fa devastò l’Oriente cubano. Ricordo che, quando una collega da Bruxelles mi aveva chiamato un giorno prima che Oscar toccasse suolo cubano, per sapere se avevamo bisogno di appoggio, io avevo risposto con un po’ di spavalderia: “Con un categoria 2 i cubani si lavano i denti”. E mi sbagliavo. Ancora oggi, dopo un anno, non c’è chiarezza sul numero di morti né sui danni causati da Oscar e dagli errori umani che ne seguirono, e in molti pensano che lo storicamente efficiente Sistema di Allerta Precoce quella volta non abbia funzionato.
Non sono l’unica a ricordare amaramente l’ottobre di un anno fa, i 3 (per alcuni fino a 7) giorni senza elettricità, i frigoriferi aperti, come sventrati, mentre i più fortunati cercavano di cucinare il cibo immagazzinato nel tentativo di salvarne almeno un po’, il caos di informazione e disinformazione e la netta sensazione, ascoltando gli spezzettati racconti dei colleghi sul territorio, che al di là dei battibecchi tra la stampa di regime e quella della dissidenza, qualcosa davvero non avesse funzionato nella preparazione e nella risposta. Purtroppo non siamo stati partecipi di alcun esercizio di apprendimento a posteriori, non sappiamo se la Protezione Civile abbia analizzato l’accaduto e tratto delle lezioni, né possiamo sperare di saperlo: vivere a Cuba significa anche troppo spesso oscillare fumosamente tra una stampa scandalistica e delegittimante per lo più finanziata dalla diaspora e ripresa dalla maggior parte dei media internazionali inclusi quelli italiani, e una di regime, basata nel Paese, che pubblica solo notizie ripulite e reimpacchettate, spesso inutilmente trionfaliste, sempre più scollate da quello che vediamo ogni giorno per le strade.
 Ma torniamo al 21 di ottobre. La lentezza dell’avvicinarsi di Melissa ha permesso a tutti di organizzarsi. La Protezione Civile ha evacuato circa 500.000 persone. A Cuba le evacuazioni preventive sono storicamente gestite su un doppio binario: tutti quelli che si trovino nella situazione di dover lasciare le proprie abitazioni, se hanno un familiare non lontano che vive in una casa definita sicura dalla Protezione Civile, si recano lì. Solo una piccola parte si reca nei rifugi, che in genere sono scuole allestite temporaneamente a riparo. Il meccanismo di evacuazione dei civili a Cuba non prevede obiezioni né giudizi individuali. Poco tempo fa, in una conversazione con uno dei medici Cubani che collaborarono a interrompere la trasmissione del virus dell’HIV da madre a figlio, lui parlando di come Cuba aveva affrontato l’HIV, mi disse: “A Cuba la vita di ogni cittadino vale più di ogni altra cosa. E per salvarla facciamo di tutto, a volte senza curarci del fatto che qualcuno possa essere o meno d’accordo con i nostri metodi. Come se disponessimo di queste vite”.
Ma torniamo al 21 di ottobre. La lentezza dell’avvicinarsi di Melissa ha permesso a tutti di organizzarsi. La Protezione Civile ha evacuato circa 500.000 persone. A Cuba le evacuazioni preventive sono storicamente gestite su un doppio binario: tutti quelli che si trovino nella situazione di dover lasciare le proprie abitazioni, se hanno un familiare non lontano che vive in una casa definita sicura dalla Protezione Civile, si recano lì. Solo una piccola parte si reca nei rifugi, che in genere sono scuole allestite temporaneamente a riparo. Il meccanismo di evacuazione dei civili a Cuba non prevede obiezioni né giudizi individuali. Poco tempo fa, in una conversazione con uno dei medici Cubani che collaborarono a interrompere la trasmissione del virus dell’HIV da madre a figlio, lui parlando di come Cuba aveva affrontato l’HIV, mi disse: “A Cuba la vita di ogni cittadino vale più di ogni altra cosa. E per salvarla facciamo di tutto, a volte senza curarci del fatto che qualcuno possa essere o meno d’accordo con i nostri metodi. Come se disponessimo di queste vite”.
Avevo personalmente sperimentato la verità di questa affermazione durante il covid, quando lo Stato aveva, per proteggere i suoi cittadini, imposto misure che sarebbero state reputate inaccettabili in moltissimi Paesi del mondo, proprio in virtù di questo dovere di protezione che va a volte anche al di là del riconoscimento dell’agentività dei cittadini e delle cittadine. Le evacuazioni nel momento di preparazione agli uragani, un processo doloroso in cui le persone sono obbligate a lasciare quanto di più caro hanno, e spesso anche i propri mezzi di sussistenza, funzionano nella stessa maniera. Bisogna salvare ciò che abbiamo di più prezioso, la vita. Tutto il resto verrà dopo.
Nel frattempo, memori degli eventi del 2024, diversi donatori europei tra cui la Germania, hanno annunciato già un paio di giorni prima del passaggio dell’uragano che avrebbero donato varie centinaia di migliaia di euro al CERF, il fondo di emergenza delle Nazioni Unite che con molta probabilità si occuperà della risposta. Un segnale di fiducia verso il multilateralismo. Peccato che il sessantennale embargo (le sanzioni unilaterali e con effetto extraterritoriale imposte dagli USA) unito alle arcinote lungaggini e complessità della burocrazia interna a Cuba, rendano praticamente impossibile importare qualsiasi bene in meno di tre mesi, un tempo interminabile per chi ha perso una casa, e anche per chi voglia portare soccorsi quasi immediati. E così stiamo assistendo a creativi appelli delle Nazioni Unite che chiedono a imprenditori e privati locali, intenzionati a rispondere, e che hanno accesso a prodotti già situati sul mercato locale, di palesarsi, e di unire le forze.
Al di là dell’encomiabile sforzo di coordinamento, emerge il fatto che la crisi della cooperazione internazionale è arrivata anche qui.
Intanto, il 29 ottobre, dopo 24 ore di pioggia e vento intensissimi, Melissa tocca terra come categoria 3 e colpisce le province di Holguin, Granma, Santiago e Guantanamo. Le ultime due sono regioni che negli ultimi anni si sono estremamente impoverite dal punto di vista sociale ed economico, e sono ancora in forte difficoltà dopo il passaggio dell’uragano Oscar nel 2024. Inoltre, si tratta delle zone di Cuba più colpite dalla degenerazione del sistema elettrico nazionale e dai lunghissimi e famosi apagones, i blackout che durano giorni interi, intervallati solo da poche ore di elettricità, che oramai flagellano senza interruzione il Paese. Quest’anno il Sistema di allerta precoce non fallisce, e tutti sono già pronti: le Ong internazionali hanno allertato i propri partner in loco sulla necessità di raccogliere informazioni al più presto, le Nazioni Unite hanno attivato il loro sistema di coordinamento, e soprattutto la Protezione civile cubana ha mobilitato quella complessa rete di militari e civili (compresa la Croce Rossa) che si occuperà della risposta nelle ore immediate al passaggio di Melissa. Nel giro di 24 ore l’uragano si allontana, dopo aver lasciato distruzione e paura, ma le conseguenze proseguono per i giorni successivi: i fiumi in piena a causa della pioggia, cominciano a esondare il 31 ottobre, soprattutto nella provincia di Granma, obbligando la Protezione civile a una massiccia operazione di salvataggio che includerà persino un trasporto massivo di persone via treno.
Mentre scrivo questo articolo sembra che siamo usciti dalla fase più critica e che tutti possiamo occuparci della delicatissima fase di recupero.
Che cosa abbiamo imparato, come cittadine e persone che si occupano di preparazione e risposta al rischio di disastri?
- Che i tempi sono cambiati e anche il governo cubano sta lentamente transitando verso un’altra modalità di risposta: è dell’1 novembre l’emissione di una Gazzetta ufficiale che stabilisce formalmente che il governo pagherà il 50% delle spese di ricostruzione a tutti i cittadini che debbano riabilitare le proprie abitazioni. Usciamo dunque dalla logica del “se ne occuperà lo Stato”, che negli ultimi anni si era tristemente trasformata in una vuota retorica, visto che lo Stato non aveva più le risorse per occuparsi di tutto. Entriamo in una logica di accompagnamento, dove lo Stato riconosce il ruolo protagonista dei cittadini e tuttavia si sforza di offrire una partecipazione e un supporto. Restano da verificare l’implementabilità e la sostenibilità di questa offerta.
- Che i tempi sono cambiati (reprise), e si ammette la necessità, al di là delle agenzie nazionali e internazionali che tradizionalmente si occupano di questo, di appoggiarsi a tutte quelle reti di privati cittadini che, dalle zone di Cuba meno toccate dall’uragano e spesso anche dall’estero, offrono supporto materiale e donazioni. Questo cambiamento di tendenza ebbe inizio, ricordo, con il tornado che colpì l’Avana nel 2019. Da pochi mesi i cubani avevano avuto accesso alla connessione 3G sui cellulari. Grazie a essa, movimenti di cittadini si mobilitarono rapidissimamente per portare aiuti al di là e a prescindere dalla risposta ufficiale.
- Che il cambiamento climatico non è un’opinione e bisogna pensare in termini di sistemi: per la prima volta assistiamo allo sforzo congiunto di agenzie basate in paesi diversi (Cuba, Jamaica, Bahamas), di ragionare sull’impatto dell’evento e unire le energie, non solo per la risposta, ma per le prossime preparazioni.
- Che il cambiamento climatico non è un’opinione (reprise), gli eventi potenzialmente disastrosi si intensificano in termini di frequenza, si fanno di natura più imprevedibile e quindi diventa difficile fare preparazione secondo il modello del “business as usual”.
Insomma sarebbe interessante, al di là delle usuali polemiche di carattere ideologico che emergono inevitabilmente quando si parla di Cuba, guardare a questo recente evento come a una fonte di apprendimento, un pilota, qualcosa che può indicarci una direzione per il futuro della prevenzione e nella risposta dei disastri di origine naturali.
L’autrice: Carla Vitantonio è cooperante, autrice, attrice. Ha lavorato come capo missione per Ong internazionali in Corea del Nord, dove ha passato quattro anni. Attualmente vive a Cuba, fra i suoi libri Bolero Avana (Add)