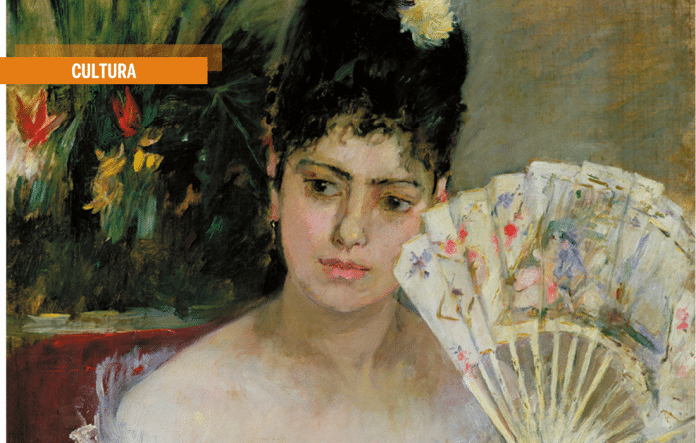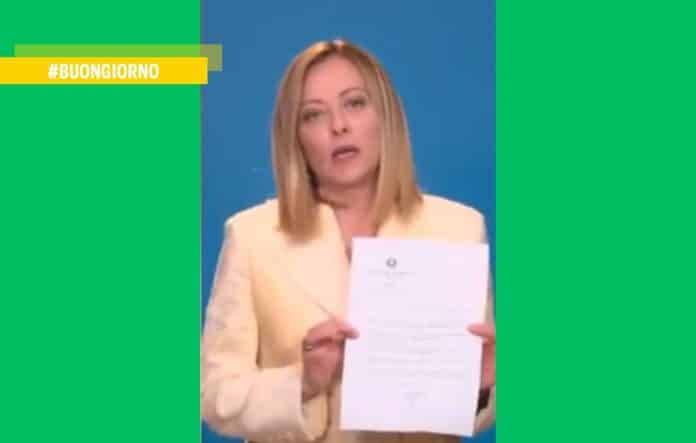Dopo essere riuscito per quattro anni ad evitare per un pelo la prigione, Donald Trump è tornato alla Casa Bianca. Per molti osservatori al di fuori degli Stati Uniti, la rielezione di un criminale condannato che ha cercato di ribaltare illegalmente un’elezione è sconcertante. Ma la seconda vittoria di Trump non è stata un caso fortuito. Sebbene Trump abbia abbandonato la politica formale nel 2021, le forze che lo hanno portato al potere non lo hanno fatto. Questa volta, è entrato in carica molto meglio organizzato, molto più forte e con una base politica più diversificata. In meno di una settimana, Trump ha già rivelato il suo obiettivo e messo a nudo la debolezza di coloro che potrebbero sfidarlo.
C’è un’ombra di qualcosa di colossale e minaccioso che sta iniziando a calare sulla terra proprio ora. Chiamatela l’ombra di un’oligarchia, se volete; è la cosa più vicina che oso immaginare. Quale possa essere la sua natura mi rifiuto di immaginarla. Ma quello che volevo dire era questo: vi trovate in una posizione pericolosa. Jack London, Il tallone di ferro (1907:67-68)
Vent’anni fa, chi avesse definito gli Stati Uniti un’oligarchia sarebbe stato etichettato come un comunista o, nella migliore delle ipotesi, un pazzo. Lo scorso 15 gennaio Biden ne ha fatto un punto centrale del suo discorso di addio al popolo americano, e ha anche messo in guardia da un complesso tecnologico-industriale. Biden ha avvertito gli americani che pochi privilegiati potrebbero presto essere pronti a esercitare un potere enorme negli Stati Uniti. Ha descritto una “pericolosa concentrazione di potere nelle mani di pochissime persone ultra-ricche e le pericolose conseguenze se il loro abuso di potere non viene controllato”. “Oggi, in America sta prendendo forma un’oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza che minaccia letteralmente l’intera democrazia, i nostri diritti fondamentali e la nostra libertà, e una giusta possibilità per tutti di andare avanti”, ha affermato Biden.
Un’oligarchia è una società governata da pochi e una plutocrazia è una società governata dai ricchi: oggi negli Stati Uniti abbiamo i segni di entrambe, grazie ad un “übercapitalismo” apertamente denunciato da Bernie Sanders nel suo recente libro Sfidare il capitalismo (Fazi Editore, Roma 2024).
Quello di Biden è stato un riconoscimento salutare (ma tardivo e ipocrita, visto che almeno 83 miliardari hanno sostenuto la campagna di Kamala Harris) che, soprattutto da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti – con la decisione Citizens United del 2010 – ha aperto le porte a enormi flussi di denaro non trasparente in politica, gli individui ricchi incontrano pochi ostacoli nell’acquistare potere politico. Sul piano costituzionale, gli Stati Uniti rimangono una democrazia liberale rappresentativa e la maggior parte delle sue istituzioni funziona, ma ora oligarchi plutocratici come Elon Musk e Peter Thiel si sono messi al centro delle campagne politiche e aspirano a governare, senza più fingere di avere impulsi/valori progressisti pro-sociali e pro-democrazia. Questa nuova visibilità, dimostrata in modo sfacciato dai leader dei grandi monopoli tecnologici del “capitalismo della sorveglianza” – tra gli altri, Jeff Bezos di Amazon, Sundar Pichai di Google, Mark Zuckerberg di Facebook/Meta, Sam Altman di OpenAI, Tim Cook di Apple, ed Elon Musk di Tesla/SpaceX/X – seduti di fronte ai ministri designati da Trump all’inaugurazione, potrebbe anche rendere gli oligarchi più vulnerabili politicamente. Raramente nella storia recente la guerra di classe è stata condotta in modo così sfacciato. In genere, i miliardari impiegano delle controfigure per attaccare i poveri per loro conto. Ma ora, liberati dalla vergogna e dall’imbarazzo, non nascondono più il loro coinvolgimento. Negli Stati Uniti, l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, guiderà l’assalto federale alle classi medie e lavoratrici: cercando di tagliare la spesa pubblica e le protezioni pubbliche che difendono le persone dal capitale predatorio.
“Oligarca” non è solo una parolaccia per gli ultra-ricchi o un sinonimo di “élite”, né significa solo il governo di pochi. Se quest’ultimo fosse vero, tutte le democrazie rappresentative dovrebbero essere considerate oligarchie, poiché i membri dei Parlamenti hanno senza dubbio più potere politico dei cittadini ordinari. Piuttosto, Aristotele – al quale dobbiamo le designazioni dei diversi regimi – intendeva l’oligarchia come governo dei ricchi (al contrario, la democrazia significava governo dei poveri o del popolo). In un’oligarchia, pertanto, il potere è detenuto da un gruppo di persone in base alla loro ricchezza, allo status nobiliare o religioso, al grado militare e così via. Il termine è anche utilizzato per descrivere Paesi in cui un piccolo gruppo di persone ha molto potere anche se non governa formalmente.
Trump è un narcisista, un bullo e un cercatore di accordi che non desidera avere obblighi verso gli altri. Sta creando una monarchia elettorale non soggetta al controllo parlamentare, un sistema in cui tutto il potere è personalizzato e tenuto nelle sue mani, una ricetta certa per flussi distorti di informazioni, corruzione, instabilità e impotenza amministrativa. Per i sostenitori di Trump, c’è un senso di energia machista scatenata, quasi messianica, che sta avviando gli Stati Uniti verso un destino nazionale che potrebbe comprendere l’annessione di Groenlandia, Canada, canale di Panama e infine Marte. Trump ha annunciato che l’età dell’oro dell’America inizia adesso. E nella sua prima settimana, ha lanciato una rivoluzione politica di destra semplicemente firmando circa 100 ordini esecutivi che avranno un pesante impatto sulla vita di milioni di americani e non cittadini, avviando la deportazione di milioni di migranti clandestini, che lui dice stanno “avvelenando il sangue” degli Stati Uniti; schierando truppe al confine tra Stati Uniti e Messico per “un’emergenza nazionale” per fermare i migranti “coinvolti nell’invasione attraverso il confine meridionale”; attentando al diritto costituzionale (previsto dal 14° emendamento) alla cittadinanza (per i bambini nati negli Stati Uniti se né la madre né il padre sono cittadini statunitensi o residenti permanenti legali); invertendo le politiche di genere e diversità (Dei) per arrivare a revocare anche un ordine esecutivo contro la discriminazione firmato da Johnson nel 1965 che istituiva l’Ufficio federale dei programmi di conformità contrattuale (Ofccp); ripristinando l’ordine esecutivo del primo mandato, denominato Schedule F, che priverebbe potenzialmente decine di migliaia di dipendenti pubblici delle tutele occupazionali e li renderebbe più facili da licenziare; abbandonando praticamente la lotta contro la crisi climatica; dichiarando un’emergenza energetica nazionale per espandere la produzione di petrolio e gas naturale (il nuovo piano per la politica industriale è “drill, baby, drill”), eliminare le normative e porre fine alle regole volte ad accelerare la transizione ai veicoli elettrici (ha definito le misure climatiche dell’Ira (Inflation reduction act) come “la più grande truffa nella storia di qualsiasi paese”); e liberando i circa 1.500 criminali violenti che lo avevano sostenuto nel tentativo di colpo di Stato del 6 gennaio 2021. I repubblicani hanno sostenuto di essere il partito della “legge e dell’ordine” sin dai tempi di Richard Nixon, ma Trump, il primo criminale condannato eletto presidente, ha ribaltato la più grande indagine del Dipartimento di Giustizia della storia. Una manciata di senatori repubblicani ha condannato la sua decisione, ma la maggior parte lo ha sostenuto o è rimasta in silenzio, un tacito riconoscimento del suo immenso capitale politico. Nella sua intervista alla Fox News, Trump ha liquidato la violenza contro la polizia come “incidenti molto minori”.
La trasformazione radicale di Trump è sostenuta da assistenti e avvocati che hanno trascorso quattro anni a preparare il suo ritorno. C’è anche il “Progetto 2025” per espandere il potere esecutivo e rimodellare la vita americana, elaborato nel corso di due anni dal think tank conservatore Heritage Foundation insieme ad un consorzio di organizzazioni conservatrici (da cui Trump ha cercato di prendere le distanze ma molti dei suoi ex ed attuali collaboratori sono stati direttamente coinvolti e vi hanno contribuito). L’azione di Trump sta in gran parte seguendo le indicazioni del “Progetto 2025” e si basa anche sulla premessa di una legittimità percepita. “La mia recente elezione è un mandato per invertire completamente e totalmente un orribile tradimento”, ha detto Trump nel suo discorso inaugurale. Il sito web della Casa Bianca afferma che ha ottenuto una “vittoria elettorale schiacciante” nel 2024. Tuttavia, la vittoria di Trump non è stata una valanga. Ha ottenuto meno della metà del voto popolare nazionale e ha battuto Kamala Harris solo di 1,5 punti percentuali. I repubblicani hanno perso alcune gare chiave al Senato e hanno mantenuto la Camera dei rappresentanti solo per un margine sottile. I sondaggi di opinione mostrano che tre americani su quattro si sono opposti alla grazia per gli insorti del 6 gennaio. Trump si trova ad affrontare divisioni all’interno del partito repubblicano al Congresso e del movimento MAGA e un elettorato che chiede risultati rapidi. Le mosse di Trump per sovvertire la burocrazia federale (che lui ritiene che gli sia stata ostile durante la sua presidenza 2017-2021), in particolare il cosiddetto “deep State”, hanno scatenato paura e confusione: le agenzie sono prese dall’incertezza su come implementare una valanga di nuove politiche del presidente mentre i lavoratori valutano l’impatto sulle loro vite. Trump ha sabotato il suo primo mandato con la sua notoriamente breve capacità di attenzione, la riluttanza a leggere i documenti politici e la promozione del caos e della disfunzione. Ha uno stile di governo in cui guida con sfacciataggine e poi ricorre alle minacce. C’è il grande discorso e gli annunci appariscenti, ma poi c’è il tipo di duro lavoro di governo e Trump sembra addormentarsi quando arriva al duro lavoro. Il suo è un programma di destra radicale, ma vedremo fin dove arriverà. Gli oppositori di Trump affermano che sta distorcendo la Costituzione degli Stati Uniti e che sta espandendo i limiti del potere esecutivo oltre il limite previsto. Affermano inoltre che le mosse iniziali di Trump dimostrano che è meno interessato a unire il Paese che a trasformarlo radicalmente, e in molti casi a esigere vendetta per punire i nemici politici e intimidire i media.
Le prime settimane della sua amministrazione potrebbero rappresentare l’apice del potere di Trump, come riconoscono alcuni sostenitori. Molti degli ordini esecutivi di Trump mettono alla prova i limiti del diritto costituzionale. Un ordine per porre fine alla cittadinanza per nascita, una dottrina costituzionale che sostiene che quasi tutti coloro che nascono negli Stati Uniti sono automaticamente cittadini, è già stato bloccato da una corte federale. Diversi altri impegni e ordini hanno subito affrontato cause legali da parte di Stati e organizzazioni di difesa, e lo shock e lo stupore della sua prima settimana potrebbero impantanarsi in un contenzioso che durerà per gran parte del suo mandato. Trump potrebbe dover affrontare una sfida nel mantenere la stretta maggioranza dei repubblicani al Congresso nella Camera dei rappresentanti tra due anni. Il partito del presidente in carica perde spesso seggi alle elezioni di medio termine. Se ciò accadesse, si tradurrebbe nella chiusura totale del già stretto percorso legislativo per Trump. Insomma, ci saranno opportunità legali, politiche e sociali per gli oppositori. Anche i piccoli successi, soprattutto se ottenuti in collaborazione con altri, possono ricordare alle persone cosa è possibile fare di fronte a quelle che possono sembrare forze insormontabili.
Il 45° e 47° presidente, di ritorno alla Casa Bianca ha elettrizzato la sua base di sostenitori con una serie di condoni e azioni progettate per rimodellare il paese, anche se, come ha notato Bernie Sanders, ha ignorato quasi ogni problema significativo che le famiglie lavoratrici statunitensi devono affrontare (dal costo di cure sanitarie e medicine ai bassi salari, alla crisi alloggiativa, all’accesso all’istruzione superiore). Da un discorso inaugurale in cui sosteneva di essere stato scelto da Dio per la missione di rifare l’America alla firma teatrale di ordini esecutivi davanti a una folla chiassosa, il suo aggressivo consolidamento del potere ha suscitato paragoni con la monarchia (un popolo che è nato dalla rivolta e guerra contro monarchi crudeli ora ha il proprio). La miscela di politica, ideologia ed escatologia megalomane è particolarmente importante perché Trump ha legato il destino degli Usa alle sue fortune personali come nessun altro presidente prima di lui. Come lui sostiene, la realizzazione del programma America First (arrestare il declino statunitense vis-à-vis l’ascesa della Cina, esaltare il nativismo bianco di ascendenza europea, sostenere il nazionalismo cristiano xenofobico e razzista, predicare il libertarismo anarco-capitalistico, imporre protezionismo e unilateralismo in politica estera) è inestricabilmente legata al suo potere personale. Ma l’assalto veloce e furioso, definito “shock and awful” (piuttosto che “shock and awe”) dai critici, ha incontrato rapide sfide legali e reazioni politiche.
La torsione monarchica di Trump non è solo merito suo. Nel secolo scorso, presidenti come Franklin Delano Roosevelt hanno esteso la portata della presidenza negli affari economici e internazionali. Dopo la guerra del Vietnam, lo storico Arthur Schlesinger ha definito questa l’ascesa della “presidenza imperiale”. Ma non si è fermata. Nella sua intervista a David Frost, Richard Nixon ha sostenuto che se un presidente approva qualcosa, non è illegale. La Corte Suprema ha dato a questa visione, un tempo impensabile, la sua benedizione della maggioranza l’anno scorso, stabilendo che un presidente possiede l’immunità assoluta per qualsiasi atto ufficiale. Una giudice liberale, Sonia Sotomayor, ha affermato che questo ha reso il presidente “un re al di sopra della legge”. Attualmente, i poteri imperiali che Trump potrebbe utilizzare comprendono: uccidere cittadini americani senza un giusto processo, detenere sospettati (compresi cittadini americani) a tempo indeterminato, privare gli americani dei loro diritti di cittadinanza, effettuare una sorveglianza di massa sugli americani senza una causa giustificabile, dichiarare guerre senza l’autorizzazione del Congresso, sospendere le leggi in tempo di guerra, ignorare leggi con cui potrebbe non essere d’accordo, condurre guerre segrete e convocare tribunali segreti, sanzionare la tortura, eludere le legislature e i tribunali con ordini esecutivi e dichiarazioni firmate, ordinare all’esercito di operare al di là della portata della legge, mobilitare un esercito permanente sul suolo statunitense, gestire un governo ombra, dichiarare emergenze nazionali per qualsiasi motivo e agire come un dittatore e un tiranno, al di sopra della legge e al di là di ogni reale responsabilità.
Come afferma l’editorialista Ezra Klein, la domanda che pone Donald Trump è: “Quanto può essere re?” E con un re, inevitabilmente arriva anche una corte che può diventare un mercato, dove membri della famiglia reale, oligarchi, ministri, consiglieri, favoriti, adulatori, agenti, faccendieri e imbonitori competono per l’attenzione e il favore del sovrano. Questo è esattamente il motivo per cui lo stesso George Washington potrebbe riconoscere il sistema politico di corte che ora prospera attorno a Trump come qualcosa di simile alla forma di governo regale contro cui fu spinto a ribellarsi quasi 250 anni fa.
Gli aristocratici sono “gli animali più difficili da gestire, di qualsiasi cosa in tutta la teoria e la pratica del governo. Non si lasceranno governare”, avvertì uno dei “padri fondatori”, John Adams, scrivendo dopo la sua presidenza (1797-1801). Vietare i titoli non era sufficiente; alcuni si sarebbero comunque distinti per nascita o, soprattutto, per ricchezza. Il problema non era solo la loro capacità di acquistare favori politici, ma la presa che il loro denaro aveva sulla mente delle persone. Ecco perché i “padri fondatori (tutti maschi bianchi proprietari di schiavi neri) si sono impegnati per proteggersi da questo tipo di potere assoluto e concentrato, istituendo un sistema di controlli e bilanciamenti che separa e condivide il potere tra tre rami pari (esecutivo, legislativo e giudiziario) per garantire che nessuna autorità singola sia investita di tutti i poteri del governo.
Il potere economico e quello politico si intrecciano ovunque. La paura dell’influenza sproporzionata dei ricchi è esistita per tutta la storia degli Stati Uniti. Tuttavia, a volte la relazione diventa particolarmente dura e minacciosa. Nel suo monito contro gli oligarchi, Biden ha evocato la Gilded Age del XIX secolo e i “baroni ladri” (Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, John Pierpont Morgan e John D. Rockefeller) e i loro monopoli, che schiacciavano i concorrenti, sfruttavano i lavoratori, compravano giudici e politici e ostentavano la ricchezza. La ricchezza del team di Trump è creata e immagazzinata nei mercati finanziari; il loro patrimonio netto è la somma della fiducia che i grandi fondi finanziari (BlackRock, Vanguard, State Street, etc.) e altre persone abbienti ripongono nel loro potere di accumulazione. Viaggia facilmente e può comprare cittadinanza, sicurezza e influenza quasi ovunque.
Ecco perché Trump rimarrà fedele ai suoi miliardari, o almeno alle politiche che li hanno arricchiti: lui è uno di loro, con uno stile da “barone ladro” transazionale che sostiene che le tasse sono per i perdenti. Durante la sua prima amministrazione, nonostante le promesse populiste fatte durante la campagna elettorale, Trump alla fine si è schierato con i ricchi. Steve Bannon, il capo stratega di Trump all’inizio del suo primo mandato, ha spinto per aumenti delle tasse per i ricchi. Dopo sette mesi di presidenza, Trump lo ha licenziato e poi ha proceduto ad approvare tagli fiscali per ricchi e grandi corporation, per cui le 400 famiglie miliardarie più ricche degli Stati Uniti hanno pagato un’aliquota fiscale media inferiore rispetto alla metà più povera delle famiglie, quella della classe lavoratrice americana.
Nella sua nuova amministrazione, la destra nazionalista farà sicuramente dei progressi: è entusiasta delle mosse di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita e della sua promessa di andare avanti con le deportazioni di massa. Per questa destra si tratta di riportare l’America all’epoca precedente alla diffusione dei diritti – sociali ed economici del New Deal di FDR degli anni Trenta; civili e politici della ”Great Society” di Johnson degli anni Sessanta -, diritti che ritiene abbiano oscurato l’identità bianca, anglosassone e protestante del Paese. Ma se mai dovesse entrare in conflitto con ciò che vogliono i ricchi consiglieri di Trump nel mondo della tecnologia (portare l’America nell’epoca futura, dove le piattaforme social sono le nuove arene per esercitare una libertà di parola senza regole) è probabile che il suo ruolo verrebbe ridimensionato. Trump sta tentando di dare vita ad un nuovo ordine politico basato sul connubio tra conservatorismo tradizionalista (MAGA) e post-conservatorismo tecnologico (tech-right) dominato da un gruppo ristretto di persone.
La politica degli oligarchi può assumere forme molto diverse, non sono tutti necessariamente conservatori, ma hanno sempre un interesse in comune: proteggere la propria ricchezza. Storicamente, ciò potrebbe significare impiegare un esercito privato; può anche tradursi in sottomissione a un despota, che premia la lealtà con almeno un po’ di sicurezza e lucrativi contratti governativi. Nelle democrazie rappresentative liberali, ha significato esternalizzare la protezione della proprietà allo Stato, assicurandosi al contempo che la maggioranza non si faccia venire strane idee su aliquote fiscali elevate e restrizioni alla libertà privata di commercio, industria e finanza. Per questo il capitalismo ha sempre avuto un problema con le libertà democratiche che esistono solo grazie alle grandi lotte popolari condotte sotto le bandiere del socialismo dalla fine del XIX secolo.
Come ha notato Franco Ferrari, mentre la democrazia liberale si fonda sul principio dell’uguaglianza degli individui, il capitalismo si basa sulla disuguaglianza affermata come principio regolatore ineludibile (mascherata dalla retorica del “merito”). È stata in larga parte l’azione del movimento operaio socialista e comunista che, perseguendo il principio dell’uguaglianza sociale, ha posto le condizioni per una democratizzazione, relativa, del capitalismo. L’evoluzione politica e sociale degli ultimi decenni, dominata dal paradigma ideologico neoliberista (nelle versioni sia progressiste di centro-sinistra sia conservatrici di centro-destra), ha cambiato il contesto complessivo e ha consentito al capitalismo di tornare a sviluppare, senza vincoli, la propria naturale tendenza a produrre sempre maggiore disuguaglianza. Questa è fondata sulla concentrazione della ricchezza che si trasforma inevitabilmente in una concentrazione del potere. In un saggio per il think tank conservatore Cato Institute, Peter Thiel è arrivato a scrivere: “Non credo più nella compatibilità di democrazie e libertà [perché] se abilitato, il demos finirà inevitabilmente per votare restrizioni al potere dei capitalisti e quindi restrizioni alle loro libertà”.
L’1% più ricco degli americani possiede il 30% della ricchezza nazionale, mentre il 97,5% del patrimonio netto totale è detenuto dal 50% più ricco, ma la vera divisione non è tra l’1% e il resto; piuttosto, la linea di confine cruciale corre tra ciò che i gestori patrimoniali liquidano come i semplici “ricchi di massa” (tra loro c’è anche il gruppo Patriotic Millionaires che a Davos ha fatto campagna pro-tasse) e gli oligarchi che possono pagare per i servizi dell’industria della difesa della ricchezza accumulata. Persino i professionisti con redditi elevati non possono permettersi gli avvocati e i contabili necessari per creare società paravento e trasferire denaro nei paradisi fiscali; coloro che possono permetterselo, ovvero il decimo più alto dell’1%, finiscono per dover pagare meno tasse delle loro segretarie (per riprendere il famoso esempio di Warren Buffett). Apparentemente Musk ha pagato il 3,4% di imposta federale sul reddito tra il 2014 e il 2018.
L’industria della difesa della ricchezza accumulata è discreta; parte di ciò che il mondo offshore offre agli oligarchi è la segretezza. Come ha osservato la sociologa Brooke Harrington, alcuni dei ricchi pagano persino i professionisti per aiutarli a mimetizzarsi, nascondersi dall’occhio pubblico e non comparire nella lista di Forbes. Allo stesso tempo, gli oligarchi hanno un chiaro interesse nel plasmare l’opinione pubblica. In un’epoca in cui i “media tradizionali” sono in difficoltà finanziarie, è diventato molto più economico acquistare giornali o canali TV, come hanno fatto il defunto Silvio Berlusconi e l’imprenditore Vincent Bolloré, un importante sostenitore dell’estrema destra in Francia. Le piattaforme dei social media sono un po’ più costose, ma la loro portata globale offre anche possibilità uniche per influenzare la politica in molti Paesi diversi, come dimostra l’ossessivo poster Musk quasi ogni ora del giorno e della notte.
Resta insolito, tuttavia, che gli oligarchi si appropriano personalmente delle leve dello Stato, a meno che, come nel caso di Berlusconi, entrare in politica non sembri l’unico mezzo per evitare il crack finanziario e la prigione. Dei nominati politici di Trump – l’uomo che si scaglia contro le élite e si rivolge a coloro che sono rimasti indietro, i perdenti dell’era della globalizzazione – 26 hanno fortune che superano i 100 milioni di dollari; 13 sono miliardari, un variopinto gruppo di persone ultra-ricche che ha una cosa in comune: si autodefiniscono tutti dei “disruptor” che mirano a distruggere (non a riformare) gli attuali sistemi di governo. Il suo è il governo più ricco nella storia del Paese. Inoltre, c’è la persona più ricca del mondo – Elon Musk, che durante la cerimonia inaugurale ha rivolto ai suoi sostenitori il saluto nazi-fascista – in un ruolo ampiamente indefinito e completamente irresponsabile come promotore di “efficienza governativa” (DOGE). Musk, la prima persona il cui patrimonio netto ha superato i 400 miliardi di dollari, afferma che i cittadini affronteranno “difficoltà temporanee” mentre il suo Dipartimento taglia la spesa pubblica. Ha affermato che potrebbero essere tagliati “almeno” 2.000 miliardi di dollari dalla spesa federale, una cifra superiore all’intero budget discrezionale (una contrazione le cui conseguenze sarebbero devastanti per la maggior parte degli americani). Trump e Musk vogliono tagliare il bilancio federale in modo da poter tagliare le tasse per gli ultra-ricchi.
Questa classe ha bisogno di tutto l’aiuto possibile: dal 2020, la ricchezza dei 12 uomini più ricchi degli Stati Uniti è aumentata “solo” del 193% e collettivamente ora possiedono “solo” 2 trilioni di dollari. Questo mentre gli “oil-garchi” stanno già raccogliendo i frutti per aver sostenuto Trump, amico dei combustibili fossili (le grandi compagnie petrolifere hanno speso 445 milioni di dollari nell’ultimo ciclo elettorale per influenzare Trump e il Congresso). L’elezione di Trump è stata una risposta ai crudeli fallimenti del neoliberismo, ma sarà anche la loro massima espressione. È stata una risposta alla corruzione del sistema politico da parte del denaro privato. E sarà la massima corruzione del sistema.
Se il programma di Musk avrà successo, difficilmente dovremo immaginare i suoi impatti sulla vita umana e sul mondo vivente, perché nell’ultimo anno un piano simile è stato attuato in Argentina. Lì, Javier Milei ha condotto la sua guerra di classe per conto del capitale internazionale. I risultati includono un’orribile ondata di povertà; un crollo del numero di persone con assicurazione sanitaria, unito a un sottofinanziamento critico del sistema sanitario pubblico; la proliferazione di crimini d’odio; un assalto coordinato alla scienza e alla protezione ambientale; e un libero accesso per le corporation straniere che sperano di impossessarsi dei minerali, della terra e della manodopera del Paese.
Un massiccio programma di tagli e deregulation che Musk e gli altri oligarchi trumpiani cercano di estendere grazie alla politica sadomasochistica ora in ascesa su entrambe le sponde dell’Atlantico. I demagoghi hanno scoperto che non importa quanto soffrano i loro seguaci, finché i loro nemici designati soffrono di più. Se riescono a continuare ad aumentare il dolore per i capri espiatori (principalmente gli immigrati e i poveri), gli elettori li ringrazieranno per questo, indipendentemente dal loro dolore. Questa è la grande scoperta degli oligarchi guidati dallo stesso Musk: ciò che conta in politica non è quanto bene stanno andando le persone, ma quanto bene stanno andando in relazione ai gruppi esterni designati come capri espiatori.
Comunque, la strana miscela di visibilità e invisibilità crea vulnerabilità. In fondo, Trump guida una banda di arrivisti, nemici dell’”establishment corrotto” delle coste orientali e occidentali, assetati di denaro e nazionalisti irriducibili. Ci sono i conflitti di interessi e gli scandali che deriveranno dal saccheggio dello Stato (anche se, per ora, sia i democratici che il pubblico in generale sembrano semplicemente rassegnati a una cleptocrazia su una scala senza precedenti); le grandi promesse di “efficienza” di Musk potrebbero rimanere insoddisfatte; le teorie del complotto e la pura petulanza di oligarchi neo-trumpisti come Mark Andreessen (Netscape) – che si lamentano del fatto che l’amministrazione Biden aveva scatenato il “terrorismo” contro l’industria tecnologica – intaccano l’immagine dei geni della Silicon Valley sempre pronti con una soluzione ai problemi dell’umanità.
Gli oligarchi possono essere umiliati o quanto meno messi sotto controllo di regole? Gli analisti sono pessimisti sul fatto che qualsiasi cosa che non siano guerre o catastrofi economiche come la Grande Depressione determini un cambiamento fondamentale. In linea di principio, le leggi possono impedire la concentrazione del potere: i parlamentari e magistrati italiani hanno cercato di limitare il numero di canali TV che Berlusconi poteva controllare; gli antichi ateniesi usavano l’ostracismo per espellere chiunque avesse troppo potere dalla politica (anche se non c’era nulla di sbagliato nel loro carattere individuale). Ai nostri giorni, il teorico politico John P. McCormick, riprendendo gli insegnamenti di Machiavelli, suggerisce che solo la minaccia di processi popolari, con una possibile pena di morte, può far sì che i ricchi si astengano dal combinare misfatti.
Alla fine, la scommessa migliore rimane il potere di contrasto: una cittadinanza attiva, il cui impegno è ampiamente definito dalla protesta, organizzazioni forti, siano esse sindacati o associazioni della società civile, media indipendenti e, non dimentichiamolo, la politica democratica: Franklin Delano Roosevelt, che non ha evitato di usare la parola oligarchia (economica) nei suoi discorsi nella campagna elettorale del 1932, non aveva automaticamente il mandato di perseguire il potere concentrato a causa della Grande Depressione; lo ha rivendicato e costruito. A tal fine, è utile rendere visibili gli oligarchi, che saltano su e giù accanto al presidente Trump.
Sebbene vi siano molteplici grandi ego plutocratici intorno a Trump e quindi c’è la possibilità che si scatenino sanguinose faide interne tra diverse fazioni – da un lato, i nazionalisti di estrema destra e i reazionari (fautori di un “codice morale neo-vittoriano” che enfatizza il tradizionalismo socio-culturale conservatore, il patriarcato e le gerarchie razziali) del movimento MAGA (come Stephen Miller e Steve Bannon) che hanno sostenuto Trump da quando è sceso dalla sua scala mobile dorata nel 2015; dall’altro, la destra tecnologica (la “tech-right”) neoliberista e globalista di Elon Musk e delle altre élite della Silicon Valley, tra cui Peter Thiel e Marc Andreessen, diventati ferventi sostenitori di Trump più di recente; gruppi che si stanno già scontrando su aspetti chiave della repressione dell’immigrazione. L’imprenditore tecnologico miliardario Vivek Ramaswamy ha abbandonato la direzione del programma DOGE dopo uno scontro con Elon Musk (ma si candiderà alla carica di governatore dell’Ohio per il GOP).
Ma è probabile che il matrimonio tra Trump e gli oligarchi della tech-right – che prevede l’assenza di qualunque diaframma fra potere politico e affari, al punto che nessuna ingerenza e nessun conflitto d’interessi ormai sembrano troppo spudorati – prosperi senza sfide esterne. Mentre la rabbia cresceva all’inizio del secolo scorso, il presidente Theodore Roosevelt indebolì i “malfattori della ricchezza” distruggendo i trust, creando agenzie di regolamentazione e rendendo i terreni inaccessibili allo sfruttamento commerciale. Molti americani desiderano ardentemente un altro “accordo equo”. Ma la ricchezza consente ai suoi proprietari di plasmare la realtà. Le ferrovie che arricchirono i magnati del XIX secolo hanno letteralmente definito il tempo in cui il Paese correva (passando da 3.000 miglia nel 1840 a circa 259.000 miglia nel 1900). Ora il “complesso tecnologico-industriale” evidenziato da Biden e gestito dai nuovi amici di Trump funziona a un livello ancora più intimo, determinando cosa vedono gli elettori. In gioco potrebbe esserci in ultima analisi la questione di chi governerà: il popolo o i nuovi aristocratici americani.
La convergenza tra politiche pro-business e innovazione radicale promette un’accelerazione tecnologica, ma rischia di ampliare ulteriormente disuguaglianze e rafforzare i monopoli. Monopolisti visionari come Elon Musk e Jeff Bezos incarnano un’epoca di innovazione senza precedenti, resa possibile dal Telecommunications Act del neoliberista progressista Bill Clinton del 1996 che ha autorizzato la rivoluzione di Internet e del cyberspazio a essere libera da qualsiasi seria regolamentazione pubblica. Tuttavia, fuori dagli Stati Uniti il settore si trova ora al centro di un dibattito cruciale tra regolamentazione e innovazione, con una crescente pressione da parte di governi e organizzazioni internazionali preoccupati per le implicazioni sociali, economiche e geopolitiche.
Nel complesso è chiaro che la rielezione di Trump rappresenta una svolta critica per l’Occidente. Mentre la sua prima vittoria ha rappresentato una scommessa ad alto rischio verso l’ignoto, questa volta gli americani sapevano perfettamente per cosa stavano votando. Lungi dall’attenuare le tendenze autocratiche per cui è stato ampiamente criticato, ha raddoppiato la posta in gioco. Ora, l’Occidente è perseguitato dallo spettro del “capitalismo autoritario” che viene alimentato da tre profondi cambiamenti economici e politici che stanno rimodellando le economie occidentali: un allontanamento dall’ortodossia del libero mercato (neoliberismo), una stretta sulle libertà democratiche e un aumento della sorveglianza statale. Insieme, questi cambiamenti rappresentano un’economia politica distinta che, se non contenuta, potrebbe inaugurare una nuova era di governance più autoritaria.
Nel suo libro del 1978 “Lo Stato, il potere, il socialismo”, Nicos Poulantzas descrisse l’emergere dello “statalismo autoritario”, una forma di governo che egli distinse dalle dittature di polizia, militari o fasciste, e che tendeva a ridurre i diritti democratici. Criticò il monopolio quasi assoluto dell’esecutivo sulla legislazione e la sua concreta attuazione attraverso “decreti, interpretazioni giudiziarie e adeguamenti del servizio pubblico” che conferiscono potere all’amministrazione, poiché i memorandum hanno la precedenza sulle disposizioni legali. In tali condizioni, la politica statale viene formulata in circoli ristretti, sotto il sigillo della segretezza, in un modo che consente l’interferenza di reti nazionali ed internazionali private. In questo modello, il presidente è il “punto focale di vari centri e reti di potere amministrativo”, che diventano il “partito politico efficace dell’intera borghesia, che agisce sotto l’egemonia del capitale monopolistico”. L’alternanza dei partiti al potere è ridotta a un esercizio di prestigio, aprendo la porta a un vero e proprio “partito-stato dominante”. Questo statalismo autoritario, ha spiegato Poulantzas, non è “né la nuova forma di un autentico stato eccezionale né, di per sé, una forma di transizione sulla strada verso tale stato: rappresenta piuttosto la nuova forma “democratica” della repubblica borghese nell’attuale fase del capitalismo”. Questa forma di governo differisce dal fascismo: quest’ultimo deriva da una “crisi dello Stato”, ha osservato Poulantzas, e “non viene mai stabilito a sangue freddo”. La sua esistenza “presuppone una sconfitta storica della classe operaia e del movimento popolare”. Tuttavia, egli insiste sul fatto che lo statalismo autoritario contiene “elementi sparsi di totalitarismo” e “cristallizza la loro disposizione organica in una struttura permanente parallela allo Stato ufficiale”. Non si può quindi escludere che, dopo una profonda sconfitta dei movimenti sociali, possa svilupparsi “qualsiasi processo di tipo fascista”, non dall’esterno (come il fascismo storico), ma da “una rottura interna allo Stato, secondo linee già tracciate nella sua configurazione attuale”.
Grazie all’alleanza transatlantica emergente tra Trump, l’estrema destra europea e i magnati miliardari dei social media, lo “statalismo autoritario” o il “capitalismo autoritario” è la realtà che ora anche noi europei affrontiamo. È impossibile prevedere esattamente cosa farà Trump e se i suoi alleati di estrema destra in Europa seguiranno le sue orme, riuscendo a cementare e consolidare un ampio blocco sociale reazionario. Ma non dovremmo farci illusioni sulla minaccia che questa alleanza rappresenta. Questo non è lo stesso trumpismo che ha vinto le elezioni nel 2016: è un progetto completamente diverso e più pericoloso. Si apre la prospettiva di un “fascismo della libertà” o di “una “democrazia illiberale” o di una “democrazia autoritaria” o di una nichilista “democrazia oligarchica” (di cui parla Emanuel Todd) o di un “fascioliberismo” (di cui parla Luigi Ferrajoli) che promette di coniugare individualismo (“ciascuno è imprenditore di sé stesso”) e potere sovrano nella cornice di una società nazionale semplificata, conformista, socialmente conservatrice e culturalmente omogenea, riempito di contenuti radicalmente antidemocratici (rispetto ad una democrazia liberale) veicolati attraverso una retorica propagandistica della libertà dalle influenze straniere, dalle censure della correttezza politica, dagli obblighi di solidarietà, dal diritto internazionale, dalle regole e dagli impedimenti che graverebbero su individui e imprese.
In che modo le forze politiche progressiste dovrebbero cercare di contrastare l’ascesa di un nuovo autoritarismo? Una cosa è chiara: alimentare il sentimento anti-Cina non curerà i mali del capitalismo occidentale. Le radici di questi problemi, e quindi le loro soluzioni, possono essere trovate molto più vicine a casa. Anche il semplice tentativo di vietare o censurare le voci della destra autoritaria non funzionerà. Quando le voci in questione includono il presidente degli Stati Uniti e il secondo partito più popolare nel cuore pulsante dell’Europa (l’AFD), metterli a tacere non è un’opzione (anche se ciò non ha impedito a centinaia di politici tedeschi di provarci). Invece, le radici di questi problemi devono essere affrontate alla fonte. In realtà, non sono la Cina o gli immigrati a fregare la gente comune che lavora, ma un sistema economico estrattivo e iniquo. Le disuguaglianze socio-economiche si sono enormemente ampliate, mentre nel frattempo il lavoratore medio nelle economie avanzate ha visto solitamente la propria retribuzione reale diminuire o restare stagnante.
Le fortune contrastanti degli oligarchi mega-ricchi e di tutti gli altri non sono scollegate. Nonostante quanto affermano i nostri leader, il capitalismo nel “mondo sviluppato” è diventato principalmente un motore per ridistribuire la ricchezza verso l’alto, sia dai suoi cittadini che dal resto del mondo. La disuguaglianza alle stelle è anche inestricabilmente legata alla crisi climatica e ambientale. Oltre ad aspirare gran parte della ricchezza mondiale, l’1% più ricco emette tanto inquinamento da carbonio quanto i due terzi più poveri dell’umanità. Pertanto, affrontare la crisi climatica e ridurre la disuguaglianza devono andare di pari passo.
Ma indirizzando le legittime lamentele economiche verso spauracchi e migranti esterni, è la destra autoritaria, non la sinistra progressista, che ha capitalizzato con maggior successo questo sistema corrotto. Se vogliamo affrontare le sfide economiche e ambientali centrali che ci troviamo ad affrontare, questo deve cambiare urgentemente.
Le forze progressiste di sinistra hanno trasformato l’economia politica occidentale in passato e il compito che le attende è di farlo di nuovo. L’obiettivo deve essere quello di affrontare le disuguaglianze, aumentare gli standard di vita e affrontare la crisi ambientale, stando al contempo al fianco dei migranti e di altri gruppi minoritari contro persecuzioni e oppressioni. Ciò comporterà inevitabilmente un ruolo più proattivo per lo Stato. La domanda chiave è: nell’interesse di chi agirà? La lezione della Bidenomics è che concentrarsi principalmente su settori industriali come l’energia rinnovabile e la produzione manifatturiera non funzionerà se non sarà accompagnato da politiche per frenare il potere delle aziende e ridistribuire la ricchezza. Ciò significa sfidare di petto il potere degli interessi acquisiti, non sottomettersi a loro.
Questo progetto deve anche mirare a rafforzare la democrazia e proteggere le libertà civili in un momento in cui entrambe sono sempre più minacciate. Negli ultimi anni i governi di Stati Uniti, Europa e Regno Unito hanno represso il diritto di protesta con una legislazione draconiana (in Italia c’è in ballo l’approvazione del DDL 1660 “sicurezza”). Considerato il terrificante curriculum di Trump, tra cui la richiesta all’esercito di reprimere le proteste pacifiche dei “lunatici della sinistra radicale”, dovremmo aspettarci che l’assalto al diritto di protesta si intensifichi, insieme a una limitazione delle libertà civili in senso più ampio. La protesta pacifica sarà assolutamente fondamentale per resistere alla destra autoritaria in tutto il mondo, ed è esattamente per questo che è probabile che venga soppressa.
Lo spettro del capitalismo oligarchico autoritario sta infestando l’Occidente, è già qui, ed è in realtà piuttosto popolare. Ora bisogna contrastarlo dalle fondamenta. La domanda chiave è: possiamo costruire un “blocco sociale alternativo” in grado di avere ed esprimere il potere necessario per sfidarlo? Al momento, la situazione non sembra promettente: la protesta più forte all’”incoronazione” di Trump è giunta dalla voce calma e sommessa di una vescova episcopale. Possiamo solo sperare che l’arrivo di Trump 2.0 fornisca la sveglia di cui il mondo ha così disperatamente bisogno. Non dobbiamo presumere che il capitale trionferà, ma dobbiamo anche renderci conto che questo è un momento in cui chi ha idee diverse – ecosocialiste, ad esempio – per riorganizzare l’economia, per resuscitare la politica come partecipazione, per ricostruire un più equilibrato rapporto tra uomo/società e natura, deve farsi avanti e lottare per ciò in cui crede. Mentre i partiti populisti etno-nazionalisti e reazionari guadagnano terreno in Occidente, i progressisti di sinistra devono anteporre le priorità sociali e climatiche agli interessi del mercato.
L’autore: Alessandro Scassellati Sforzolini è ricercatore sociale e attivista, collabora con Transform! Italia. Fra i suoi libri Suprematismo bianco (Derive e Approdi).
Nella foto:il presidente Donald Trump e il vice presidente J.D. Vance (foto White House Trump), 20 gennaio 2025