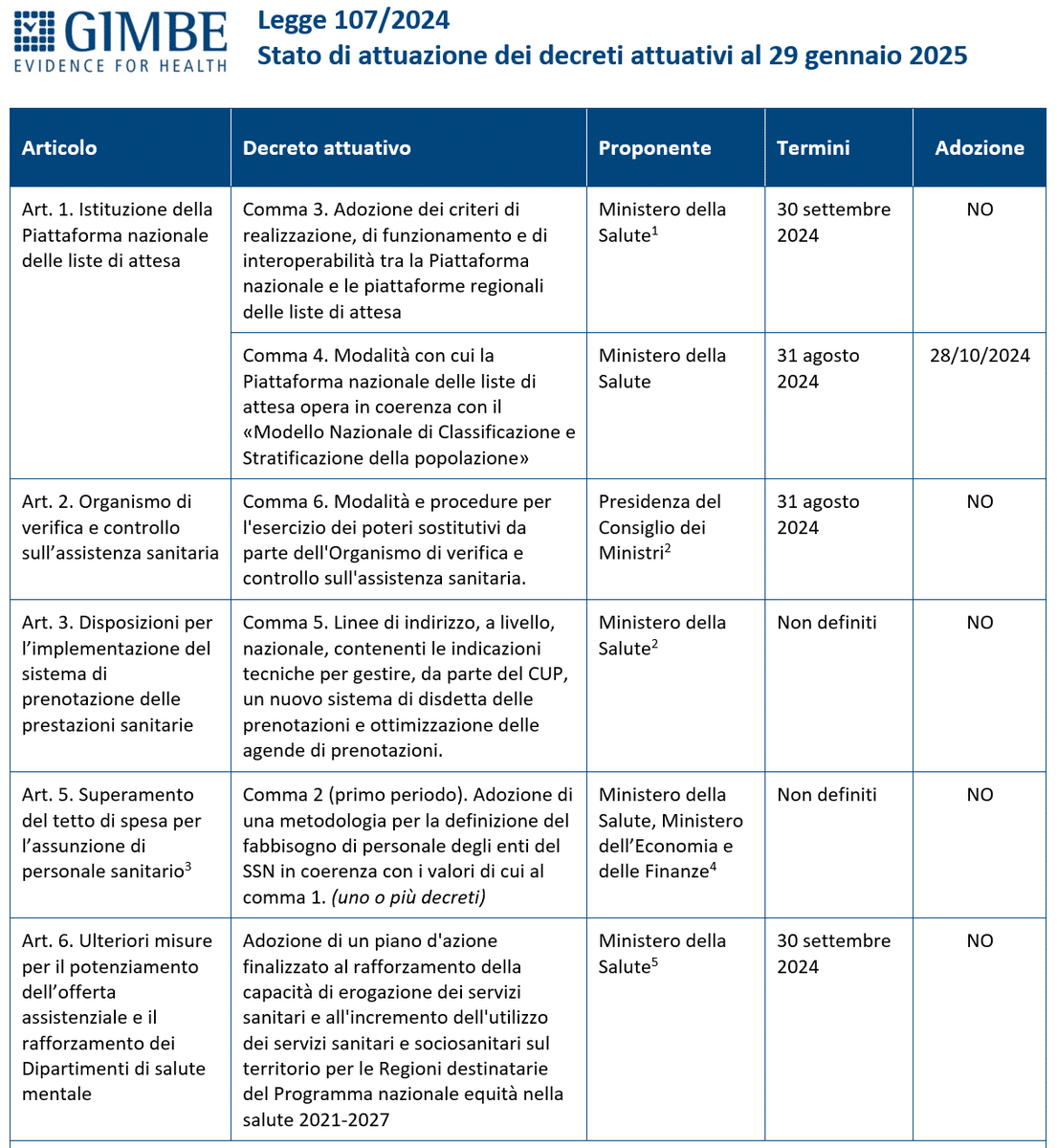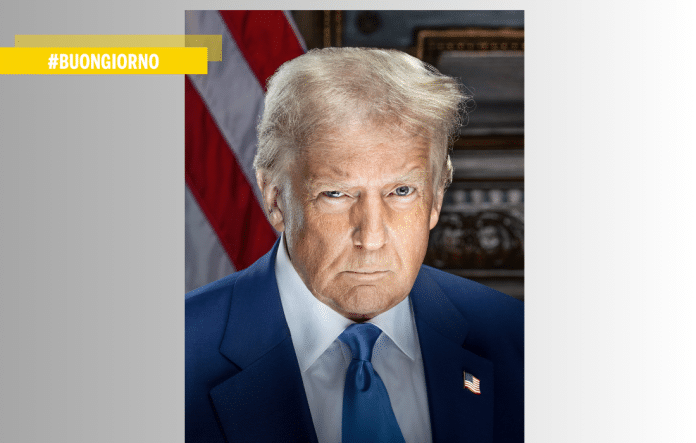L’Europa, con Trump alla Casa Bianca, si prepara a un’economia di guerra. Durante la conferenza annuale dell’Agenzia Europea della Difesa a Bruxelles, l’Alta Rappresentante Kaja Kallas ha definito ragionevole da parte di Trump aspettarsi un maggiore investimento nella difesa. Per far mandare giù questo boccone ha fatto un confronto con la Russia, che investe nella difesa il 9% del proprio Pil.
Sottovalutando un aspetto e cioè che la Russia, ad oggi, è un Paese in guerra.
Ai confini dell’Europa la paura di un’espansione russa si fa sempre più forte, così tanto da fare da pretesto per una proliferazione militare su vasta scala di tutto il continente. La Lituania, ad esempio, ha già accettato la sfida trumpiana, destinando alla difesa tra il 5 e il 6% del Pil. E lituano, non a caso, è il nuovo Commissario per la Sicurezza e la Difesa dell’Ue, Andrius Kubilius, al quale spetterà il compito di armare l’Europa e che giustifica questa imminente economia di guerra proprio con il pretesto del pericolo russo. L’idea dell’esercito europeo, pure a lungo paventata durante la precedente amministrazione, ora lascia il posto al potenziamento di 27 eserciti nazionali, dove ogni paese Ue deve raggiungere, secondo il tycoon, l’obiettivo di destinare alla NATO il 5% del Pil.
Il ruolo delle banche
Sono molti i think tank e i gruppi di pressione mossi da interessi atlantisti ad aver chiesto, già prima dell’elezione di Trump, una revisione della regolamentazione bancaria europea che allentasse un po’ le maglie dei vincoli sugli armamenti. In un dossier di ottobre 2024 che detta l’Agenda 2025 dei rapporti UE-Usa, ad esempio, l’Atlantic Council chiedeva l’istituzione di una banca con meno vincoli che agisca esclusivamente nel settore della difesa tramite obbligazioni, una Banca della Difesa europea al posto della Banca Europea degli Investimenti. Proprio in seguito a pressioni di questo tipo ad aprile scorso la Bei ha annunciato di aver modificato la policy che impediva di concedere prestiti alle aziende che operano nella difesa in cui la vendita di equipaggiamento militare rappresentava il 50% o più dei loro ricavi. «Il Gruppo BEI si conformerà quindi alla pratica delle istituzioni finanziarie pubbliche limitando i propri finanziamenti alle attrezzature e infrastrutture funzionali a esigenze difensive, militari o di polizia, oltre che civili, come ad esempio la ricognizione, la sorveglianza, la protezione e il controllo dello spettro, la decontaminazione, le attività di ricerca e sviluppo, l’equipaggiamento, la mobilità militare, il controllo delle frontiere, la tutela di altre infrastrutture critiche e i droni».
A queste regole si aggiunge l’apertura di linee di credito alle PMI per i progetti su difesa e sicurezza. Si è trattato di una decisione approvata da 14 dei 27 Paesi Ue, i più ricchi, e che ha causato una levata di scudi da parte di società che lavorano nel campo della finanza etica, attivisti e Ong che a febbraio 2024 mettevano in guardia sui rischi di una decisione del genere in una lettera aperta alla presidente della Banca Europea, Nadia Calviño. Counter Balance, prima firmataria della lettera, chiedeva di resistere alle pressioni dei produttori di armi e di non investire gli 8 miliardi di euro destinati dalla Strategic European Security Initiative all’innovazione dei prodotti a duplice uso (militari e civili) ma di utilizzarli piuttosto a favore della pace con progetti di ricostruzione o di contrasto al cambiamento climatico. «Tenete la Banca europea fuori dal settore della difesa”, perché, recita “la riduzione dei rischi del settore della difesa rischia di alimentare i conflitti con la proliferazione della produzione di armi a livello globale». Un appello inascoltato.
Parola d’ordine: flessibilità
E se la decisione della Banca Europa dovesse fare da apripista all’allentamento delle regole delle banche nazionali riguardo il mercato della difesa? Sarebbe solo un pro-forma, al momento che i più grandi istituti di credito europei concedono da anni investimenti massicci alle aziende produttrici di armi. Danske Bank, la principale banca danese, ha annunciato lo scorso ottobre che investirà in armi nucleari, giustificando futuri investimenti nel settore della difesa con «un maggiore interesse nei confronti della sicurezza e un rinnovato quadro geopolitico». Secondo l’ultimo report dell’organizzazione per la pace olandese PAX in collaborazione con ICAN (the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), “Don’t Bank the Bomb” del 2022, anche la tedesca Deutsche Bank, le francesi BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, le italiane Banco BPM, Banca popolare di Sondrio e Unicredit finanziano frequentemente armi nucleari limitandosi a definire nelle loro policy la limitazione alle «armi soggette al trattato di non proliferazione». Secondo PAX, però, «la maggior parte dei finanziamenti delle società produttrici di armi nucleari è elencata per “scopi aziendali generali. Si tratta di fondi non stanziati, pertanto non c’è modo di garantire che non facilitino la produzione di armi nucleari» una volta investiti nelle aziende produttrici. Come dire che l’investimento non entra nel merito degli scopi per i quali l’impresa intende utilizzarlo.
Lacrime e sangue per le armi
Da dove proverranno i finanziamenti europei alla difesa comune? Molto probabilmente dal fondo di coesione, come hanno annunciato alcuni funzionari Ue al Financial Times l’11 novembre. «Nelle prossime settimane le capitali degli Stati membri saranno informate che d’ora in poi avranno maggiore flessibilità, in base alle norme, nell’allocazione dei fondi di coesione per sostenere le loro industrie della difesa e i progetti di mobilità militare, come il rafforzamento di strade e ponti per consentire il passaggio sicuro dei carri armati». I fondi di coesione sono effettivamente quelli meno usati dai Paesi europei, e questo, secondo il Financial Times è un buon motivo per utilizzarli in armi: in realtà sono nati per finanziare la transizione ecologica e digitale e per mantenere stabile il gap tra gli stati d’Europa più ricchi e quelli più poveri. Il Commissario per la Difesa Kubilius confermava questa possibilità poche settimane dopo: «I fondi di coesione vengono utilizzati per lo sviluppo dell’industria nelle regioni povere, quindi non separerei troppo l’industria della difesa, che crea posti di lavoro e competitività, dagli obiettivi della politica di coesione». Il concetto comunque era già stato espresso nel rapporto di Mario Draghi sulla competitività europea dello scorso settembre che molto spazio dedica alla difesa come settore strategico per l’economia. L’urgenza è quella di diminuire l’importazione di armi e approvvigionamenti dagli Usa, che ammontano al 63% della spesa totale e incentivare sia le grandi imprese che le PMI che producono armi all’interno dei confini europei. La strategia, pertanto, è quella di deregolamentare le banche rispetto alle loro policy di responsabilità sociale, in modo che le imprese che producono armi possano godere senza intoppi di finanziamenti sia dall’Europa che dagli istituti di credito nazionali. I criteri di esclusione rispetto alle armi “limitano notevolmente la possibilità del settore della difesa di beneficiare pienamente degli strumenti finanziari dell’UE e dei finanziamenti privati”, si legge. “Inoltre gli scarsi investimenti produttivi degli elevati risparmi delle famiglie europee minano tra gli altri anche la competitività dell’industria della difesa”, sostiene il rapporto Draghi. Parole che viaggiano parallele a quelle del segretario generale NATO Mark Rutte che auspica un sacrificio dei popoli europei su pensioni e sanità per convertire lo stato sociale in produzione di armi. Eppure pare essere un sacrificio al quale i cittadini d’Europa sono disposti: secondo un recente sondaggio di Eurobarometro, «più di tre quarti degli europei (77%) sono favorevoli a una politica di sicurezza e di difesa comune tra i paesi dell’UE, mentre oltre sette cittadini dell’UE su dieci (71%) concordano sulla necessità dell’UE di rafforzare la sua capacità di produrre attrezzature militari». L’ultimo passo di un’economia di guerra che strizza l’occhio alla politica di Donald Trump sarà infine quello di rinunciare alle politiche di contrasto al cambiamento climatico in favore degli investimenti per la difesa, considerata una priorità a breve termine. Eppure a dicembre la Direzione generale per l’energia della Commissione europea e l’Agenzia per la Difesa Europea hanno firmato un accordo per migliorare la sostenibilità energetica proprio nel settore della difesa e della sicurezza, ad oggi colpevole del 5,5% delle emissioni globali di CO2. Strano che non sia venuto in mente che basterebbe un disinvestimento per abbattere le emissioni nel settore, non il contrario, trattandosi di paesi, quelli europei, fortunatamente non in guerra.
Angela Galloro è giornalista e collaboratrice di Left
Foto: da Adobestock Bandiera europea con proiettili di Alexey Novikov