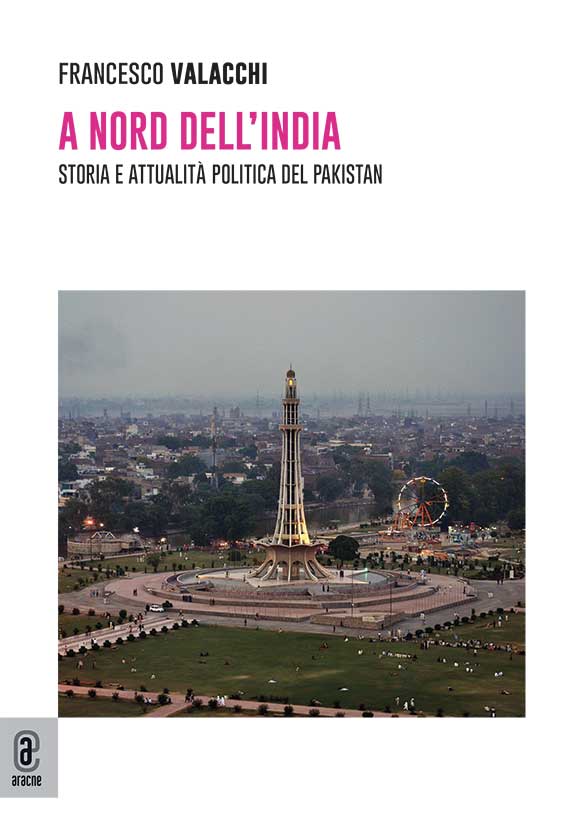Il 14 dicembre manifestazione nazionale a Roma contro il ddl sicurezza in discussione al Senato. Oltre 200 le adesioni alla Rete Nazionale No DDL Sicurezza – A Pieno Regime che ha promosso la manifestazione (ore 14 corteo da piazzale del Verano fino a piazza del Popolo). Sugli effetti del provvedimento, ecco l’articolo di Livio Pepino, uscito nel numero di Left/11/2024 Stato pericolante.
Siamo di fronte all’ennesimo “pacchetto sicurezza”? Sì, anche. Ma non solo. C’è qualcosa di più. Se diventerà legge, infatti, questo provvedimento produrrà cambiamenti profondi sull’intero assetto istituzionale e nella stessa vita delle persone, di ciascuno di noi.
Manifestare diventerà un lusso o, meglio, un rischio.
Le manifestazioni, infatti, saranno oggetto di interventi repressivi tali da renderle impossibili o, comunque, da disincentivarle in modo massiccio. Manifestare implica, anzitutto, scendere in piazza. Ebbene, la previsione come reato del blocco stradale «realizzato con la mera interposizione del corpo» e la sua punizione con la reclusione da sei mesi a due anni «quando il fatto è commesso da più persone riunite» (cioè sempre, considerato che un blocco stradale o ferroviario fatto da una sola persona è poco più che un’ipotesi di scuola…) incide direttamente e immediatamente sulla possibilità di scendere in strada. Detto in parole povere, saranno criminalizzati, in caso di manifestazione spontanea e priva di preavviso (ovvero vietata dal questore), anche i dimostranti pacifici che stazionano in gruppo in strada, di fronte ai cancelli di una fabbrica o all’ingresso di una scuola. Sarà cioè punito il semplice assembramento (consentito solo con preavviso e in assenza di indicazioni contrarie dell’autorità di polizia). C’è, sul punto, una cosa che merita segnalare. Il blocco stradale è stato introdotto, con una descrizione onnicomprensiva, nel 1948, ma nel 1999 è stato depenalizzato e trasformato in semplice illecito amministrativo (pur punito con una sanzione pecuniaria non irrisoria). Quasi vent’anni dopo, con il primo decreto Salvini, è iniziato un percorso a ritroso: il blocco stradale è ridiventato reato ma si è previsto che restasse un illecito amministrativo nel caso di ostruzione stradale con la sola presenza fisica. L’attuale disegno di legge riporta alla situazione del 1948, aggravata dall’espressa previsione dell’idoneità ad integrare il reato dell’ostruzione stradale con il solo corpo. Ma non c’è solo la criminalizzazione del blocco stradale, con tutto quel che comporta. Un ulteriore insieme di norme attribuisce alle manifestazioni di piazza in quanto tali una connotazione negativa, prevedendo specifiche aggravanti per i reati di danneggiamento, resistenza o violenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, se commessi al loro interno (arrivando al paradosso di prevedere una pena fino a vent’anni di reclusione per la resistenza o violenza a pubblico ufficiale commessa «al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica»: sic!). Queste previsioni ribaltano addirittura, in termini di maggior repressione, la disciplina del codice Rocco, il cui articolo 62 n. 3 prevedeva (e prevede, non essendo mai stato abrogato) come attenuante per qualunque tipo di reato «l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto» (pur con il limite che «non si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’autorità»).
Anche la resistenza passiva diventerà un reato.
La cosa, già implicita nel blocco stradale realizzato con il solo corpo, è formalizzata in modo esplicito dal nuovo articolo 415 bis del codice penale, che introduce il delitto di rivolta in carcere (sanzionato, per chi si limita a partecipare, con la pena della reclusione da uno a cinque anni), consistente in «atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti», con l’esplicita precisazione che «costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza». In concreto, dunque, se sarà approvato il disegno di legge, incorreranno nel reato di “rivolta”, per esempio, i detenuti che, in gruppo (anche piccolo) e disattendendo gli ordini, rifiuteranno, per protesta, di rientrare in cella dall’aria, o di assumere il cibo, o di recarsi alle docce, impedendo così al personale penitenziario di chiudere le celle, di liberare la mensa etc. La previsione del delitto di resistenza passiva con riferimento a una categoria di soggetti (i detenuti) considerati devianti e marginali, oltre ad essere grave in sé, introduce nel sistema un precedente dotato di evidente capacità espansiva, che potrebbe ripetere la (triste) esperienza del Daspo, introdotto inizialmente (nell’ormai lontano 1989) per una categoria marginale come quella dei tifosi violenti e diventato negli anni uno strumento ordinario di governo del territorio. Togliamo il condizionale: accade già nello stesso disegno di legge che estende la disciplina, con una lieve riduzione di pena, a tutti i luoghi di accoglienza per migranti (e, dunque, non solo i Cpr, ma anche i Cara e gli hotspot).
Verrà pesantemente limitata la possibilità di azione dei movimenti attivi nei settori più delicati del conflitto sociale.
Tutto questo con interventi analoghi a quelli che negli ultimi anni hanno criminalizzato e frustrato nelle possibilità di azione le Ong impegnate nel salvataggio dei migranti in mare. Il riferimento è, in particolare, alla norma che estende il delitto di occupazione di immobili a chi, «fuori dei casi di concorso nel reato, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile» e a quella che prevede un aggravamento della pena per il delitto di “istigazione a disobbedire alle leggi”«se il fatto è commesso a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute». L’attacco ai movimenti per la casa e quelli di sostegno alle persone detenute non potrebbe essere più diretto ed esplicito.
Il carcere scoppierà.
Questo sarà inevitabile in presenza di 14 nuovi reati e di altrettante nuove aggravanti, alcune delle quali di grande rilievo. E gli interventi repressivi sostituiranno sempre di più quelli sociali. Lo dimostra – quasi come un manifesto politico – l’introduzione nel codice penale di una norma (l’articolo 634 bis) in forza della quale «chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui … è punito con la reclusione da due a sette anni», cioè esattamente la pena prevista per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche (sic!). Superfluo dire che già ora l’occupazione di case è un reato, punito con la reclusione fino a due anni e con una multa. Dunque la norma non è solo un presidio a tutela penale della proprietà privata (già ampiamente protetta); è, ancora di più, la sintesi della risposta istituzionale all’emergenza abitativa. A tale emergenza (50mila famiglie occupanti case popolari, 100mila sentenze di sfratto con richiesta di esecuzione e 40mila sentenze di sfratto emesse ogni anno) si risponde, infatti, non – come sarebbe lecito attendersi – con un “piano casa” ma con un surplus di repressione per chi cerca di risolvere il problema, sia pure indebitamente, occupando un’abitazione. Non potrebbe esserci dimostrazione più plastica, anche in termini simbolici, del passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale e del governo repressivo della povertà (a cui si aggiungono altri tasselli come il Daspo ferroviario, la trasformazione da obbligatorio in facoltativo del rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di un bambino inferiore all’anno, il divieto di vendita della Sim telefonica agli stranieri privi di permesso di soggiorno etc.).
Il rapporto tra le polizie e i cittadini sarà sempre più improntato al principio di autorità.
Si assisterà ad una definitiva chiusura della stagione (pur contraddittoria) in cui si è tentato un processo di democratizzazione (una stagione che ha visto passaggi importanti come l’introduzione della scriminante della reazione all’atto arbitrario del pubblico ufficiale, la dichiarazione di incostituzionalità della necessaria autorizzazione del ministro per procedere nei confronti di operatori della polizia per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, la sindacalizzazione e smilitarizzazione del corpo, l’abrogazione del delitto di oltraggio etc.). Questo percorso subirà ora, se sarà approvato il disegno di legge, una drastica inversione che ripristinerà, anche qui, una situazione simile a quella degli anni Cinquanta (un’epoca in cui – è bene ricordarlo – le politiche di ordine pubblico lasciarono sulle strade e nelle piazze del Paese oltre 100 morti: 157, tra il 1946 e il 1977, di cui 14 tra le forze di polizia e 143 tra i dimostranti). Ciò avverrà grazie alle disposizioni che prevedono, tra l’altro: la già ricordata tutela privilegiata degli operatori di polizia nel corso di manifestazioni; un’ulteriore tutela sul piano legale consistente nella possibilità di fruire, se indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, dell’anticipazione da parte dello Stato di una somma di 10mila euro per ogni fase di giudizio per spese di difesa (con possibilità di rivalsa nel solo caso di accertata responsabilità a titolo di dolo); l’autorizzazione agli appartenenti alle varie forze di polizia a portare, senza licenza, un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio; una maggior libertà di azione indotta dalla possibilità di agire, nei confronti di associazioni terroristiche (ma anche qui con evidente potenzialità espansiva), non solo a mezzo di “infiltrati” ma anche a mezzo di “agenti provocatori” e dalla dotazione, per i servizi di ordine pubblico (e non solo), di dispositivi di videosorveglianza idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento» (e, dunque, una registrazione di immagini continua e non limitata ad episodi “critici”).
No. Non è solo l’ennesimo (pur grave) pacchetto sicurezza!
L’autore: Livio Pepino, magistrato fino al 2010, già segretario e presidente di Magistratura democratica e condirettore della rivista Questione Giustizia, dirige le Edizioni del gruppo Abele. Tra i suoi libri: Forti con i deboli (Rizzoli, 2012) e Come si reprime un movimento: il caso Tav (Intra Moenia, 2014).
Questo articolo è stato pubblicato nel numero di Left di novembre 2024 Stato pericolante, dedicato al “pacchetto sicurezza” del governo Meloni. Con interventi di giuristi, attivisti e parlamentari. Per leggere qui