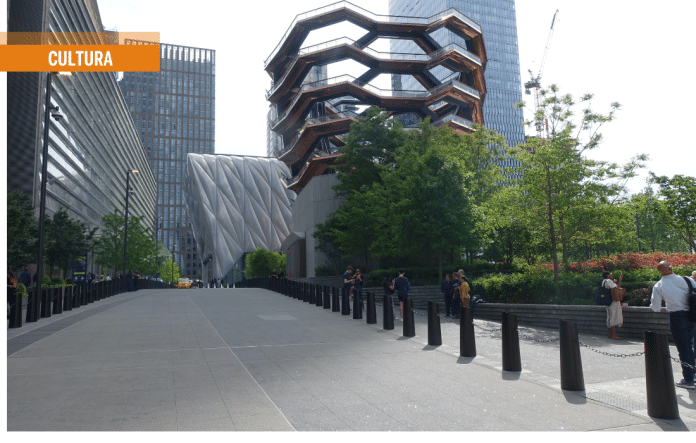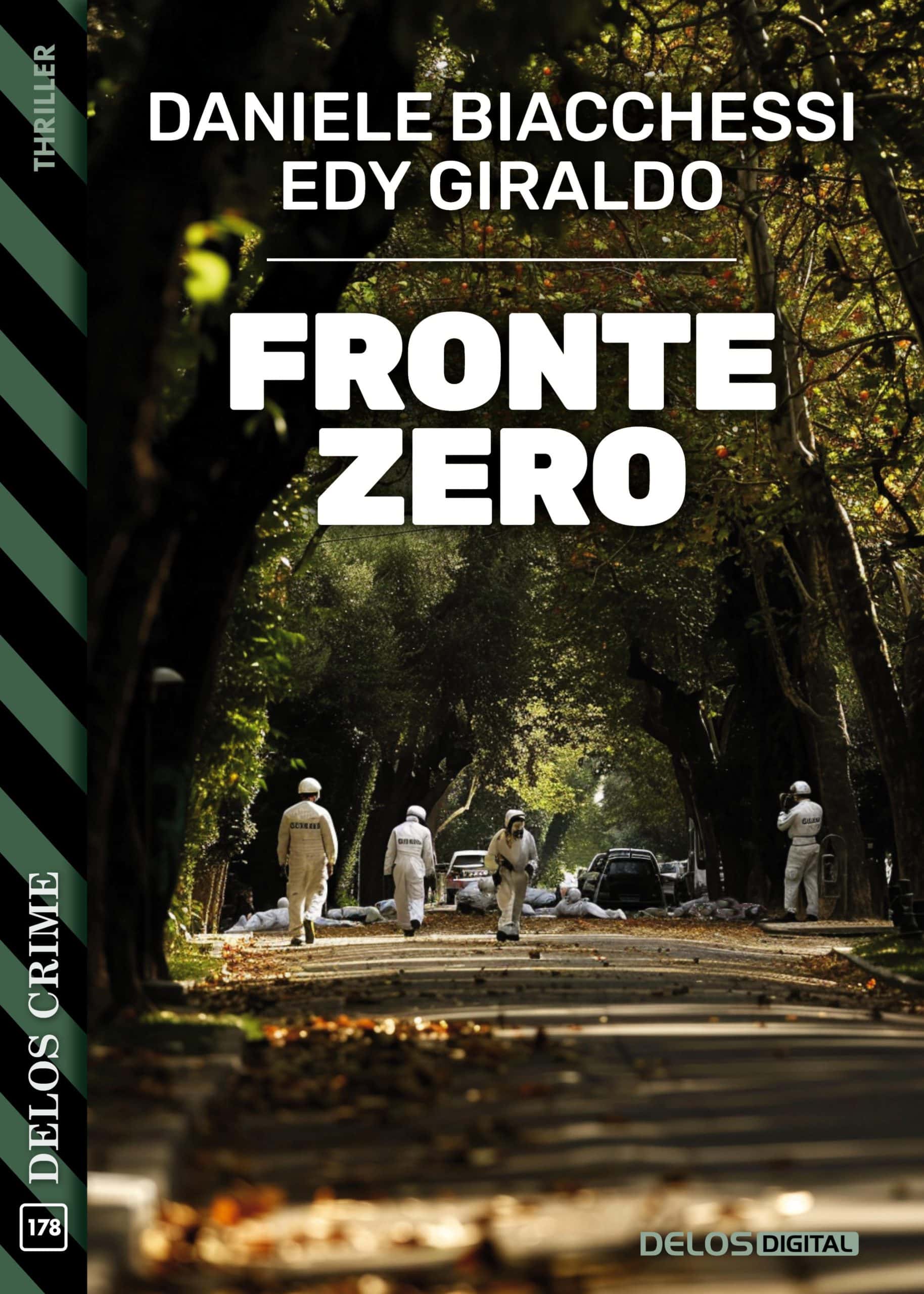Daniele Biacchessi, giornalista d’inchiesta, scrittore, attualmente direttore editoriale di Giornale Radio e responsabile della collana editoriale “Contastorie” della casaeditrice Jaca Book, aggiunge alla sua intensa produzione letteraria, teatrale e cinematografica il suo primo libro noir, dal titolo Fronte Zero (Delos Digital) scritto insieme a Edy Giraldi, scrittrice ed esperta di romanzi gialli. La lunga carriera di Biacchessi comincia quando, giovanissimo, indaga sullo scandalo Seveso e sulla fuoriuscita dalla fabbrica di diossina Icmesa che contaminò una vasta area di territori e le persone che vi abitavano. Continua con passione la sua attivitàdescrivendo personaggi dal forte impegno civile e morale nella lotta contro la mafia, come Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Piero Borsellino, o contro il terrorismo anche per tenere viva la memoria di fatti destinati, per il trascorrere del tempo e le tante difficoltà a portare avanti le indagini, ad essere dimenticati come l’assassinio dei due diciottenni Iaio e Fausto, i cui veri nomi erano Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli, a Milano nel 1978, i cui mandanti sono rimasti sconosciuti oppure per tenere in vita la Resistenza e i troppi depistaggi che hanno impedito al nostro Paese di prendere consapevolezza degli anni della dittatura fascista. Il giornalista ha anche esplorato le dinamiche che negli Stati Uniti d’America hanno portato al movimento Black lives Matter, analizzandone le radici storiche ivi compresa la cultura di personaggi come Woody Guthrie, cantore della musica popolare. Libri importanti,
da consultare per comprendere le radici del mondo di oggi. Fronte zero è un breve, sorprendente libro la cui scrittura scorrevole suddivisa insintetici capitoli dai titoli bellissimi, come rapidi flash cinematografici, partendo da un passato che sembra ostinatamente che non voglia passare, rappresentato da unpiccolissimo gruppo di irriducibili brigatisti arriva alla situazione di oggi, in cui la violenza sembra ormai la strada sulla quale dobbiamo incamminarci e che tutti dovremmo accettare. In vista della presentazione del libro il 20 dicembre a Montefiascone abbiamo rivolto alcune domande all’autore.
Due coppie di fratelli progettano l’assassinio di un diplomatico americano apparendoci come irriducibili brigatisti. Biacchessi è un caso che il progetto solleciti qualche ricordo con il rapimento del generale James Lee Dozier, nel 1981, a Verona, che fu in effetti l’atto violento che segnò l’inizio della fine e il fallimento del Brigate Rosse?
No, non è un caso. Mi sono chiesto cosa potrebbe accadere se un gruppo di terroristi colpisse una alta autorità degli Stati Uniti in Italia? Gli investigatori italiani sarebbero liberi di indagare oppure gli apparati dello Stato americani sovrasterebbero la sovranità del nostro Paese? Nel caso Dozier si vide chiaramente che gli americani, nei fatti, diressero le operazioni e altri eseguirono la liberazione del generale: i Nocs, le teste di cuoio. Dozier era sottocapo di stato maggiore addetto alla logistica del Comando delle forze terrestri della Nato nell’Europa meridionale. Quindi un ruolo apicale. Ai responsabili del rapimento vennero inflitte torture pesantissime. La squadra di poliziotti si faceva chiamare “Quelli dell’Ave Maria”: il capo era chiamato professor De Tormentis, soprannome che gli aveva dato Umberto Improta, dirigente dell’Ucigos (Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali) prendendo spunto dalla Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni. Il vero nome del professor De Tormentis venne svelato solo anni più tardi. Nel mio romanzo, quelli del “Fronte Zero” non hanno un’organizzazione che li copre, agiscono da soli. Non rapiscono, ma uccidono. Non chiedono riscatti. Ma i meccanismi del potere che si innestano dopo l’attentato sono quelli di un Paese a sovranità limitata, anzi controllata.
Le protagoniste al femminile, sia le donne del gruppo di brigatisti sia la moglie del diplomatico americano sembrano percepire la verità di quello che sta succedendo. Ce lo può spiegare?
I presagi. Le terroriste e la moglie dell’ambasciatore sentono che qualcosa è andato storto ben prima dello svolgimento dei fatti che le coinvolgono. Sono ovviamente punti di vista opposti, però simmetrici. Capiscono di essere rimaste imprigionate da un identico meccanismo di poteri più forti di loro.
Il poliziotto incaricato delle indagini si trova stretto dalle imposizioni dei Servizi americani mentre le cariche istituzionali, attente al compromesso, stanno bene attente a non urtare l’equilibrio dei rapporti internazionali. E’ possibile per il commissario Martini salvare la sua formazione riconducibile ai principi della Costituzione e all’esperienza di magistrati e colleghi coraggiosi da lui conosciuti?
Daniele Martini è un commissario all’antica, ligio al dovere, fedele alla Costituzione, che pensa con la propria testa. Non è uno dei soliti commissari guasconi e donnaioli che vengono proposti dal mercato del noir. E’ uno che crede in ideali impossibili da realizzare e viene sconfitto. In “Fronte Zero” non c’è uno Stato buono e onesto e un gruppo di macellai violenti e cattivi. Qui ci sono sfumature di grigi e di altri colori tra il bianco e nero. E’ un giallo politico, un atto di denuncia.
Il libro è un susseguirsi di fatti violenti che – come avviene nella realtà attuale- una volta avvenuti, vengono accettati come “normale realtà degli esseri umani”. Dove trovare il modo per reagire, rifiutare, ritrovare gli anticorpi verso una violenza di fronte alla quale sembra ci sia solo la possibilità di soccombere, come di fronte ad un attacco di una malattia pestilenziale nel Medioevo?
In Italia, il passato non passa mai perché non si sono comprese fino in fondo le origini da cui nasce la violenza politica. E’ l’unico paese europeo dove sono state eseguite contro civili stragi con matrice di destra eversiva sui treni, nelle banche, nelle piazze, nelle stazioni: piazza Fontana e Questura a Milano, piazza della Loggia a Brescia, treno Italicus, stazione di Bologna. E l’unico luogo in Europa dove decine di sigle riconducibili alla lotta armata di sinistra hanno eseguito 131 omicidi, oltre 2000 ferimenti contro magistrati, poliziotti, carabinieri, generali, guardie carcerarie, giornalisti, dirigenti di imprese, e politici come Aldo Moro. L’Italia è dunque un paese dove si sono sperimentate operazioni coperte, tentativi di colpi di Stato. Molte cose sono accadute perché non si sono comprese le ragioni della malapianta della violenza non solo quella dei terroristi che hanno creduto di cambiare lo stato delle cose con le armi, ma anche la violenza di uno Stato che poteva arrestarli, ma li ha lasciati fare fino poi a sopprimerli con ogni mezzo quando non erano più funzionali al sistema.
Quanto la paura del potere come possibilità di infettarsi ha allontanato generazioni di cittadini e cittadine nel prendere più attivamente parte alla vita politica? Ritiene sia stato un errore? La cultura come ricerca continua è politica?
Si, la cultura, la letteratura, l’arte nel senso più alto della sua potenza, restano le uniche vie possibili per il miglioramento umano e per l’elevazione collettiva dell’intera società. C’è ancora molto da fare. Ci vorrebbero meno giallisti civili, scrittori, attori,registi, giornalisti civili, e più panettieri civili, ingegneri, operai, impiegati, pensionati civili. Insomma ognuno dovrebbe mettere in campo un’inversione di rotta, un moto di ribellione e disobbedienza civile. Se le cose vanno in un certo modo è anche colpa nostra.
L’Intelligenza artificiale consente al commissario, attraverso l’analisi e il confronto letterale dei testi molto vecchi di brigatisti, di trovare il bandolo della matassa. Come se lei volesse evidenziare che anche la mancata evoluzione de linguaggio, che si trova a ripetere parole e rituali, sia essa stessa violenza?
I documenti di rivendicazione dei terroristi sanno di vecchio, obsoleto, il linguaggio scelto è burocratico. Devono giustificare un atto tremendo come la morte, allora al loro obiettivo calzano la maschera della sua funzione, così l’uomo che colpiscono diventa un magistrato, un poliziotto, un carabiniere, un giornalista, o come in questo caso un ambasciatore, senza la sua storia, la sua famiglia, i suoi pensieri, le speranze, le delusioni. Però qualcuno del “Fronte Zero” inizia a porsi il problema della disumanizzazione, anche se è ormai stritolato nel suo stesso nichilismo. Il libro è uno strumento per comprendere quelli che erroneamente chiamiamo con superficialità “anni di piombo”.
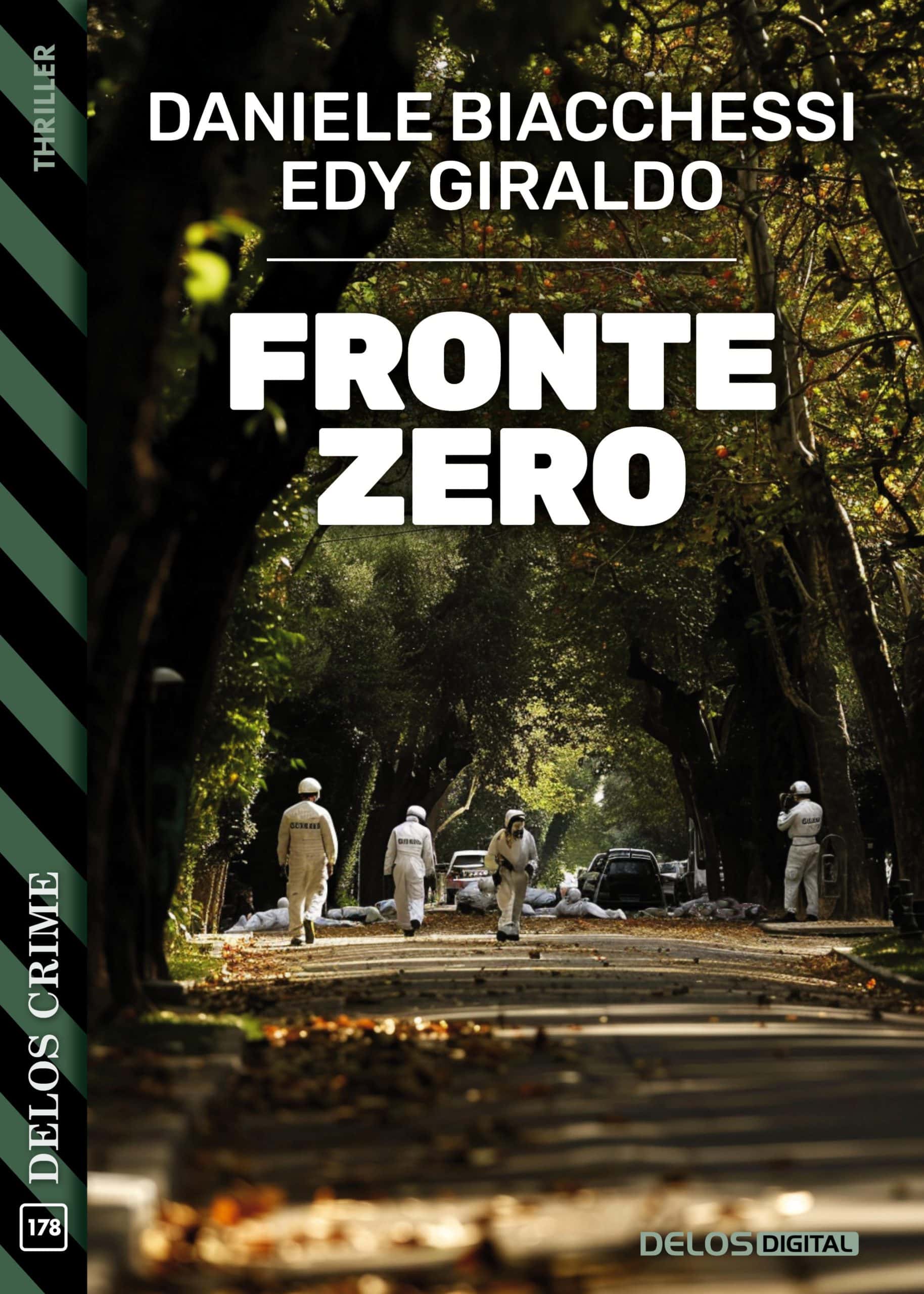
L’autrice: Già dirigente Rai, Sonia Marzetti è coordinatrice del Gruppo Storia e collaboratrice di Left
In foto Il cupolone visto da Villa Pamphili. Foto di Notafly – self-made Own photo August 2007 Ricoh Caplio 5, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2861145