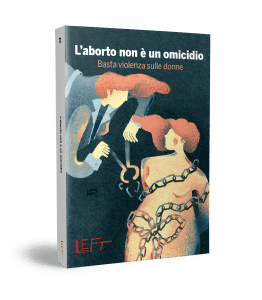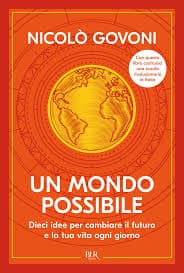Era il 2 ottobre 2009, quando, da Wellington (Nuova Zelanda), partiva la prima marcia mondiale per la pace e la nonviolenza. Il giorno scelto era non a caso il 2 ottobre, perché già giornata internazionale della nonviolenza, promossa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 giugno 2007. Tale data era stata scelta dall’Onu visto che era il giorno in cui era nato Mohāndās Karamchand Gāndhī. La marcia nacque dalla volontà di Rafael de la Rubia (fondatore dell’associazione internazionale umanista Mondo senza guerre e senza violenza) di creare unione tra le varie persone durante il passaggio di una delegazione internazionale di marcianti con l’intento di conoscere quanto sia fondamentale il disarmo nucleare e denunciare la violenza in tutte le sue forme esistente tra gli esseri umani. Il gruppo di marciatori percorse tutti i continenti per arrivare il 2 gennaio 2010 a Punta de Vacas (Argentina). La seconda marcia si svolse nell’ottobre-novembre 2019. Sull’onda della Marcia mondiale il 15 settembre 2021 iniziò la prima marcia latinoamericana per la nonviolenza (multietnica e multiculturale). Nonostante ci fossero ancora restrizioni a causa della pandemia, furono organizzati diversi eventi in presenza, anche in scuole, in tutta la regione latinoamericana.
Quest’anno, il 2 ottobre 2024, è partita da San José di Costa Rica, Paese che nel 1948 abolì l’esercito e la marina militare (il Paese non aveva aviazione), la terza marcia mondiale per la pace e la nonviolenza dove tornerà, dopo aver fatto il giro del pianeta, il 5 gennaio del 2025. In Italia la marcia ha toccato, dal 16 al 30 novembre, una trentina di città secondo il calendario trovabile qui ). Il 22 novembre è arrivata a Firenze, dove dalle ore 16.30 è stata accolta da decine di persone in piazza SS. Annunziata. Al termine della cerimonia e degli interventi, le persone si sono unite al centro della piazza per fare il simbolo umano della pace e della nonviolenza. Tra i marciatori arrivati a Firenze c’erano anche Rafael de la Rubia e Martine Sicard. Quest’ultima autrice anche del libro, illustrato da Luis Alzueta Martínez, intitolato Un cammino verso la pace e la nonviolenza, edito da Multimage la casa editrice dei diritti umani. Siamo riusciti a raggiungere proprio Martine Sicard, che fa parte anche del Coordinamento mondiale di Mondo senza guerre e senza violenza.
Qual è stato il suo apporto per la nascita della prima marcia mondiale per la pace e la nonviolenza?
Mi trovavo insieme a Rafael de la Rubia nell’associazione Mondo senza guerre e senza violenza, e volendo fare qualcosa in grado di coinvolgere più persone possibili per cambiare questo mondo, già allora pieno di violenze, guerre e con la minaccia atomica, decidemmo di lanciare la marcia insieme. Infatti attraversando tutto il globo avremmo potuto ascoltare e farci ascoltare da moltissime persone, comunità, associazioni, che ci avrebbero potuto aiutare nei nostri obbiettivi creando una rete mondiale. Grazie a questa avremmo potuto sensibilizzare e spingere i governi dei vari Paesi ad attuare gli obbiettivi che ci eravamo preposti. E tutt’oggi andiamo avanti in quella direzione. Ci tengo a sottolineare comunque che l’ideatore della marcia è stato Rafael de la Rubia, che io ho appoggiato e sostenuto fin da subito.
Quali sono gli obbiettivi della terza marcia partita il 2 ottobre scorso dal Costa Rica?
Innanzitutto bisogna cercare di essere ingenui e di fare in modo che il maggior numero di persone al mondo manifestino la propria volontà di voler vivere in pace, ma questa dimostrazione non è sufficiente, perché quello che per noi è importante è approfondire dentro ognuno di noi cosa sia la nonviolenza. In merito agli obbiettivi di questa Marcia, li abbiamo elencati, dal primo all’ultimo. Sono questi:
Vale a dire?
● Chiedere ai nostri governi di firmare il Trattato per la proibizione delle armi nucleari, eliminando così la possibilità di una catastrofe planetaria. Solo 94 Paesi su 195 l’hanno firmato, e tra quelli che non lo hanno firmato vi sono i Paesi della Nato, tra cui l’Italia, e quelli che detengono armi nucleari.
● Chiedere la rifondazione delle Nazioni Unite, garantendo la partecipazione della società civile, democratizzando il Consiglio di Sicurezza per trasformarlo in un autentico Consiglio mondiale della pace e istituendo un Consiglio di sicurezza ambientale ed economico.
● Chiedere l’inclusione della Carta della Terra nell'”Agenda Internazionale” degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Ods) al fine di affrontare efficacemente il cambiamento climatico e gli altri fattori di insostenibilità ambientale.
● Promuovere la nonviolenza attiva in tutti gli ambiti, in particolare nell’educazione, affinché diventi una reale forza trasformatrice del mondo.
● Rivendicare il diritto all’obiezione di coscienza come rifiuto di collaborare in qualsiasi modo alla violenza.
● Incoraggiare la proclamazione a tutti i livelli di un impegno etico, in cui è pubblicamente stabilito di non usare mai le conoscenze ricevute o l’apprendimento futuro per far violenza agli esseri umani bensì per liberarli da questa.
● Progettare un futuro in cui ogni vita umana abbia valore e ciascuno sia in armonia con sé stesso, con gli altri esseri umani e con la natura, in un mondo libero da guerre e violenza.
 Lei è coautrice del libro intitolato Un cammino verso la pace e la nonviolenza, quanto è importante partire dalla cultura della nonviolenza e dall’educazione anche nelle scuole specie tra i più piccoli, per trasformare il presente, dominato dalla violenza, in un futuro di nonviolenza?
Lei è coautrice del libro intitolato Un cammino verso la pace e la nonviolenza, quanto è importante partire dalla cultura della nonviolenza e dall’educazione anche nelle scuole specie tra i più piccoli, per trasformare il presente, dominato dalla violenza, in un futuro di nonviolenza?
Si tratta di un libro che narra brevemente la storia e le idee della nonviolenza, illustrato dal bravissimo fumettista Luis Alzueta Martínez, il che lo rende una lettura agevole per tutte le età. È uscito in spagnolo, poi in italiano, e ora stiamo cercando di farlo uscire in francese. Noi crediamo molto nell’educazione, per questo collaboriamo con le scuole, soprattutto le università, non solo per mettere in moto dei seminari e degli incontri sulla nonviolenza, ma anche per far dichiarare l’impegno etico, citato prima, perché rappresenta una guida di principi e valori per sensibilizzare sulla pace, la nonviolenza e i diritti umani.
Molti Stati dell’Unione Europea, compresa l’Italia, non hanno ancora ratificato il Tpan, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari. In che modo voi, oltre naturalmente facendo la marcia, sensibilizzate e sollecitate i governi a firmarlo?
Noi come marcia e come associazione Mondo senza guerre e senza violenza, abbiamo proposto una campagna internazionale ad Ican, che questa ha deciso di adottare. Si tratta di una campagna rivolta alle municipalità, che possono appoggiare il trattato aderendo all’appello di Ican: “Le città sostengono il Tpan”. In questo modo le municipalità dal basso possono far pressione sui governi affinché firmino il Trattato. Si parte dal basso, anche un consigliere comunale d’opposizione può chiedere al proprio comune di aderire all’appello di Ican, così se ne parla e si sensibilizza l’opinione pubblica. Partendo da piccole città si può arrivare al capoluogo della propria regione e poi alla capitale del proprio Stato, facendo in questo modo sempre più pressione al governo del proprio Paese affinché firmi il Tpan.
Tra i personaggi italiani di spicco, ad aver aderito alla terza Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, c’è anche l’attore, regista e scrittore ebreo Moni Ovadia che ha lanciato un video di adesione.
L’autore: Andrea Vitello collabora con Pressenza, ha scritto “Il nazista che salvò gli ebrei” (Le Lettere)
Nella foto: Manifestanti della Marcia della pace a Firenze (foto Cesare Dagliana)