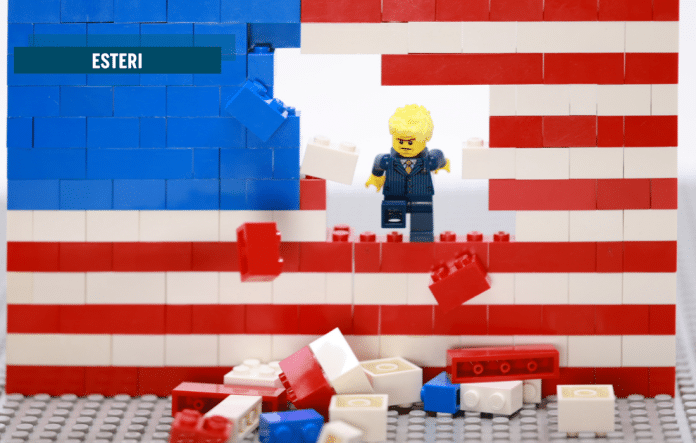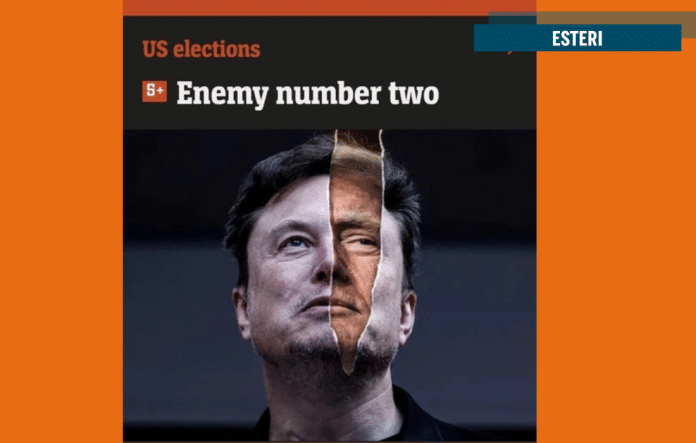Trump è stato eletto e si appresta a governare dal 20 gennaio 2025. Le sue nomine per il futuro governo sembrano essere frutto di un flagrante atto vendicativo contro quelli che considera i suoi nemici e le istituzioni (il “deep State”) che hanno reso il suo primo mandato (2016-2020) un clamoroso insuccesso. Punta davvero a realizzare i cambiamenti che ha in mente. Non vuole che qualcuno della sua squadra possa diventare un ostacolo, per cui sceglie solo dei fedeli esecutori dell’agenda MAGA e dei suoi ordini che manterranno le sue promesse. Con le sue nomine controverse, spregiudicate e scandalose, Trump ci sta mostrando esattamente come intende governare: come un estremista autoritario, con disprezzo per il pianeta, gli alleati dell’America e lo Stato di diritto.
Il contesto economico-politico: la crisi delle promesse del neoliberismo
La globalizzazione, il capitalismo del libero mercato e il neoliberismo, i principi organizzativi di tutti gli Stati tranne pochi, hanno mantenuto la promessa di avvicinarci tutti. Ma ciò che spesso viene trascurato è il modo in cui questi processi ci hanno resi più simili creando vincitori e vinti più o meno allo stesso modo in tutto il mondo. La standardizzazione dei modi di vivere e fare affari che la globalizzazione ha prodotto ha ancorato i vincitori e ha sganciato i vinti. Le nostre vite sono molto più riconoscibili l’una all’altra rispetto a 30 anni fa. Siamo stati tutti inondati da beni, servizi, app e intrattenimento digitale, eppure sentiamo ancora il bisogno di qualcos’altro, di un senso di sicurezza che vada oltre la nostra capacità di consumare nell’immediato.
Fingere di soddisfare tale esigenza è ciò che ha portato alla vittoria di Donald J. Trump. Lui capisce che un sistema oligarchico che arricchisce pochi non può garantire sicurezza economica alle masse. Se vuoi la maggioranza degli elettori dalla tua parte, devi promettere un cambiamento, ma non in un modo che riconfiguri effettivamente la struttura della società.
Il problema non è un sistema rapacemente capitalista che ha portato a un’assistenza sanitaria non funzionante, un sistema politico parlamentare catturato da ricche e potenti lobby o una deregolamentazione che ha spogliato i lavoratori dei loro diritti statutari e di conseguenza ha creato un trasferimento epico di ricchezza a una classe di miliardari. Il problema sono gli immigrati clandestini, i nemici all’interno della burocrazia che hanno cercato di far cadere Trump durante il primo mandato, gli estremisti della diversità (LGBTQ+, “wokism” e la teoria critica della razza, ossia la “Critical Race Theory”), per cui Trump probabilmente userà la dichiarazione di un’emergenza nazionale per utilizzare l’esercito per deportare milioni di immigrati e le accuse di antisemitismo per lanciare una repressione “anti-woke” nelle università americane. Se sei un leader di un partito centrista come quello Democratico e tutto ciò che hai per contrastare questa potente visione sono un sacco di bei valori, la promessa vaga e vuota di “creare una economia delle opportunità“ (un’idea che ha maggiori probabilità di attrarre gli imprenditori piuttosto che i lavoratori in difficoltà), tanti grandi sorrisi a 32 denti e “gioia” danzante ma nessuna proposta materiale e concreta per cambiare radicalmente la vita delle persone (la Harris non ha spiegato se e come avrebbe affrontato l’avidità aziendale e la disuguaglianza). Non hai nemmeno portato un coltello a una sparatoria: hai portato la pop star Taylor Swift e la repubblicana moderata, Liz Cheney, figlia del “falco” neoconservatore guerrafondaio Dick (il principale responsabile della guerra in Iraq). Questo mentre tra le decine di milioni di lavoratori i cui salari non hanno tenuto il passo con il costo della vita negli ultimi anni, si è registrata molta più frustrazione che gioia.
Il modello di libero mercato socialmente neoliberale in cui credono i liberal progressisti si è bloccato nel 2008 ed è entrato in una crisi profonda. Ma nelle loro intenzioni sarebbe sempre andato avanti senza una regolamentazione più aggressiva, politiche redistributive e il tipo di rete di sicurezza ad alta tassazione e alta spesa che è necessaria quando le relazioni e gli equilibri sociali tradizionali vengono infranti (come prevedeva il modello del New Deal e della socialdemocrazia). Sulla scia della globalizzazione, intere comunità negli Stati Uniti, come nel resto dell’Occidente, sono state frantumate e deindustrializzate mentre una classe operaia urbana mal pagata è stata creata nel Sud del mondo. Dopo il crollo finanziario del 2008, la ricchezza si è concentrata e ha escluso un’intera generazione di persone dalla vita della classe media e lavoratrice che avevano i loro genitori. Negli anni 2010, con l’ascesa delle aziende tecnologiche della Silicon Valley, si è aggiunto un crescente proletariato precario: autisti, riders e imballatori di scatole sono stati gettati in lavori mal protetti e mal pagati. I social media sono stati lanciati con la promessa del crowdsourcing della verità contro il potere e di avvicinarci tutti, poi hanno ceduto allo “smerdamento”, alla disinformazione, ai deepfake e al razzismo.
La vita moderna è fuori controllo. Non c’era modo per i Democratici di imitare il trucco di Trump e del resto della squadra autoritaria. Ostacolati dalla crescente esposizione di quel poco che i liberal possono fare in un mondo neoliberista, i progressisti negli Stati Uniti possono solo sottolineare l’importanza della legge, della costituzione, dell’ordine e delle istituzioni. Finché i centristi insisteranno su questo sistema e spereranno nel meglio, le democrazie occidentali saranno vulnerabili. La democrazia liberale elettorale e formale da sola non può garantire libertà e uguaglianza se il sistema economico in cui esiste impedisce a queste stesse qualità di emergere. Diviene una “democrazia oligarchica” o una “democrazia autoritaria”.
I politici autoritari e gli oligarchi che li appoggiano hanno una risposta al problema dei sistemi troppo redditizi e consolidati da disfare: mentire, usare capri espiatori e fare appello alle paure, ai pregiudizi e alle vanità delle persone. I liberal progressisti no. Perché non riescono a comprendere che all’interno di tali sistemi, i benefici della razionalità e delle libertà individuali, e la ricerca di soluzioni scientifiche e prosperità personale semplicemente non si accumulano più in modo significativo per un numero sufficiente di persone. L’ascensore sociale non sale, è fermo o scende sempre più in basso.
È più facile credere che sia stato il razzismo a far eleggere Trump. Ma la verità è che Trump ha vinto quasi due terzi di tutti gli elettori senza laurea e ha migliorato la sua performance con la classe lavoratrice non bianca. Secondo i sondaggi in uscita, il suo sostegno tra i neri è aumentato di oltre un terzo. Ha anche vinto una larga quota di latinoamericani, che sembravano fidarsi di lui di più per quanto riguarda l’economia, che i sondaggi hanno mostrato essere di gran lunga la questione più importante per gli elettori di origine latinoamericana.
La verità è che in tutto il mondo occidentale, il vecchio ordine basato sulla democrazia liberale è in drastico declino o scomparso e quello nuovo è sconcertante. Le persone si sentono intrappolate e vogliono un senso di liberazione, una promessa di un futuro radicalmente diverso, o semplicemente un futuro. Anche se quel senso di libertà proviene indirettamente da un autocrate o un oligarca miliardario che ha piegato e spezzato le catene del sistema. E vogliono sentirsi parte di qualcosa di più grande e forte mentre diventano più soli e più deboli e i loro mondi si fratturano e si atomizzano giorno dopo giorno. Non è che non siano pronti per la democrazia: la democrazia non è pronta per loro.
Le scelte di Trump
Il giorno dopo le elezioni presidenziali, molte anime belle hanno pensato che, nonostante il risultato non gradito, la democrazia non fosse finita, dopotutto, le elezioni erano democrazia. L’ex e futuro presidente avrebbe sicuramente rinunciato alle sue frenetiche minacce fatte nel corso della campagna elettorale e si sarebbe dedicato al banale compito di governare. Rendere di nuovo grande l’America richiede sobrietà e competenza, e Trump e i suoi consiglieri avrebbero senza dubbio riconosciuto tale obbligo.
Per gli oligarchi del business, la nuova amministrazione promette una prosperità inimmaginabile: la regolamentazione sarà allentata, le aliquote fiscali diminuite. Elon Musk renderà il governo dello Stato federale civile, generoso ed “efficiente” come la sua piattaforma di social media, X. Jeff Bezos, dopo aver ordinato al comitato editoriale del suo giornale (il Washington Post) di bloccare il suo sostegno a Kamala Harris, ha twittato disinteressatamente «grandi congratulazioni» a Trump, per il suo «straordinario ritorno politico». I dirigenti di Wall Street hanno esultato perché il «clima di fusioni e acquisizioni» porterà opportunità oltre ogni immaginazione. Come queste opportunità potranno giovare alla classe lavoratrice, presumibilmente sarà chiarito in un secondo momento.
Nel frattempo, il presidente eletto, in vista del suo ritorno alla Casa Bianca il 20 gennaio 2025, ha convocato i suoi fedelissimi a Mar-a-Lago, dove hanno messo insieme uno staff della Casa Bianca e un Gabinetto. Storicamente, questo è un processo deliberativo che può, anche con le nobili intenzioni, andare terribilmente male. Almeno sul piano retorico, Trump non è interessato alle nozioni convenzionali di competenza (che sa di elitismo). Né è interessato alla creazione di un gruppo di consiglieri capaci di articolare un disaccordo critico costruttivo, una squadra di rivali (che sa di slealtà). Mentre le sue scelte del personale – che richiederanno l’approvazione del Senato controllato (53 a 47) dai repubblicani che, in molti (alcuni ancora della vecchia guardia, per cui è stato eletto speaker il moderato John Thune del Sud Dakota), non appaiono contenti per la presenza di diversi candidati controversi e in gran parte senza nessuna esperienza governativa – si sono svolte nel corso delle due ultime settimane, è diventato chiaro che puntano interamente alle sue priorità di lunga data.
In passato, numerosi candidati alle posizioni di governo hanno fatto ricorso a una retorica che avrebbe indebolito la missione delle agenzie per le quali sono stati proposti. Le nomine dell’ex deputato della Florida Matt Gaetz come Procuratore Generale (mentre gli avvocati penalisti personali di Trump, Todd Blanche ed Emil Bove, sono stati scelti per i ruoli più importanti nel Dipartimento di Giustizia), dell’avvocato ambientalista, scettico sui vaccini e nipote dell’ex presidente John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Jr., come Segretario della Salute e dei Servizi Umani (che supervisiona la Food and Drug Administration, l’agenzia che regola cibo e farmaci), del conduttore di Fox News e veterano militare Pete Hegseth come Segretario della Difesa e l’ex deputata democratica delle Hawaii (fino al 2022), Tulsi Gabbard, come Direttore dell’Intelligence Nazionale, sono il residuo dei risentimenti di Trump e della sua sete di vendetta contro i suoi oppositori del “deep State” che comprende le agenzie di intelligence, il Dipartimento di Giustizia e l’esercito. Durante il primo mandato di Trump, questi organismi si sono opposti alle sue mosse più autoritarie, come l’impiego di truppe contro i manifestanti e la dichiarazione di illegittimità delle elezioni del 2020.
In Gaetz, che affronta accuse (da lui negate) di uso illegale di droga e di aver fatto sesso con una minorenne, Trump vede se stesso, un uomo giudicato ingiustamente, insiste, come responsabile di abusi sessuali. In Kennedy, un teorico della cospirazione anti-vaccino, vede una rivendicazione del suo stesso sospetto sulla scienza e la sua gestione selvaggiamente irregolare della crisi del CoVid-19. In Hegseth, che difende i criminali di guerra e critica i generali “risvegliati”, vede una vendetta contro gli esponenti dell’establishment militare che lo hanno definito inadatto. In Gabbard, che trova il buono nei dittatori stranieri (ha espresso simpatia anche per Putin), vede qualcuno che potrebbe modellare il lavoro delle 18 agenzie di intelligence (tra cui CIA e NSA) per contrastare gli oppositori interni ed esterni e per aiutare a giustificare la fine del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. In altre parole, le nomine di Trump, nel loro sconsiderato sostegno a chi è pericolosamente non qualificato, sembrano essere frutto di un flagrante atto vendicativo. Ma sta andando anche oltre i limiti che la maggioranza dei senatori repubblicani sembrano essere disposti a tollerare.
Tutti questi nominati sono destinati a sostenere lo sforzo di Trump di licenziare i funzionari e decostruire le istituzioni federali che disprezza o considera come minacce al suo potere o alla sua persona. Questi nominati non sono destinati a essere i suoi consiglieri (tra questi, invece, oltre al vicepresidente JD Vance, ci sono Elon Musk e Peter Thiel, il miliardario responsabile dell’ascesa di Vance; Susie Wiles, Capo dello staff della Casa Bianca; Stephen Miller, vice Capo dello staff per la politica, che è stato stretto consigliere e speechwriter di Trump dal 2015 e che durante il primo mandato di Trump, è stato coinvolto nello sviluppo di alcune delle più severe politiche sull’immigrazione dell’amministrazione; l’avvocato repubblicano William McGinley che assumerà il ruolo di consigliere della Casa Bianca e ha prestato servizio come segretario di gabinetto della Casa Bianca durante parte del primo mandato di Trump ed è stato il consigliere del Republican National Committee per l’integrità elettorale nel 2024; Karoline Leavitt che sarà l’addetta stampa della Casa Bianca; Steven Cheung che sarà il direttore della comunicazione ed è parte del team di Trump dal 2016; Sergio Gor, socio in affari di Donald Trump Jr, che sarà l’assistente del Presidente). Sono le sue fedeli truppe d’assalto – i “disruptors”, ossia persone che sconvolgeranno lo status quo – che credono ciecamente nell’ideologia trumpiana. D’altra parte, se le scelte del gabinetto di Trump, vengono disprezzate e stroncate dai critici di Washington (che vedono candidati sottoqualificati e discutibili), entusiasmano molti dei suoi elettori che li descrivono come degli anticonformisti reclutati per scuotere Washington.
A questi si aggiungono altri fedelissimi di Trump come il ricco Doug Burgum, governatore del Dakota del Nord, per guidare il Dipartimento degli Interni, l’agenzia responsabile della gestione e della conservazione delle terre federali e delle risorse naturali. L’ex membro del Congresso della Georgia (ha perso la corsa al Senato) e cappellano della US Air Force Reserve, Doug Collins, è stato scelto per guidare il Dipartimento per gli Affari dei Veterani. La governatrice del Sud Dakota Kristi Noem alla Homeland Security, un ruolo ministeriale chiave di supervisione della sicurezza degli Stati Uniti, compresi i confini, le minacce informatiche, il terrorismo e la risposta alle emergenze (l’agenzia ha un budget di 62 miliardi di dollari e impiega migliaia di persone). Il fondatore e CEO di Liberty Energy del settore petrolifero e del gas (fracking) Chris Wright guiderà il Dipartimento dell’Energia, dove dovrebbe mantenere la promessa della campagna elettorale di Trump di «trivellare, baby, trivellare» e massimizzare la produzione energetica fossile degli Stati Uniti (ha definito allarmisti gli attivisti per il clima, ha paragonato la spinta dei Democratici per le energie rinnovabili al comunismo in stile sovietico e in un video pubblicato sul suo profilo LinkedIn l’anno scorso, ha affermato: «Non c’è alcuna crisi climatica e non siamo nemmeno nel mezzo di una transizione energetica»). Lo “zar del confine”, l’ex agente di polizia che è stato direttore ad interim dell’US Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante il primo mandato di Trump, Tom Homan, ricoprirà un incarico fondamentale perché include la responsabilità delle deportazioni di massa di milioni di migranti clandestini da parte di Trump, che è stata una promessa centrale della campagna (ha garantito che gestirà «la più grande operazione di espulsioni che questo paese abbia mai visto»). Homan, insieme a Miller e Noem rappresenta la fazione dei sostenitori della linea dura sul controllo di confine e immigrazione e Trump stesso ha suggerito che dichiarerà l’emergenza nazionale e userà l’esercito per portare avanti le deportazioni di massa. L’ex deputato repubblicano e tra i dirigenti del think-tank texano trumpiano America First Policy Institute (AFPI), Lee Zeldin, guiderà l’Environmental Protection Agency (EPA) e si occuperà della politica climatica americana in questo ruolo (ha già detto che ha intenzione di “ridurre le normative” fin dal primo giorno). La deputata di New York Elise Stefanik è stata scelta per ricoprire il ruolo di ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Trump ha scelto il suo ex direttore dell’intelligence nazionale, l’ex membro del Congresso del Texas John Ratcliffe, per ricoprire il ruolo di direttore della Central Intelligence Agency (CIA). Trump ha anche detto che licenzierà il direttore dell’FBI Chris Wray, che aveva nominato nel 2017, ma con cui da allora ha litigato. Jeffrey Jensen, un ex procuratore degli Stati Uniti nominato da Trump, viene preso in considerazione per sostituire Wray. Il deputato della Florida ed ex membro delle Forze speciali dell’esercito americano, Michael Waltz, è stato scelto come prossimo Consigliere per la Sicurezza Nazionale (dovrà aiutare a gestire la posizione degli Stati Uniti sulle guerre in Israele, in Ucraina e in Russia); insieme a Rubio e Ratcliffe forma la fazione dei falchi anti-Cina. Trump ha scelto l’investitore immobiliare e filantropo Steve Witkoff per il ruolo di inviato speciale in Medio Oriente. Witkoff farà coppia con l’ex governatore dell’Arkansas e fervente pastore evangelico Mike Huckabee che sarà ambasciatore degli Stati Uniti in Israele (Huckabee è fermamente filo-israeliano e in precedenza ha respinto l’idea della “soluzione dei due Stati” per risolvere il conflitto israelo-palestinese). Né Huckabee né Witkoff hanno precedenti esperienze diplomatiche, né tantomeno una profonda conoscenza del Medio Oriente. Infine, il repubblicano Brendan Carr sarà a capo della Federal Communications Commission (FCC), di cui è un membro attuale, che regolamenta l’uso di Internet e delle trasmissioni. Apparentemente è un sostenitore della regolamentazione delle Big Tech: “Facebook, Google, Apple, Microsoft e altri hanno svolto un ruolo centrale nel cartello della censura che deve essere smantellato”, ha scritto su X.
Per il Dipartimento dei Trasporti (che ha un budget di circa 110 miliardi di dollari, oltre a finanziamenti significativi rimanenti nell’ambito della legge sulle infrastrutture da 1 trilione di dollari del 2021 dell’amministrazione Biden), Trump ha scelto il collaboratore di Fox News Sean Duffy, un ex membro repubblicano della Camera (2011-2019) per il Wisconsin che è stato anche parte del cast della serie The Real World: Boston (1997) prodotta da MTV. “Darà priorità a eccellenza, competenza, competitività e bellezza quando ricostruirà le autostrade, i tunnel, i ponti e gli aeroporti americani”, ha affermato Trump in una dichiarazione che annunciava la sua nomina. «Si assicurerà che i nostri porti e le nostre dighe servano la nostra economia senza compromettere la nostra sicurezza nazionale e renderà di nuovo sicuri i nostri cieli eliminando la DEI per piloti e controllori del traffico aereo» (DEI sta per “diversità, equità e inclusione” e sono dei quadri organizzativi che mirano a promuovere il trattamento equo e la piena partecipazione di tutte le persone, in particolare dei gruppi che sono stati storicamente sottorappresentati o soggetti a discriminazione sulla base dell’identità o della disabilità). Trump ha promesso di annullare le norme sulle emissioni dei veicoli dell’amministrazione Biden. Ha affermato che intende iniziare il processo di annullamento delle severe norme sulle emissioni, finalizzate all’inizio di quest’anno, non appena entrerà in carica. Le norme riducono i limiti delle emissioni allo scarico del 50% rispetto ai livelli del 2026 entro il 2032 e spingono le case automobilistiche a costruire più veicoli elettrici.
Il senatore della Florida (dal 2010) Marco Rubio, ex cubano anticastrista, è una scelta più sicura come prossimo Segretario di Stato. Sarà il primo latino nella storia degli Stati Uniti e ha una visione aggressiva verso Cina (ha descritto il rivale americano come la “minaccia che definirà questo secolo”) e Iran.
I sostenitori miliardari Elon Musk e Vivek Ramaswamy avranno un ruolo nel taglio dei costi. Sono loro che dovranno condurre l’attacco frontale contro il ruolo dello Stato federale, cercando di scardinarne le funzioni. Ramaswamy e Musk, l’uomo più ricco del mondo che ha investito 132 milioni di dollari nella campagna di Trump, sono destinati a guidare il nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), l’agenzia che, secondo Trump, condurrà un «audit finanziario e delle prestazioni completo dell’intero governo federale e formulerà raccomandazioni per riforme drastiche». Musk ha proposto di tagliare di 2 trilioni di dollari il budget federale, corrispondente a poco meno di 1/3 di quest’ultimo. L’obiettivo è lo “slash-and-burn”, il fare terra bruciata per arrivare allo “Stato minimo” con la drastica riduzione della burocrazia (almeno 1/3) per «decostruire il deep-State» (a partire dai vertici militari e dell’intelligence), la radicale privatizzazione del sistema del welfare e di altre funzioni regolative e gestionali. Sarà una guerra complicata e difficile da vincere considerati gli evidenti conflitti di interesse in campo e dato che i dipendenti del governo federale godono di forti tutele occupazionali che ostacolerebbero l’approccio di Musk alla riduzione dei costi, rendendolo forse impossibile.
Mancano ancora le nomine dei Segretari al Tesoro (tra i papabili ci sono Scott Bessent, il fondatore della società di investimenti Key Square Capital Management ed ex gestore finanziario di George Soros, che è diventato un importante fundraiser e consigliere economico di Trump; Howard Lutnick, amministratore delegato della società di Wall Street Cantor Fitzgerald e sostenuto da Musk; John Paulson, un altro mega-donatore del mondo degli hedge fund; l’ex presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) Jay Clayton; Marc Rowan, l’amministratore delegato di Apollo Global Management; Kevin Warsh, un ex governatore della Federal Reserve); al Commercio (in ballo ci sono la donna che presiede il team di transizione di Trump, Linda McMahon; la CEO del think-tank AFPI Brooke Rollins; l’ex rappresentante commerciale degli Stati Uniti nell’amministrazione Trump dal 2017 al 2021 chi ha guidato la guerra tariffaria con la Cina e l’Unione Europea, Robert Lighthizer; e una ricca donna d’affari che ha prestato servizio per un breve periodo al Senato, Kelly Loeffler); al Lavoro; all’Agricoltura; all’Edilizia pubblica e allo Sviluppo Urbano. Trump ha promesso durante la campagna elettorale di chiudere il Dipartimento dell’Istruzione, ma per farlo servirebbe l’approvazione del Congresso.
Sul piano delle politiche economiche, ricordiamo che Trump ha detto che vuole implementare un piano per imporre tariffe elevate (dal 10% al 60%) su migliaia di miliardi di dollari di importazioni che riporterà immediatamente le fabbriche negli Stati Uniti. “Torneranno subito”, ha detto. Pochi economisti sono d’accordo, avvertendo che rispettare questa promessa causerà invece un aumento dei prezzi al consumo (inflazione), con gli oneri più pesanti che ricadranno sulle famiglie a basso reddito, e che costringerà la FED a rallentare la riduzione dei tassi di interesse o, addirittura, a rialzarli.
Trump è sempre stato ossessionato dai drammi di dominio e sottomissione, forza e debolezza, chi ride di chi. Questa è la sua lente per le relazioni umane in generale, e in particolare quando si tratta di politica, estera e interna. Durante la campagna presidenziale, Trump ha detto a una folla a Mar-a-Lago, «Il 5 novembre passerà alla storia come il giorno più importante nella storia del nostro paese. In questo momento, non siamo rispettati. In questo momento, il nostro paese è considerato una barzelletta. È una barzelletta».
Ora i critici di Trump e un numero crescente di suoi sostenitori stanno facendo il punto sulle sue nomine più vergognose: questi uomini e donne con mascelle perfette, reputazioni dubbie e idee marce. Si chiedono se questa non sia la barzelletta definitiva, con il pericolo e il declino nazionale come battuta finale.
Le forze politiche che animano la gigantesca macchina-Stato statunitense sono diventate faziose ed incoerenti all’interno di una battaglia tra il pluralismo della liberal-democrazia oligarchica e il fascismo autoritario proposto da Trump. Potrebbe essere solo questione di tempo prima che quell’incoerenza politica cominci a colpire le maggiori leve del potere economico e militare. Dal 20 gennaio 2025, con il ritorno alla presidenza di Trump dovremmo aspettarci che le disfunzioni diventino ancora più evidenti. L’enigma che devono affrontare gli alleati dell’America – a cominciare dagli europei che fanno parte della NATO, un’alleanza apparentemente difensiva rilanciata dagli USA come strumento per restaurare il proprio dominio sull’Europa e sul resto del globo – è come far fronte al declino e alla possibile implosione di una grande potenza imperiale che è ancora una grande potenza imperiale, il garante dell’ordine mondiale, ma che è anche la più grande fonte potenziale del suo disordine e sfarinamento.