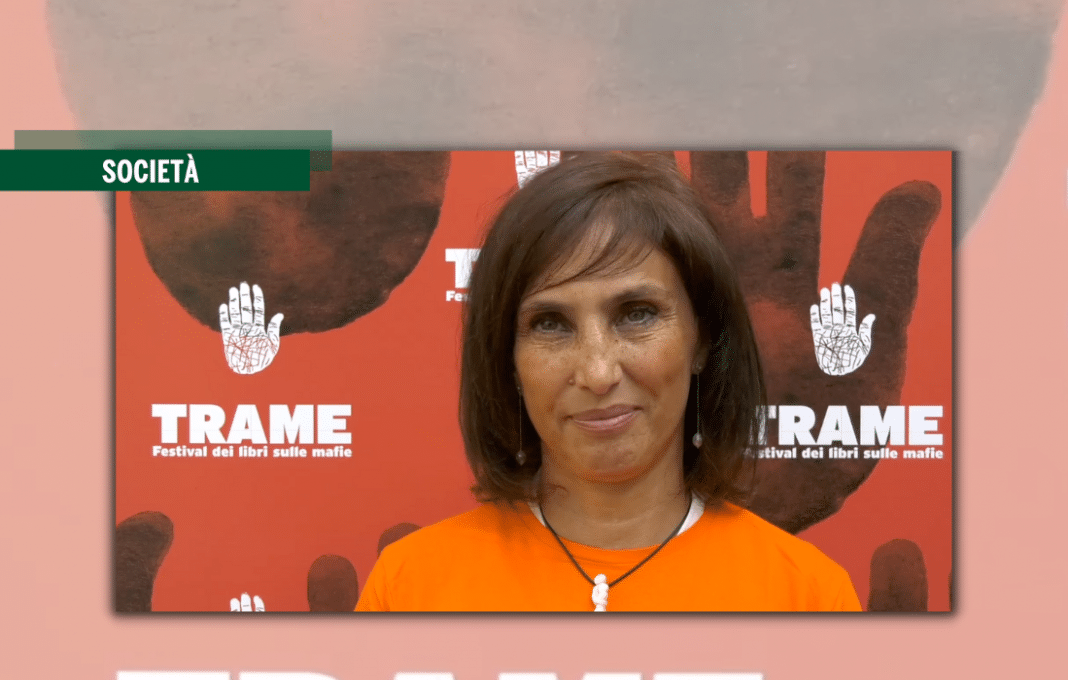Quando penso al direttore di un carcere, l’immagine che mi viene in mente è quella di Samuel Norton nel film Le ali della libertà, un individuo che impone la sua legge sui detenuti con violenza e prevaricazione. Niente di più lontano dalla verità nel caso di Cosima Buccoliero, già vicedirettrice del carcere di Opera, direttrice del carcere di Bollate e dell’Istituto penale minorile Beccaria di Milano, nonché autrice, insieme a Serena Uccello, del libro Senza sbarre. Storia di un carcere aperto, edito da Einaudi.
Una donna pratica ma sensibile, che ha saputo portare l’umanità tra le mura del carcere, che non crede che ci siano solo il bianco o il nero: «C’è anche il grigio, ed il bianco può diventare nero e viceversa». Una professionista che ha voluto esserci, condividendo i problemi di coloro che sono detestati o, peggio ancora, dimenticati da tutti: i detenuti, convinta che la persona non sia il suo reato e che tutti abbiano diritto a una seconda possibilità.
«Il carcere può diventare un luogo profondamente ingiusto, che spoglia l’individuo della propria identità», ci dice l’autrice che ci spiega che se il carcere è coartazione e violenza, questa violenza si ribalterà nella società, rendendola a sua volta violenta e insicura. In questo libro viene descritto il modello di carcere a cui ha lavorato Buccoliero con i suoi collaboratori: un luogo che non vuole essere di segregazione, dove anzi le porte sono aperte per fare entrare “energia”, dove i diritti e la dignità dell’uomo devono essere garantiti in linea con quanto previsto dalla Costituzione.
Quanto è stato realizzato a Bollate deve essere raccontato perché dove manca la conoscenza, sono i pregiudizi e i cliché a tenere banco.
Bollate offre ai detenuti un trattamento penitenziario particolare, con stanze di detenzione aperte di giorno, celle singole (riservate soprattutto ai detenuti condannati all’ergastolo, così da rendere più umana la prospettiva del “fine pena mai”), celle da due o da quattro posti, con la possibilità graduale di ottenere libertà di movimento all’interno dell’istituto, aderire a offerte lavorative, formative e culturali.
Un modello di carcere in cui non si pensa solo ai bisogni primari ma dove si punta a sfruttare bene il tempo della detenzione, lavorando perché la persona possa uscirne migliorata e pronta ad essere reinserita nella società.
Nel libro si spiega chiaramente che il modello della detenzione dura non porta alcun beneficio ma molti svantaggi per tutta la collettività. Il detenuto che si trova a vivere una condizione di totale afflizione si sentirà vittima del sistema, non compirà nessun passo in avanti (ma verosimilmente moltissimi passi indietro) e una volta uscito tornerà a delinquere.
Un carcere diverso determina risultati decisamente più positivi per tutti: detenuti, operatori e anche per la collettività poiché la recidiva di chi esce da un carcere come Bollate è del 20% contro l’80% della media nazionale. Inoltre, un detenuto che vede riconosciuti i propri diritti e la propria dignità sarà più propenso a compiere un’opera di rielaborazione e riflessione su quanto accaduto, su cosa lo ha portato a commettere il reato, sul danno provocato alla persona offesa e ai suoi familiari.
Discorsi sensatissimi che però non riescono a squarciare la cortina di silenzio e pregiudizio che avvolge da sempre l’argomento carcere. La mancanza di conoscenza su cosa sia realmente il carcere è un grande problema, ci dice Cosima Buccoliero. I media non si interessano di quello che accade dentro quelle mura, ne parlano solo quando succede qualche fatto negativo e, allo stesso tempo, i politici, anche a livello locale, preferiscono non occuparsene. Un’altra difficoltà che porta il carcere ad essere un argomento impopolare è la difficoltà di coniugare i diritti dei detenuti con quelli delle vittime dei loro reati.
Perché pensare ai diritti dei carcerati quando questi non hanno di certo rispettato quelli delle loro vittime? La Buccoliero risponde con un pensiero semplice e carico di sensibilità: forse non si è obbligati a sanare questa contraddizione, basta sapere che esiste e tener conto di una prospettiva e dell’altra. Ma lo Stato deve comportarsi come stabilito dalla Carta Costituzionale, rispettando il detenuto in quanto persona che dovrà essere reinserita nella società e, in effetti, il modello Bollate va proprio in questo senso.
Viene da domandarsi cosa si può fare perché questa tipologia di carcere diventi l’unica possibile e l’autrice ci indica una strada da seguire: ripartire dalle nuove generazioni.
Per arrivare a un cambiamento culturale bisogna coinvolgere le scuole, i luoghi i cui si formeranno gli adulti di domani.
L’autrice ci racconta dei risultati positivi prodotti negli ultimi dieci anni dagli accordi col Ministero dell’Istruzione, dei progetti che sono stati realizzati e che hanno visto coinvolti moltissimi ragazzi. Gli studenti sono stati accolti nelle carceri, si sono confrontati con i detenuti, con la polizia penitenziaria e con gli operatori. Altre volte, sono stati i detenuti, i poliziotti e i dirigenti delle carceri ad andare nelle classi e le esperienze sono state importanti e formative.
La scuola è un luogo di educazione ma anche di formazione delle nuove personalità e, ancora una volta, è chiaro come sia importante investire su di essa perché si possa costruire una società migliore, una cultura più sana, in cui il carcere possa essere visto come l’extrema ratio e possa essere percepito con una diversa sensibilità.
Per approfondire, da leggere su Left:
Luigi Manconi: vi racconto perché il carcere è inutile