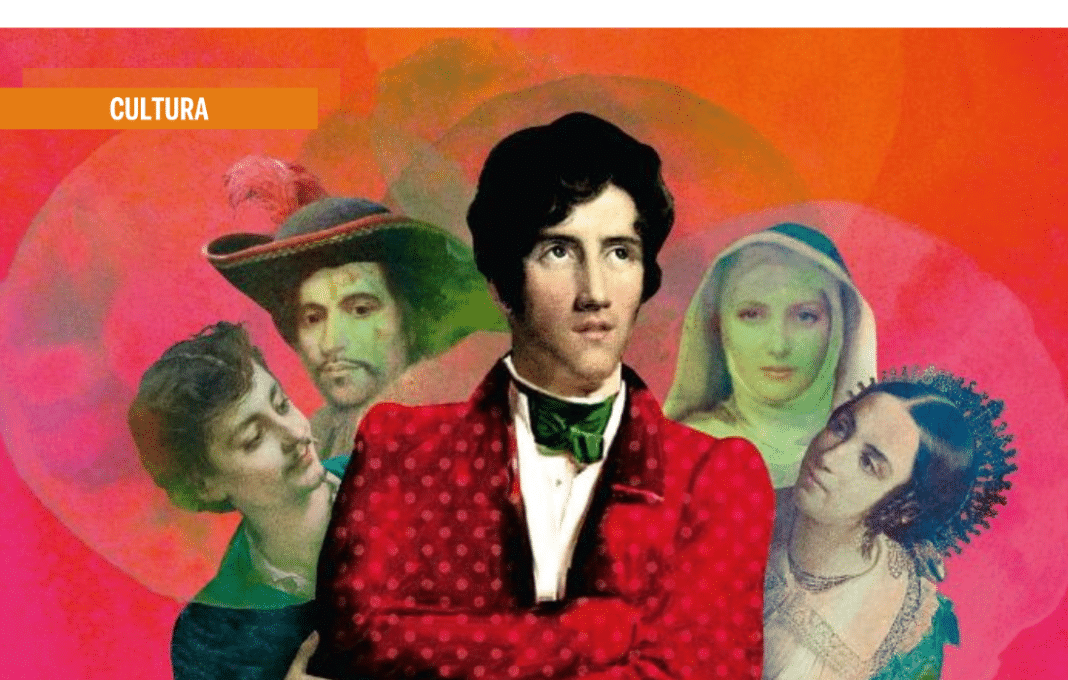Manzoni un «rivoluzionario passato alla storia come un reazionario», denunciava già Carlo Dossi. Eleonora Mazzoni, il discorso agiografico su Manzoni ne ha alterato la memoria?
La discussa conversione di Manzoni, su cui sono stati spesi fiumi di parole, dimenticando che lui avesse optato per la sua proverbiale riservatezza, ha presto generato un’immagine di bigotto baciapile. Mi ha sempre colpito il commento di uno dei primi biografi dello scrittore: “i preti furono solleciti a levarne soverchio romore e a trarne troppo grande profitto”.
Quanto sono responsabili certi programmi scolastici nel proporre un ritratto polveroso, tout court conservatore, dell’autore dei Promessi sposi?
I promessi sposi, quando uscirono nel 1827, ebbero un successo spropositato, popolare e trasversale. Lo leggevano tutti quelli in grado di leggere, “dalla portinaia all’astronomo”, come diceva sempre Carlo Dossi. Venne tradotto subito in Francia e in Germania, dove fu recensito da Goethe. La stessa cosa successe nel 1840-42 con l’edizione definitiva. Purtroppo un romanzo così vitale subì in seguito uno strano destino: si istituzionalizzò.
A quando risale questo obbligo scolastico”punitivo”?
Ai primi del Novecento e aveva la funzione educativa di guidare i ragazzi verso i buoni sentimenti, poi rinsaldata dalla riforma Gentile e, a breve giro, anche dall’introduzione nelle scuole dell’insegnamento della religione cattolica. Manzoni si proponeva l’utile per scopo, il vero per oggetto e l’interessante per mezzo, non aveva certo l’obiettivo di educare ragazzi. Ai buoni sentimenti, poi. Per potere assolvere questa funzione, quindi, l’opera fu mutilata dell’inquietudine che conteneva, a lungo le sue parti più pericolose, come i capitoli dedicati a Gertrude o certi brani relativi al troppo “difettoso” Don Abbondio, furono ignorate.
Non fu considerata abbastanza la sua Storia della colonna infame che denuncia l’ingiustizia durante la peste di Milano del 1630?
La Storia della colonna infame è il racconto duro, atroce, drammatico di un’ingiustizia della giustizia, nell’edizione del 1827 era ancora dentro alla carne del romanzo. Diventò in quella definitiva un’opera a se stante, che però rappresentava il finale ideale de I promessi sposi e l’antidoto naturale a ogni tentazione di interpretazione idilliaca. Bene. Quel processo, “capolavoro d’autorità, di superstizione e di bestialità”, cadde nell’oblio più assoluto. Dunque una lettura imposta – di per sé capace di trasformare un piacere in piccola o grande avversione – perdipiù edulcorata: un cocktail veramente letale sia per il romanzo che per il suo autore.
Il suo primo incontro con le opere di Manzoni è avvenuto fuori dall’obbligo scolastico. Ha giovato che fosse una libera scelta piluccando da sola nella biblioteca di famiglia. Cosa le ha fatto scattare il pensiero “Questo scrittore capisce gli esseri umani”?
Sì, e sono molto grata alla mia curiosità giovanile! Sicuramente il personaggio in cui mi colpì allora, anche per una questione anagrafica, fu la monaca di Monza. Manzoni scava nella psicologia di quella bambina e adolescente, tartassata dalla violenza che compiono su di lei – in maniera subdola e sottile, mai manifesta – il padre e tutta la società patriarcale, con una tale immediatezza di particolari e sfumature. Si avventura nelle pieghe della sua mente, dentro alle sua paure, i continui rimandi e le incapacità di opporsi, poi, una volta avvenuto l’abuso, affonda nei rimpianti e nel risentimento. Ma ogni personaggio de I promessi sposi è costruito a tutto tondo, quasi a comporre un altro romanzo all’interno del romanzo stesso, con un punto di vista preciso e una voce narrativa specifica, che crea la polifonia e la varietà di stili presenti nell’opera. E ogni personaggio viene presentato come un caso di coscienza, che ancora oggi ha molto da dirci.
Mettere insieme biografia e opera è un modo non per fare aneddotica ma al contrario per andare più in profondità. Come è nata questa esigenza e questa ricerca?
Dopo essere rimasta folgorata a neppure dodici anni da I promessi sposi e dopo averli riletti svariate volte in età diverse, sempre continuando ad amarli, ho avuto voglia di conoscere di più l’autore. Anche qui, mi sono imbattuta, a parte poche eccezioni, in una gran quantità di libri pedanti e noiosi. Fedele al consiglio di Calvino di preferire la «lettura diretta dei testi originali, scansando il più possibile bibliografia critica, commenti, interpretazioni», sono andata alla fonte e alle tantissime lettere di Manzoni, a cui ho aggiunto anche quelle della madre, delle mogli, figli, parenti e amici. Pur sapendo che gli epistolari, soprattutto a quei tempi, seguivano una grammatica peculiare e non dicevano la verità tout court, mi sono messa in ascolto profondo dei pensieri e delle emozioni, seguendo quella preziosa quotidianità che si capta qua e là. Quando poi sono tornata a I promessi sposi, ho notato quanto siano impregnati di traumi, ostacoli, esperienze sue personali, oltre che di luoghi, paesaggi, sapori e odori. E questo mi ha permesso una lettura ancora più accurata.
Nel libro spicca Giulia Beccaria, madre di Manzoni. Fu costretta alle nozze con l’anziano conte Manzoni da suo padre, il celebre Cesare Beccaria, così poté continuare la relazione con Verri, approfittando giustamente dell’ipocrisia dell’epoca. Dopo la nascita di Alessandro scappò, ancora una volta per amore, rifugiandosi nei salotti illuministi di Parigi. Una figura decisamente insolita, quella di Giulia. A suo modo cercò di ribellarsi al patriarcato e a un padre che, per quanto avesse scritto Dei delitti e delle pene, forse non era così affettivo e aperto ai diritti delle donne?
Giulia era veramente anti convenzionale, non a caso fu sempre molto chiacchierata dalla società milanese. Prima di moglie e madre, sentiva istintivamente di essere una donna. Ebbe il coraggio di chiedere una separazione dal marito, che non sopportava più, senza accettare l’ipocrisia dei cavalier serventi o dei cicisbei e fregandosene dei pettegolezzi. E fece causa a suo padre per avere l’eredità, che le aveva lasciato sua madre e lui le aveva egoisticamente sottratto. Giulia intuiva che, per essere libera, a una donna occorreva non solo una buona formazione culturale ma anche un’indipendenza economica, quella famosa rendita di 500 sterline l’anno rivendicata un secolo e mezzo dopo da Virginia Woolf.
In questo alveo si iscrive l’adorazione che Beccaria nutriva per Rousseau? Beccaria «illuminato solo a parole»?
È interessante vedere che nella vita di Cesare Beccaria, geniale intellettuale, ma ombroso e anaffettivo, agivano spinte diverse. Questo si nota anche in altre menti progressiste: se da una parte a livello teorico sentivano, ad esempio, il bisogno di definire un altro tipo di femminilità più moderna, dall’altra nella pratica rimasero a lungo intrappolati in posizioni più tradizionali e tranquillizzanti per il genere maschile. Nel rapporto con la figlia femmina (un maschio Beccaria ce lo avrà dalla seconda moglie), questo è ancora più evidente: l’illuminato Beccaria rinchiuse Giulia in un collegio di suore agostiniane, paragonato da lei, esattamente come faranno anche Manzoni e la Monaca di Monza, a un carcere, permettendole così solo una cultura scarsa e approssimativa, le combinò un matrimonio per lei odioso, non le cedette la legittima eredità materna.
Torniamo a Manzoni: Da un lato si taglia il codino, si ribella ai preti che abusano degli studenti, legge Voltaire, sceglie amicizie elettive per sottrarsi a rapporti di sangue indifferenti e anaffettivi, rifiuta la religione. Dall’altra però finisce nel gorgo della ritualità (pretendendo il battesimo cattolico dei figli), finendo folgorato sulla via di Damasco dopo una crisi di panico. Un bel guazzabuglio di contraddizioni?
Sì, proprio un bel guazzabuglio. Ci tenevo innanzitutto a rispolverare l’adolescenza e la giovinezza di Manzoni (Manzoni, tra l’altro, non viene mai percepito giovane!), periodo irrequieto, trasgressivo, giacobino e anticlericale senza mezzi termini, con quei dieci anni passati in tristi collegi cattolici, tutti da lui detestati, e con quel suo successivo soggiorno francese, tra salotti mondani impegnati e anticonformisti. Manzoni a ventun anni, mentre era già a Parigi, di fronte al compagno di collegio Luigi Arese, gravemente ammalato e costantemente assediato dai preti, è uno che disse al comune amico Pagani di voler rimanere lontano dall’Italia, «un paese, in cui non si può vivere né morire come si vuole. Io preferisco l’indifferenza naturale dei Francesi che vi lasciano andare pei fatti vostri, allo zelo crudele dei nostri che s’impadroniscono di voi, che vogliono prendersi cura della vostra anima, che vogliono cacciarvi in corpo la loro maniera di pensare». Sono parole forti. Ad un certo punto sì, è indubbio che ci sia stato in Manzoni un cambio di rotta, il recupero di una fede in dio e il bisogno di un centro saldo (anche se Carlo Dossi, suo attento conoscitore, sosteneva che «Manzoni – come ogni grande umorista – è scettico» e «dissimula il non credere»). Comunque sta di fatto che la sua formazione continuò a circolare nel suo sangue e nel suo cervello anche dopo. Così come una certa dose di anticlericalismo – basta leggere alcune lettere a Padre Tosi. Manzoni, lievemente eretico per la vicinanza all’ambiente giansenista, non condivise mai il potere temporale della Chiesa. E il suo pensiero rimase, anche indipendente e originale.
Che idea si è fatta del suo rapporto con Enrichetta, docile, innamorata, sedicenne, molto religiosa, con cui lui instaura un rapporto simbiotico? Enrichetta sua musa, sua moglie e sua ombra… tutto questo ci aiuta a poter meglio comprendere il personaggio di Lucia?
Mentre ho amato follemente Giulia Beccaria (e Gertrude), di primo acchito Enrichetta (e Lucia) mi sono apparse donne di altri tempi, distanti dalla nostra sensibilità contemporanea. In effetti per tanti versi Enrichetta (e Lucia) restano donne di quei tempi, che ci raccontano quei tempi e le donne di quei tempi, a cui era ancora quasi totalmente sottratto il diritto di parola e la possibilità di inserirsi all’interno di una dimensione pubblica, private di quel “potere” inteso primariamente come verbo: poter essere ascoltate, poter essere prese in considerazione, poter incidere nel mondo. Guardandole però a un certo punto con occhio più attento, ho riconosciuto sia in Enrichetta sia in Lucia un ruolo chiave e una forza “guerriera”, per nulla passiva, che subito non avevo percepito. Anche qui ho dato credito al commento di uno dei primi biografi di Manzoni, che parlava di Enrichetta, oltre che come musa, anche come prima lettrice dei testi del marito, mentre noi tendiamo a immaginare in quel ruolo il solito Fauriel o l’amico Ermes Visconti. Allora la questione diventa più complessa, considerando, tra l’altro, che nell’Introduzione al Fermo e Lucia lo scrittore dichiara espressamente di voler rivolgersi all’universo femminile e che affida a una donna la conclusione del suo romanzo.