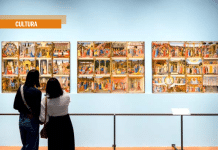La destra sta colonizzando il linguaggio della politica. Se, come riteneva Edward Sapir, grande vecchio dell’antropologia linguistica nordamericana, lingua e cultura sono in rapporto di interazione reciproca, l’uso di determinati termini può agire a livello culturale veicolando una particolare visione della società e dei rapporti sociali. La destra, in altre parole, più o meno consapevolmente a seconda dei casi, sta agendo sul piano culturale tramite il linguaggio per sdoganare e rendere condivisibili i punti di vista che le sono cari. Bastano pochi colpi ben assestati ad alcuni concetti che sono alla base della democrazia per aprire le porte a una visione dello Stato e della società ben diversa da quella delineata nella nostra Costituzione repubblicana e antifascista.
La prima nozione da tempo sotto attacco è quella di cittadino/a. Nei discorsi pubblici, nelle interviste, negli articoli dei quotidiani – purtroppo anche non di destra – sempre più spesso si parla di ‘italiani’ piuttosto che di cittadini. Sono gli italiani, non i cittadini, che vanno o non vanno a votare; è la supposta volontà degli italiani, non dei cittadini, a cui i politici si appellano; e sono le esigenze degli italiani, non dei cittadini, quelle che il politico di turno sbandiera come obiettivo della sua azione. Il messaggio che viene trasmesso – a volte magari anche indipendentemente dalla volontà di chi parla – è che gli unici veri titolari dei diritti costituzionalmente garantiti sono le persone di ascendenza italiana, e che pari diritti non possono quindi essere riconosciuti a persone di diversa origine: “prima gli italiani”, come recita il motto di Salvini.
Non era questa la visione dei Costituenti che hanno voluto un testo in cui il termine ‘italiani’ compare una sola volta, all’art. 51, a proposito dell’accesso alle cariche pubbliche da parte degli «italiani non appartenenti alla Repubblica». I Costituenti non hanno definito l’Italia Stato degli italiani. Anzi, hanno stabilito che l’Italia può essere lo Stato di tutti coloro a cui non è consentito nei loro paesi di origine «l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana». L’art. 10 – una finestra aperta sul mondo che estende all’umanità intera il dovere di solidarietà sancito all’art. 2 – riconosce infatti a chi si trova in quelle condizioni, il diritto di essere accolto nel nostro Paese. E non toglie valore a tale affermazione di principio, il fatto che oggi essa appaia difficile da attuare.
L’Italia, in altre parole, non è uno Stato etnico, come lo è ad esempio Israele che con una legge del luglio 2018 si è autodefinito «Stato-Nazione degli ebrei», o le repubbliche della ex-Jugoslavia, come la Croazia e la Slovenia che si definiscono nelle loro Costituzioni Stati-Nazione dei rispettivi popoli. Come ha osservato l’antropologo statunitense Robert Hayden (American Ethnologist 23 (4), 1996), in uno Stato etnico lo Stato si fonda «sulla sovranità della nazione etnicamente definita». Chi non appartiene al gruppo dominante può essere quindi solo un cittadino di seconda classe, che «non può aspettarsi un pari diritto al controllo dello Stato». Uno Stato etnico, quindi, per definizione non è uno Stato democratico poiché non riconosce pari diritti a tutte le componenti della popolazione.
Parallelamente e conseguentemente, insieme al termine “cittadino”, è emarginato oggi il termine “Paese”, sostituito sempre più frequentemente – e costantemente nella bocca di Meloni e dei suoi – dal termine “nazione”. È il bene della nazione, non del Paese, l’obiettivo dichiarato dell’azione politica, e sono gli interessi della nazione, non del Paese, da tener presente in politica estera. È un processo che fa pensare a quanto accaduto nella ex-Jugoslavia, per lontani che possano sembrare i tragici sviluppi che ha avuto in quel contesto. Se lì erano prese di mira le minoranze etniche, da noi l’obiettivo sono i migranti. In Italia e non solo: siamo di fronte a un processo estremamente preoccupante che, come hanno mostrato le recenti elezioni europee, è in atto in tutto il continente.
Non a caso anche i termini “nazione” e “nazionale” furono usati con parsimonia dai Costituenti (il sostantivo compare solo tre volte nella Costituzione), e – secondo Vezio Crisafulli – per lo più con il significato di Stato-ordinamento, e una sola volta, all’art. 67, con quello di popolo. Infatti, mentre “Paese” rimanda a un territorio con tutta la sua popolazione di qualunque origine possa essere, “nazione” rimanda a una comunità in qualche misura omogenea per qualche tratto fondamentale come la lingua, la memoria di un passato comune o la religione, oppure perché si considera semplicemente tale. E chi non rientra in tale comunità viene visto come “altro”, estraneo a quel “noi”, e quindi potenzialmente oggetto di discriminazione; se non necessariamente per legge, certamente di fatto, come dimostrano costantemente le cronache trasmesse dai media.
Il campo semantico del termine “nazione” in realtà non sarebbe molto diverso da quello del termine “etnia”; vocabolo proveniente dalla letteratura antropologica e prontamente utilizzato a fini discriminatori nel linguaggio della xenofobia. Etnia e nazione – entrambe nozioni assai discusse – in realtà potrebbero essere quasi sinonimi, anche se nazione tende ad avere una caratterizzazione più politica. Ambedue i termini si riferiscono a una comunità di persone che si ritiene omogenea per un qualche fondamentale tratto comune o che comunque si sente soggettivamente di esistere in quanto tale; ma è diverso il contesto storico in cui hanno avuto origine. “Nazione”, in Occidente, ha una lunga storia, che passa per la Rivoluzione francese e continua nell’Ottocento nel contesto delle lotte di un popolo per la sua patria, con il principio di nazionalità di cui Mazzini fu apostolo in Italia, per degenerare infine nei nazionalismi novecenteschi.
Anche “etnia” ha radici antiche (dal greco classico ethnos) ma il suo significato moderno si forma nel quadro delle politiche coloniali di dominio messe in atto dalle potenze europee. ‘Nazione’ rientra quindi nella sfera della “civiltà”, mentre ‘etnia’ rimanda al primitivo e al selvaggio, o comunque al lontano da noi. Così capita di leggere o di sentir parlare di “etnia albanese”, rumena, cinese, marocchina; ma mai di etnia francese, inglese o tedesca. Etnici sono coloro da cui vogliamo distinguerci. Oggi tuttavia, nonostante la sua diversa storia, anche il termine nazione rimanda allo Stato etnico: della nazione italiana non possono far parte – è questo il corollario implicito nel termine – a pieno titolo i migranti. L’Italia deve essere la patria degli italiani e non di tutti.
Particolarmente delicata è infine la posizione del termine “patria”. La sinistra è stata accusata, e si è auto accusata, di averlo lasciato alla destra per troppo tempo. Solo con la presidenza Ciampi, abbiamo cominciato a vedere – nel mio caso, confesso, con un certo irrefrenabile fastidio per gli inevitabili echi nazionalistici – in certe occasioni simboliche i tricolori alle finestre e abbiamo visto i calciatori cantare l’inno a squarciagola all’inizio delle partite internazionali, mentre prima lo sussurravano appena. Ma è chiaro a tutti il perché: sotto il fascismo il richiamo ideologico alla patria era servito a mandare a morire in guerra migliaia e migliaia di giovani, non per difendere la patria aggredita, ma per aggredire quella altrui. Sulla facciata della palestra del mio liceo a Palermo negli anni Sessanta campeggiava – e campeggia ancora – a cubitali caratteri lapidei la seguente scritta:
«Voi soiete l’aurora della vita, siete la speranza della patria, siete soprattutto l’esercito di domani».
Si può capire, quindi, perché il mondo antifascista abbia faticato a ri-accogliere nel suo lessico la parola patria. La patria era quella che mandava a morire per la grandezza del cosiddetto impero; non quel lido accogliente che parla la tua lingua, ti racconta storie tue e dei tuoi e ti inonda della luce, dei paesaggi, dei rumori, degli odori, dei sapori che conosci. Era il cittadino – o meglio il suddito – che doveva mettersi al servizio dello Stato (soprattutto in armi, recita la scritta), e non viceversa.
Oggi, a ottant’anni dalla caduta del fascismo il termine patria sta tornando ad assumere un connotato aggressivo nei confronti di coloro che non si vuole facciano parte del nostro mondo. Patrioti si definiscono adesso – ahinoi anche formalmente a livello europeo – gli xenofobi che vogliono sbarrare la strada a chi fugge dalla fame o dalle guerre, o semplicemente aspira a una vita migliore.
Ma non potrebbe invece essere patriota chi ama sì il proprio Paese ma lo vede parte di patrie più grandi, come il Mediterraneo, l’Europa, o il pianeta intero? E si riconosce cittadino del mondo accanto ad altri miliardi di umani che hanno i suoi stessi diritti (e doveri)? Sarebbe questo il modello dell’uomo planetario – delineato da Ernesto Balducci – che unisce in sé tante identità che non servono però ad escludere ma ad accogliere, e che sa scoprire ‘l’altro’ al di là delle frontiere.
Purtroppo non è questa la direzione in cui oggi si vuole portare il nostro Paese. Ce lo dice il linguaggio della politica. Un linguaggio tipico della destra che sta subdolamente conquistando anche le altre parti politiche. Le parole sono pietre, ma questa volta non sono rivolte contro la mafia, come quelle della coraggiosa madre siciliana di cui scrisse Carlo Levi. Sono scagliate contro la Costituzione antifascista che questo governo vorrebbe smantellare.
L’autore: Augusto Cacopardo è docente di antropologia all’Università di Firenze
Illustrazione di Marilena Nardi