Sarebbe bello che qualcuno trovasse il coraggio di scriverlo che si incrociano nomi altisonanti che sottovoce confessano di non essere nella condizione di poter contraddire il potere. Sarebbe bello ricordarsi che gli intellettuali (o accontentandosi: gli operatori culturali) anticipano la Storia, ne prevedono le nefandezze, ne annusano profeticamente i bisogni e non sono i leccapiedi ludici del potere. Sarebbe bello, insomma, riconoscere che i forbiti allineati sono portavoce. Tutt’altra cosa.
Per questo anche il piccolo gesto di Tomaso Montanari merita di essere sottolineato: lo storico dell’arte ha deciso di dimettersi dal proprio ruolo di membro di commissione del Ministero dei Beni Culturali con una lettera indirizzata direttamente al ministro Franceschini.
«Abbiamo esaminato e chiuso ventiquattro complesse pratiche. – scrive Montanari nella sua lettere – Abbiamo deciso di accettare 11 proposte di cessione di beni culturali come pagamento delle imposte, per un valore totale di 2.055.396,31 euro: ma il ministero dell’Economia ci ha comunicato che il relativo capitolo dello stato di previsione della spesa prevede solo la ridicola cifra di 31.809 euro». In queste condizioni, secondo Montanari «il lavoro della commissione è del tutto inutile: o, meglio, è utile solo all’accanita propaganda che si sforza di rappresentare agli occhi degli italiani la falsa immagine di un governo sollecito verso il bene del patrimonio culturale. Poiché io, al contrario, ritengo che alcune leggi e ‘riforme’ promosse dall’attuale Governo (..) e da Lei (…) siano una grave minaccia per la ‘tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione’, non ho alcuna intenzione di prestare il mio lavoro e la mia competenza a quella propaganda».
Ecco, io, non so voi, quando l’ho letta ho pensato che ce ne vorrebbero, forse, di Montanari.
Buon giovedì.










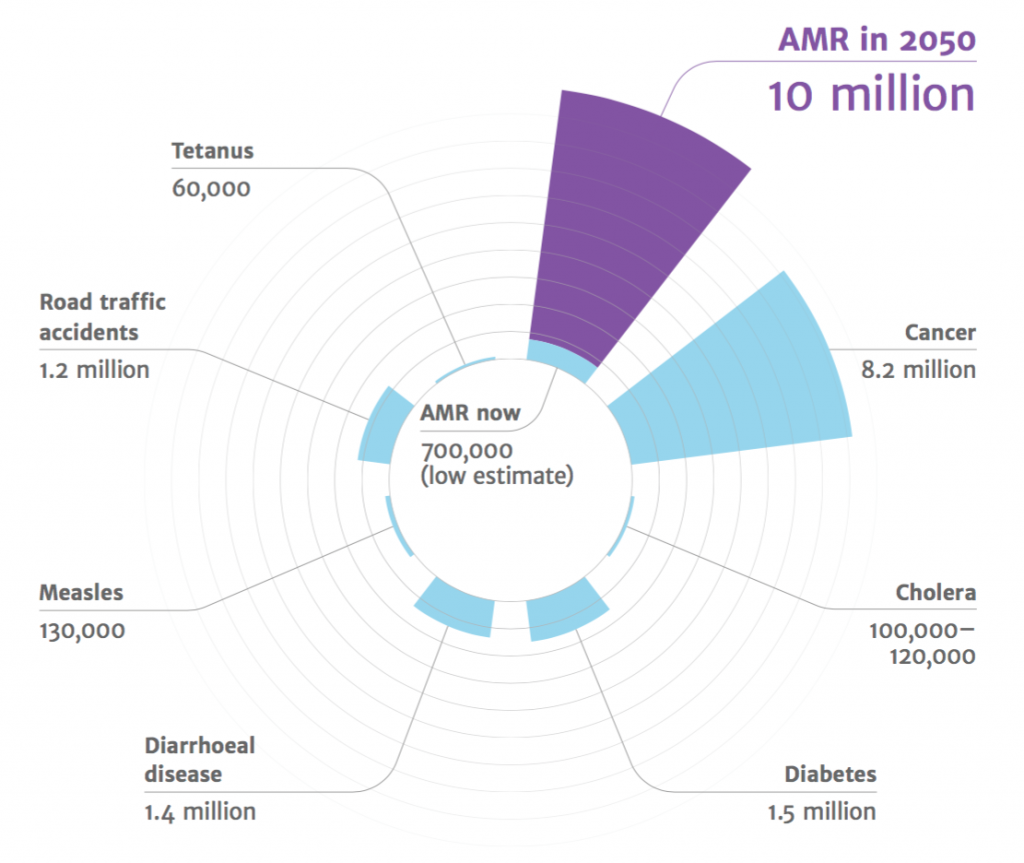


 Nella mostra romana curata dalla professoressa Rossella Menegazzo, docente di Storia dell’Arte dell’Asia Orientale all’Università degli Studi di Milano e dal Maestro Takeshi Fujimori, direttore artistico del Ken Domon Museum of Photography ci sono i primi scatti, realizzati prima e durante la seconda guerra mondiale, in cui Domon Ken cercava di destreggiarsi fra foto giornalismo e propaganda. Poi l’immane tragedia di Hiroshima e il suo lavoro diventa coraggioso, intenso, altamente drammatico sotto l’eleganza e il pudore, mai formale, che si coglie al primo sguardo.
Nella mostra romana curata dalla professoressa Rossella Menegazzo, docente di Storia dell’Arte dell’Asia Orientale all’Università degli Studi di Milano e dal Maestro Takeshi Fujimori, direttore artistico del Ken Domon Museum of Photography ci sono i primi scatti, realizzati prima e durante la seconda guerra mondiale, in cui Domon Ken cercava di destreggiarsi fra foto giornalismo e propaganda. Poi l’immane tragedia di Hiroshima e il suo lavoro diventa coraggioso, intenso, altamente drammatico sotto l’eleganza e il pudore, mai formale, che si coglie al primo sguardo.  In mostra c’è Hiroshima (1958) foto che ha fatto la storia e che uno scrittore come il Nobel Kenzaburo Oe ha giudicato come più importante di un libro di storia. E poi ecco i Bambini di Chikuho, scatti realizzati nei villaggi di minatori, con ritratti indimenticabili di bambini di strada. Ma affascinanti sono anche le foto che raccontano un Giappone di signorine eleganti in cerca di amore. Con lo splendido doppio ritratto di profilo che ricorda Hiroshima mon amour di Resnais. Una certa allure francese di alcune di queste immagini ha fatto scrivere ad alcuni critici che Domon Ken è il Cartier- Bresson giapponese. La mostra all’Ara pacis presenta anche la parte dell’opera di Domon Ken dedicata alla tradizione culturale giapponese, quella del teatro No, in primis, con le sue splendide maschere astratte e quella buddista, con una serie di lussureggianti fotografie rosse e oro, scattate all’interno di templi.
In mostra c’è Hiroshima (1958) foto che ha fatto la storia e che uno scrittore come il Nobel Kenzaburo Oe ha giudicato come più importante di un libro di storia. E poi ecco i Bambini di Chikuho, scatti realizzati nei villaggi di minatori, con ritratti indimenticabili di bambini di strada. Ma affascinanti sono anche le foto che raccontano un Giappone di signorine eleganti in cerca di amore. Con lo splendido doppio ritratto di profilo che ricorda Hiroshima mon amour di Resnais. Una certa allure francese di alcune di queste immagini ha fatto scrivere ad alcuni critici che Domon Ken è il Cartier- Bresson giapponese. La mostra all’Ara pacis presenta anche la parte dell’opera di Domon Ken dedicata alla tradizione culturale giapponese, quella del teatro No, in primis, con le sue splendide maschere astratte e quella buddista, con una serie di lussureggianti fotografie rosse e oro, scattate all’interno di templi.









