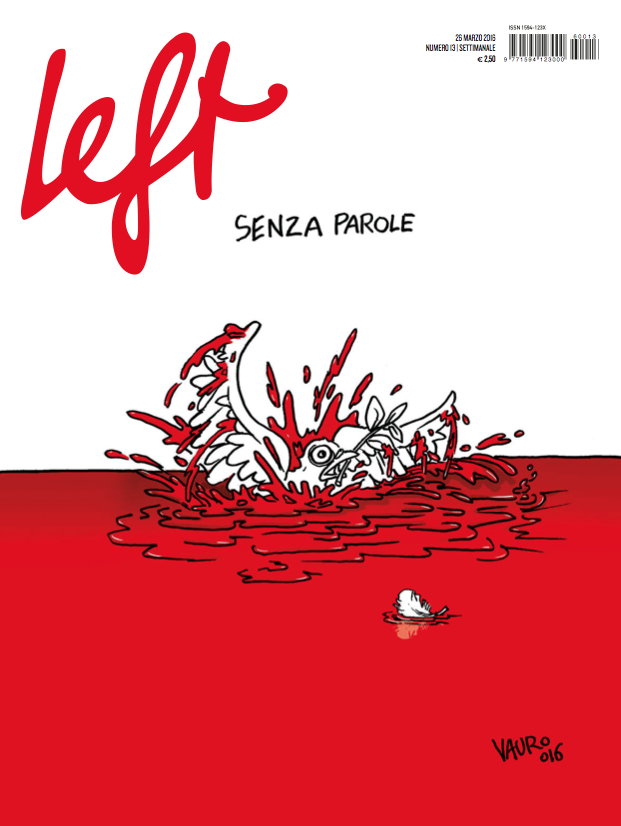Ripubblichiamo questo articolo su gentile concessione di Cronache di ordinario razzismo, sito di informazione, approfondimento e comunicazione specificamente dedicato al fenomeno del razzismo curato da Lunaria.
I Cie vanno eliminati. Non si può riformare un luogo di distruzione della dignità umana. Vanno chiusi, perché sono lo strumento di un sistema più ampio di controllo sociale, di alienazione dell’essere umano e della sua realizzazione personale.
Quello che sono lo abbiamo detto e denunciato tante volte: luoghi dove persone che non hanno i documenti di soggiorno – o li avevano e non sono riusciti a rinnovarli, a volte per via della perdita del lavoro, altre per la conclusione di un ciclo di studi..- vengono trattenute formalmente per un tempo massimo di tre mesi, periodo in cui le istituzioni dovranno identificarle e espellerle dal territorio italiano. Il tutto in un contesto di privazione e alienazione. Raccontarlo è una cosa, viverci è un’altra.
Il Cie di Ponte Galeria è avvolto dallo sconforto. Ci entriamo mercoledì 23 marzo, con una delegazione della campagna LasciateCIEntrare. «Qua certo non si muore di fame. Ci danno il cibo. Vengono gli operatori a pulire per terra. Ci danno dei buoni da 5 euro da spendere all’interno del centro per avere le ricariche telefoniche, a chi fuma danno le sigarette. Non possiamo dire che ci trattano male: ma manca la dignità. La dignità che ti da l’essere autonomi, lavorare, badare a se stessi e agli altri». Così O., una signora russa di circa cinquant’anni, nel Cie da due settimane. Vive in Italia da anni, a Sanremo, dove lavorava per una famiglia come collaboratrice domestica. Senza documenti (e quindi anche senza contratto). «Non sono mai riuscita a rientrare nel sistema di quote», spiega. L’hanno fermata dei poliziotti in borghese e ora è nel Cie in attesa dell’espulsione. Quello che afferma O. si palesa nei movimenti lenti e ciondolanti delle donne detenute nel Cie, dal letto alla panca di metallo al cortile, dal cortile alla panca di metallo al letto. Sono i gesti di chi da un momento all’altro è stato privato della propria quotidianità e chiuso in una struttura detentiva, senza nemmeno aver capito bene cosa stia succedendo.
«Io sono venuta in Italia per sposarmi, con un visto turistico. Allo scadere del visto non avevo ancora tutte le carte necessarie per il matrimonio, e non sono riuscita a organizzarmi in tempo per rincasare. In questo periodo in Italia, ho lavorato per circa un mese con un signore, che alla fine non mi ha pagata. Sono andata alla polizia per denunciarlo.. e mi hanno portata qua. Gli ho detto che avevo avuto questi problemi, che mi stavo organizzando per prendere il volo e tornare a casa, e che me ne sarei andata a breve io. Mi hanno risposto che dovevo stare in un centro, da dove mi avrebbero rimandata a casa. Ma questo non è un centro, è un carcere. Il mio compagno si è spaventato quando è venuto a trovarmi, da Napoli, e non ci hanno nemmeno fatti incontrare». A parlare è S., una donna cubana. Anche lei sottolinea che nel Cie di Ponte Galeria«ci danno da mangiare, non ci maltrattano. Però questo è un carcere. Guarda come viviamo».
Come vivono, le persone dentro al Cie di Ponte Galeria? Saperlo non è così facile perché così come le persone non possono uscire, nessuno può entrare, almeno non liberamente. Si deve fare richiesta alla Prefettura, che deve dare l’autorizzazione, come in tutti i Cie (alcune risposte sono contenute nei dossier di LasciateCIEntrare Accogliere:la vera emergenza, e inCAStrati). E non sempre succede.
Dentro a Ponte Galeria nel primo cortile ci sono molte automobili della polizia, della guardia di finanza, dei carabinieri, anche dell’esercito. Intorno, sbarre. Si entra, e c’è il primo controllo della polizia. Intorno, uffici. Passato un corridoio con uffici a destra e sinistra, si entra – attraverso porte a scatto automatico aperte per mezzo di tessere – in un atrio circondato da sbarre. Da li, tramite una porta – composta da sbarre – si accede a due cortili, entrambi circondati da alte sbarre e totalmente vuoti, fatta eccezione per alcune panche e tavoli di metallo.
Dai cortili si entra nelle stanze e nei bagni: sconfortanti strutture di muratura. Solo i disegni e le frasi scritte dalle trattenute sulle pareti interrompono lo squallore del grigio del cemento e delle sbarre, entrambi leit motiv del Cie. “Jesus help us”, scritte in arabo, il disegno di una tigre con a fianco una scritta cinese, “Infami”, “La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto” (una frase tratta da una canzone degli Assalti Frontali). Tra le sbarre le detenute legano lunghe corde su cui stendono gli abiti. Le stanze sono vuote: ci sono solo i letti, brandine di metallo con sopra un sottile materasso di gommapiuma, e una coperta di lana marrone, logora.
Le lenzuola non sono di cotone, ma sintetiche: sembrano di carta, esattamente come gli asciugamani contenuti nel kit che viene dato alle donne ogni 3/4 giorni, insieme a confezioni monodose di sapone. Le stesse lenzuola vengono utilizzate dalle donne per creare delle tende alle docce, prive di porte. I bagni se possibile sono ancora più squallidi delle stanze, oltre a non garantire alcun tipo di privacy e a non avere riscaldamento. Che non è assicurato nemmeno nelle stanze, provviste di un condizionatore che spesso non funziona. Le finestre sono coperte dalle lenzuola per non far entrare la luce ma soprattutto il freddo.
In questo contesto le persone stazionano anche per mesi, senza la possibilità di fare nulla, confinate in una sorta di limbo che le esclude dalla società, anche fisicamente. I Cie sorgono lontano dai centri abitati, e dagli sguardi delle persone. In effetti non si deve mostrare troppo una struttura in cui le persone vengono private della propria libertà ed espulse dal territorio nazionale contro la propria volontà, e mantenute nel frattempo in condizioni indegne, e in uno stato di totale inerzia e assistenzialismo.
Le problematiche all’interno dei Cie sono molte, e possono variare da struttura a struttura e da periodo a periodo: generalmente, si riscontra una grave carenza di mediatori, di assistenza legale e sanitaria. Le segnalazioni a proposito delle violazioni dei diritti umani all’interno dei Centri di identificazione ed espulsione sono moltissime, e non mancano i casi di suicidio. Le frequenti proteste portate avanti dai detenuti in tutte le strutture d’Italia denunciano la pesante condizione che si vive all’interno di questi centri, spesso chiusi proprio in seguito e grazie alle manifestazioni delle persone trattenute – esattamente come è successo per la parte maschile del Cie di Ponte Galeria, chiuso dopo una rivolta avvenuta lo scorso gennaio, e ad oggi fortunatamente ancora inagibile.
Ciononostante, il totale smantellamento del sistema di identificazione ed espulsione non sembra vicino. Anzi, c’è il serio pericolo che si ampli, in particolare dopo le sollecitazioni europee circa la necessità di identificare ed espellere più velocemente (per cui l’Europa chiede la rapida attivazione degli hotspot, di fatto altri centri di identificazione).
«Sono dentro da cinque mesi. Sto impazzendo. Non riesco a dormire, non mangio. Penso in continuazione. Perché sono qui? Che fine farò? Ho fatto richiesta di protezione internazionale, ho avuto il diniego e ho presentato ricorso». Sono le parole di J., una giovane donna nigeriana. «Alle mie domande nessuno mi da risposte: devo aspettare, sempre. Intanto non posso fare nulla, guarda intorno, non c’è niente! Siamo tra le sbarre, senza aver fatto niente».