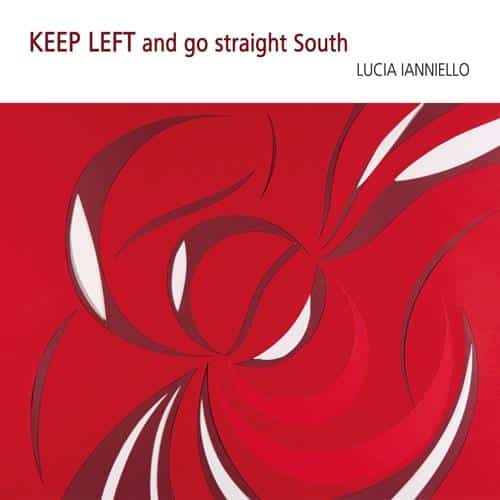In Africa è in corso un cambiamento profondo, inarrestabile e rivoluzionario. Le parole chiave che lo connotano sono resilienza, emancipazione e determinazione. I protagonisti sono i giovani e le giovani africane, queste ultime in particolare impegnate per un futuro sostenibile. Ma i media italiani purtroppo continuano a raccontare principalmente l’Africa come un luogo privo di speranza e pieno di problemi, come emerge dalla V edizione de L’Africa MEDIAta, il rapporto presentato a Roma da Amref Health Africa-Italia per l’Africa Day. Curato dall’Osservatorio di Pavia, ha l’obiettivo di analizzare come e quanto i media italiani raccontino l’Africa. Un tratto di continuità accompagna tutte le edizioni del rapporto: la marginalità della comunicazione sull’Africa e sulle persone africane e afrodiscendenti nei media mainstream.

Quest’anno all’interno del report vi è un focus specifico sulla rappresentazione mediatica e sulla presenza nei social network dell’attivismo giovanile africano, in particolare della sua componente femminile. Purtroppo, di attiviste e attivisti africani nei media italiani però si parla davvero con il contagocce. Un dato su tutti lo testimonia: del totale degli intervistati nei telegiornali di prima serata (50.573), vi è appena 1 attivista africano ogni 919 persone, ovvero lo 0,1% di presenza complessiva. Se consideriamo invece solo le attiviste africane sul totale dei soggetti interpellati nei Tg, la situazione peggiora poiché, in media, compare una attivista africana ogni 4200 intervistati. Un numero evidentemente ai confini dell’invisibilità.
Eppure, l’Africa rappresenta la gioventù, per eccellenza. Il 70% degli 1,8 miliardi di giovani di tutto il mondo vive nei territori dell’Africa subsahariana. Proporzione che nei prossimi decenni si manterrà, anzi crescerà: le proiezioni al 2050 prevedono che la popolazione del continente africano sarà la più grande e la più giovane del mondo e si presume che il numero di giovani in Africa sarà dieci volte più grande rispetto a quello dell’Unione europea.
Una composizione anagrafica speciale quella africana, da maneggiare con cura. Una così consistente presenza di giovani nella società rappresenta innanzitutto una sfida: dobbiamo trovare i giusti driver per supportarli, per aiutarli a liberare il loro grande potenziale, per promuoverne la consapevolezza e la partecipazione. Ed è ovviamente anche un’opportunità, enorme e rivoluzionaria: non dobbiamo lasciarci sfuggire l’occasione di orientare tutta questa energia, creatività e voglia di cambiamento per favorire finalmente uno sviluppo sostenibile e condiviso.
In un panorama in cui il Continente è spinto con vigore dalla sua gioventù verso il cambiamento, c’è un gruppo in particolare che sta lottando con maggiore tenacia e determinazione: sono le ragazze. Le barriere contro le quali si stanno ancora scontrando sono di tipo sociale, economico e politico, e sono radicate nel tempo, nella tradizione, nelle famiglie. La piaga della violenza di genere è ancora profonda: le giovani donne africane devono fronteggiare abusi domestici, molestie sessuali e pratiche altamente lesive come le mutilazioni genitali femminili. Per molte l’emancipazione e l’indipendenza economica sono ancora chimere, obiettivi lontani e difficili da raggiungere a causa delle disparità salariali, dell’accesso limitato al credito e delle varie forme di discriminazione che subiscono sul posto di lavoro. Le diseguaglianze di genere si riscontrano chiaramente anche in politica: il diritto al voto, attivo e passivo, risente fortemente dell’impostazione patriarcale e l’opportunità di partecipare alla vita politica rimane spesso solo sulla carta. Sono infatti poche le donne in politica – ostacolate da leggi discriminanti, da risorse economiche limitate e da supporti sociali traballanti – e di frequente messe a tacere da norme culturali difficili da estirpare.

Si tratta evidentemente di un quadro complesso, ancora ricco di contraddizioni, ma inesorabilmente e fortunatamente in fermento. I limiti e le difficoltà non riescono ad arginare la forza e l’energia di queste e questi giovani, desiderosi di guidare il proprio Continente verso una nuova era, all’insegna dei diritti. La salute rappresenta certamente un determinante imprescindibile di questo cambiamento, in particolare quando parliamo di diritti di genere. Amref è la più grande organizzazione sanitaria africana e si impegna a migliorare la vita delle comunità e a potenziare i sistemi sanitari in tutto il Continente, riconoscendo il ruolo cruciale dei giovani e delle donne per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Uno dei pillar della strategia globale di Amref si fonda proprio sulle parole chiave salute – donne – giovani e si sviluppa attraverso programmi innovativi e partnership speciali. Amref negli anni è diventata una vera e propria piattaforma a disposizione delle e dei giovani attivisti.
A prescindere dalle tante sfide che si trovano ad affrontare, i giovani africani sono intenzionati a cambiare il futuro dell’Africa. È importante ricordare che i giovani non sono i leader del futuro, ma sono i leader di oggi. È importante che sia data ai giovani la possibilità di esprimersi e far sentire la propria voce ed è soprattutto necessario investire sui giovani come partner dello sviluppo, non come meri beneficiari. È la leadership intergenerazionale che può permettere la sostenibilità dell’Africa e del mondo intero.
 L’autrice: Bitania Lulu Berhanu è direttrice programma Youth in Action (Y-ACT) Amref Health Africa
L’autrice: Bitania Lulu Berhanu è direttrice programma Youth in Action (Y-ACT) Amref Health Africa







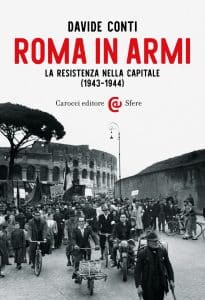





 Festival Encuentro, evento in collaborazione con left
Festival Encuentro, evento in collaborazione con left