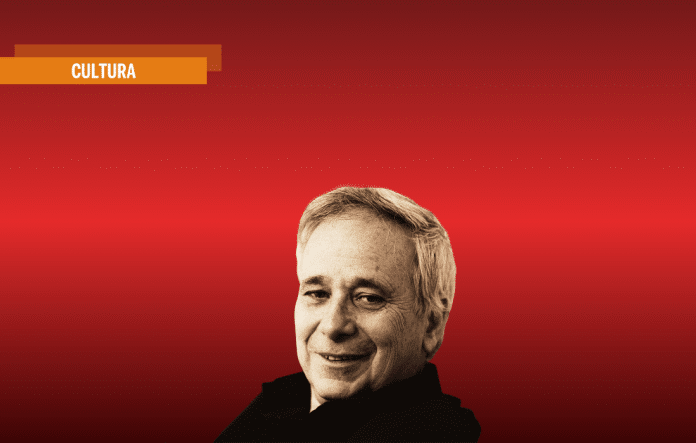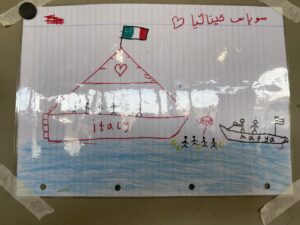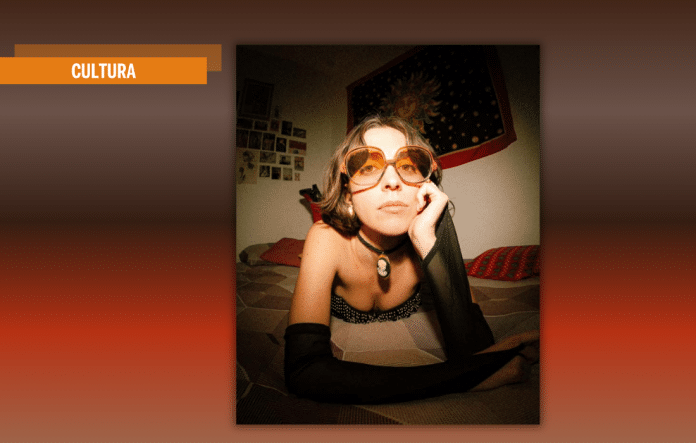Nel processo politico il confronto tra idee diverse viene affermato essere ciò che permette la nascita di nuove possibilità di sviluppo di una società.
Il confronto è dialettica, orale e scritta. Lo scopo è convincere con le proprie argomentazioni chi ascolta, con l’idea che questi poi sosterrà la posizione politica in una votazione o in una ulteriore discussione altrove. Gli argomenti della discussione politica sono evidentemente tutto ciò che riguarda il vivere insieme, il progettare il futuro, il migliorare le condizioni di vita, il gestire tutto ciò che può essere lesivo del benessere e tutto ciò che è migliorativo del benessere. Ma l’oggetto della politica sappiamo tutti che non è in realtà la semplice amministrazione della cosa pubblica.
È evidente che l’idea di fondo di ogni idea o movimento politico si riferisce sempre ad un’idea più o meno consapevole di cosa sia un essere umano e di conseguenza di quale sia una politica che vada a “vantaggio” di quell’idea di essere umano. Al fondo possiamo dire che sono le diverse concezioni di cosa sia un essere umano che fanno le diverse idee politiche. La concretezza della decisione e dell’azione politica è una manifestazione di quel pensiero. Una politica contro l’aborto avrà una ben precisa idea di donna e di relazione tra donna e uomo che la sostiene così come d’altra parte una politica a favore dell’aborto avrà un’altra idea di ciò. E non è necessario che queste idee siano palesate esplicitamente. La gran parte della politica esprime le proprie idee sull’essere umano senza “dirle” esplicitamente ma lasciandole intendere tramite l’azione politica. Se il ministero dell’Istruzione diventa anche “del Merito” si intende che c’è un’idea di competitività naturale tra gli esseri umani che deve essere valorizzata.
D’altra parte una sanità che sia pubblica e universale, che non consideri il censo o la situazione personale del paziente, che faccia sì che chiunque, che sia un clochard o un broker di borsa, possa avere accesso a cure sofisticate e costose, realizza e comunica un’idea di essere umano in un certo modo. Così come al contrario, una privatizzazione estrema della sanità, comunica un’altra idea di essere umano, un’idea per la quale avere successo economico e quindi potersi permettere le cure mediche significa essere dei prescelti, dal destino, da un’ascendenza o da dio, a seconda del tipo di approccio filosofico dei sostenitori di tale impostazione. Allora quale che sia la concezione dell’umano, essa è il contenuto della politica di chi ha il potere in un determinato momento storico.
Dobbiamo essere grati alla Rivoluzione francese e a Napoleone se è stata messa a punto un’idea dello Stato per cui la politica deve muoversi all’interno di una struttura di istituzioni che lo governano in cui ogni idea può esprimersi a condizione di non mettere in crisi la stessa struttura istituzionale. Sappiamo dalla storia che questa struttura è valida e permette uno sviluppo intellettuale ed economico straordinario. Ma la storia ci dice anche che questa struttura di per sé non è sufficiente a contenere la politica quando essa diventa violenta. Qualcosa si rompe, si vuole andare oltre, si creano spaccature nel confronto culturale e politico per cui non c’è più possibilità di recuperare un vivere insieme accettando di non pensare l’umano tutti allo stesso modo.
Quale che sia l’origine del pensiero politico esso produrrà azione politica che influisce sul vivere sociale nel senso di affermare quell’idea di umano che viene proposta più o meno latentemente. Conseguentemente sarebbe compito di chi voglia veramente fare politica approfondire la ricerca sull’essere umano, su cosa sia veramente e su cosa lo muova. Che non si dia frettolosamente per scontato che sappiamo tutto e che non c’è alcun dubbio su cosa esso sia. Ovvero, e più regressivamente ancora, che non si dia per scontato che non sia possibile studiare, sapere e conoscere cosa sia l’essere umano.
La conoscenza scientifica ha permesso di sapere pressoché tutto della fisiologia e biologia umana. Per cui sappiamo perfettamente quali sono i bisogni essenziali di ogni essere umano nelle sue diverse fasi di vita, da bambino, adulto e poi anziano. Sappiamo esattamente cosa sia necessario affinché il corpo si sviluppi forte e sano. Sappiamo come fare in modo che si viva a lungo, abbiamo strumenti per combattere malattie che nella storia hanno fatto milioni di vittime. L’evidenza scientifica dei bisogni degli esseri umani rende lo scontro politico rispetto ad essi la fiera dell’ovvio. Sarebbe da andare oltre a questo. Perché certamente l’essere umano ha bisogni ma altrettanto certamente l’essere umano non è soltanto questo!
E qui entriamo nel merito politico che mi interessa: se la sinistra si ostina a contestare soltanto bisogni non riconosciuti e non sviluppa un pensiero su tutto il resto che fa la specificità umana, lascia campo libero alle altre forze politiche per affermare idee di umano che di umano non hanno proprio nulla. Così come non si può in nessun modo accettare che la sinistra pensi che tutto ciò che non è bisogno sia dominio della religione e che vada bene tutto ciò che essa sostiene. In questo modo si rinuncia ad ogni ricerca su ciò che è la mente e il pensiero umano e di conseguenza si rinuncia a fare una Politica che sia realmente nuova e soprattutto umana! Perché se è il pensiero religioso “la verità”, allora perché complicarsi la vita… votiamo per una teocrazia e abbiamo risolto!
Vediamo allora di delineare come fare questa ricerca andando a guardare nel pensiero sull’uomo. Grossolanamente possiamo dire che c’è una distinzione di fondo tra pensiero politico che ha un pensiero negativo dell’agire umano oppure il contrario. Se pensiamo all’essere umano come intrinsecamente cattivo (con il peccato originale, il nulla originario o il caos di pulsioni parziali) la conseguenza politica necessaria è pensare ad un potere, ad una forza materiale, che contenga queste le pulsioni negative e violente degli esseri umani. Dio, patria, padre, famiglia, strutture che possano contenere il pensiero inevitabilmente violento di chi altrimenti si troverebbe a uccidere il prossimo. Perché la violenza e il dominio dell’uno sull’altro sarebbe la realtà ineluttabile e naturale degli esseri umani. Realtà che si può forse contenere e modificare con l’educazione, la ragione e il comportamento. Dall’altro canto c’è (o dovrebbe esserci) una cultura e poi una Politica che invece ha un pensiero positivo rispetto all’agire umano, un pensiero che sappia di una fantasia spontanea e originaria dell’essere umano il cui contenuto è un pensiero di voler stare insieme agli altri. Un pensiero che vede bene senza farsi confondere e sa bene che la violenza umana può esistere e quando questo accade non è per una naturale realtà violenta degli esseri umani ma perché c’è una storia individuale in cui è esistita una socialità non sana che ha determinato l’emergere di quella violenza.
Un pensiero e una politica che rinuncia alla cecità del dire che esiste il Male per spiegare le tragedie del mondo, cercando un sapere scientifico, una conoscenza dell’essere umano che permetta di vedere e di capire quando e soprattutto come l’umano perde la sensibilità e gli affetti e diventa violento verso i suoi simili perché crede che non siano più uguali a lui. Nata dalla Rivoluzione Francese, la sinistra si è sempre battuta per i bisogni negati e ha sempre avuto un’idea ottimistica del futuro dell’essere umano. La rivoluzione scientifica, la scoperta di nuovi mondi e di popoli lontani, liberi dal pensiero religioso, le possibilità di sviluppo e ricchezza create dalla tecnologia ha fatto ipotizzare ai più brillanti filosofi che potesse esistere un possibile benessere per tutti. Hanno pensato ad una socialità naturale e originaria. Ha fatto pensare che potesse esistere una società ideale di uguali. Purtroppo avevano pensato solo in termini materiali e si erano dimenticati delle donne e dei bambini. La politica era cosa da uomini… Ma poi il tempo è passato, tante menti geniali hanno scoperto molto e hanno creato molto, e forse ci hanno detto che gli esseri umani sono più della loro materialità.
Ma non è stato sufficiente. Ci sono state due guerre mondiali e altre centinaia di guerre più piccole. Il grande benessere e la grande ricchezza non sono state sufficienti per evitare lo scontro fisico, la “soluzione finale” dell’eliminazione fisica dell’avversario politico/religioso/economico/militare. C’è qualcosa di nascosto e sfuggente, qualcosa di invisibile nella mente che rende la ricerca dell’uomo nuovo, della sua libertà e della società ideale qualcosa di così complesso da sembrare impossibile.
Che cos’è quell’invisibile? Dove sta? È un conflitto intrapsichico? Oppure un qualche tipo di alleanza con il “nemico”? E chi sarebbe poi questo nemico? Viviamo tempi strani e difficili. Le ideologie costruite dalle menti eccelse dei secoli passati sembrano ormai non avere più alcun valore. Le parole e il loro significato vengono decostruite e rimesse insieme ad affermare significati opposti al precedente. È difficile rimanere calmi e non arrabbiarsi per il continuo chiasso di tanti che affermano di avere la verità imponendola agli altri.
È un’epoca dittatoriale, in ogni campo. Ci sono dittatori per ogni uso, in ogni attività. Persone che avrebbero la verità in tasca per risolvere qualunque problema. Il metro del successo è l’accumulazione economica. Più si ha, o meglio più si accumula, più si è, e più si è “buoni” e più si può essere dittatori. Persone che si propongono come ideale per altri e che a loro volta hanno ideali cui aspirano, altri dittatori più grandi di loro. Il rapporto con gli altri non c’è più, si tratta solo di dominio. Rapporto sadomasochistico? O peggio, proporre uno specchio? Viene proposta un’identità fasulla che permette di non pensare, di non angosciarsi in questi tempi in cui le minacce tra gli stati somigliano a quelle dei secoli scorsi, come se ci fossimo dimenticati di cosa sono state due guerre mondiali con l’invenzione della bomba atomica, l’arma che non può e non deve essere mai usata. Pensavamo di esserci allontanati, perlomeno come ambizione e come diritto internazionale, da rapporti tra Stati che fossero solo di forza. Invece no, siamo ancora là. E siamo ancora sulla stessa retorica dello spazio vitale, del territorio, dell’“italianità” o “americanità” o nazionalità qualsiasi che farebbe l’identità umana diversa dalle altre. La razza. La scienza che ha scoperto il Dna che tutti sanno definisce l’umano e che permette la riproduzione tra persone di nazionalità diverse non sa come spiegare che non c’è alcuna razza.
Perché la scienza non sa spiegare perché alcuni decidono di non pensare e preferiscono credere alla favola del “popolo prescelto” invece di studiare e comprendere la biologia umana. Il non voler vedere, voluto e cercato da questa politica, è talmente assoluto che mette in discussione anche la realtà materiale e quindi la conoscenza scientifica.
Ed ecco che i vaccini o la tachipirina determinano l’autismo, il cambiamento climatico non esiste e che la terra in realtà è piatta… Per contrastare questo impazzimento di rapporto con la realtà è necessario che le forze politiche progressiste ripartano dalle basi. È necessario interrogarsi e chiedersi da dove viene e come si sviluppa questo impazzimento totale per cui si nega senza alcun problema realtà evidenti, si modifica il linguaggio e si spacciano bugie per verità. Sono cose che abbiamo denunciato più volte su Left, in riferimento all’allora nuovo governo Meloni, con una copertina che faceva riferimento a 1984 di Orwell: la deformazione del linguaggio per manipolare le menti. Lo stesso processo, amplificato e reso ancora più terrificante dalla dimensione e potenza del paese, sta avvenendo con Trump. È necessario comprendere per potersi opporre in maniera efficace. È necessario comprendere cosa è che determina la violenza, cosa è l’odio e cosa è la rabbia. Non si può dire che è il Male che determina le guerre! Perché ciò significa rinunciare ad ogni ricerca e dire che gli esseri umani sono così e basta…
Così come dire “clima d’odio” non spiega nulla ed è fondamentalmente sbagliato. Il clima semmai è di paura e in alcuni casi di rabbia.
Bisogna vedere che la violenza, quella terribile che uccide, compare quando anche l’odio e la rabbia non ci sono più. Quando si perde ogni affetto e il pensiero diventa lucido e freddo. Quando la morte dell’altro è l’inevitabile unico “pensiero” rimasto come rapporto con l’altro. Fenomeno evidentissimo nella popolazione israeliana quando gli viene chiesto cosa pensano del genocidio dei palestinesi realizzato dal loro Paese. Ci sono gli strumenti per comprendere. Dobbiamo studiare e capire quello che succede. Dobbiamo proporre strade alternative e nuove. Dobbiamo comprendere che cos’è la realtà umana. E dobbiamo farlo insieme, adesso! E dobbiamo farlo insieme adesso!