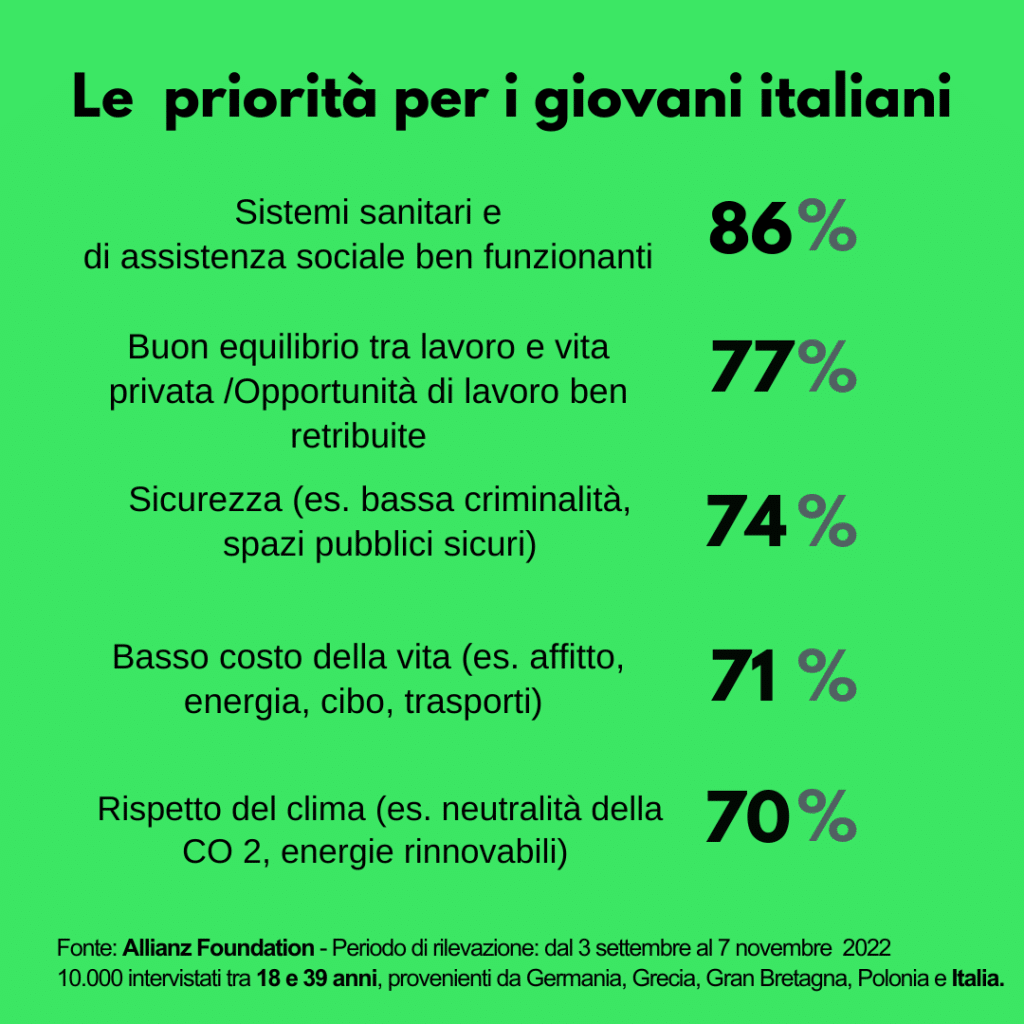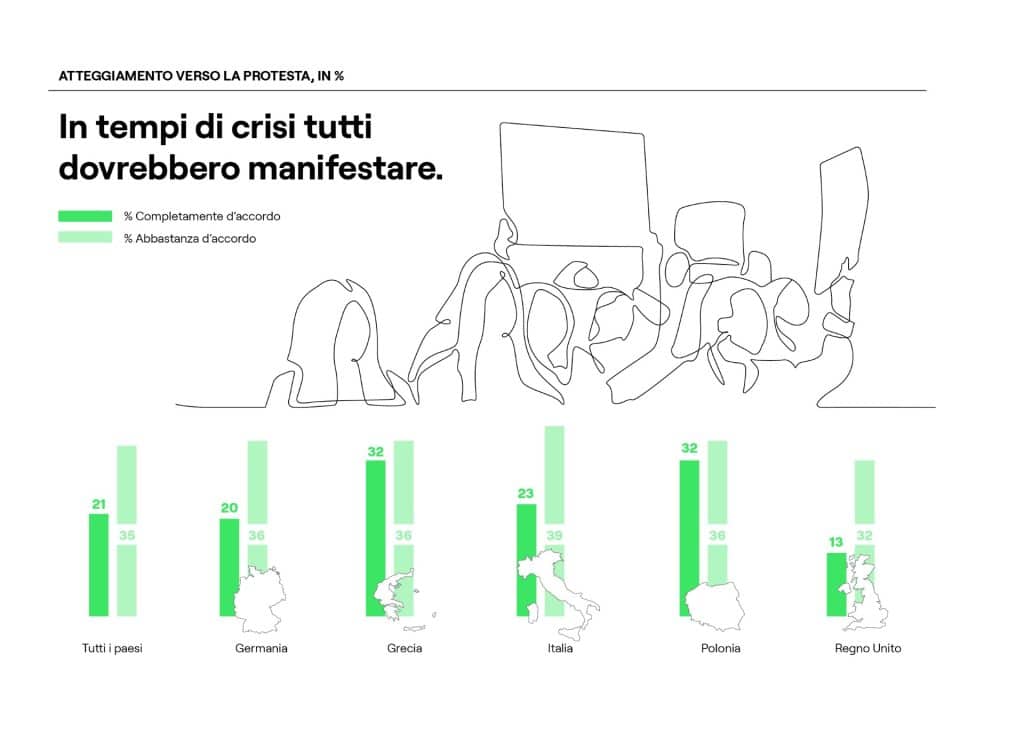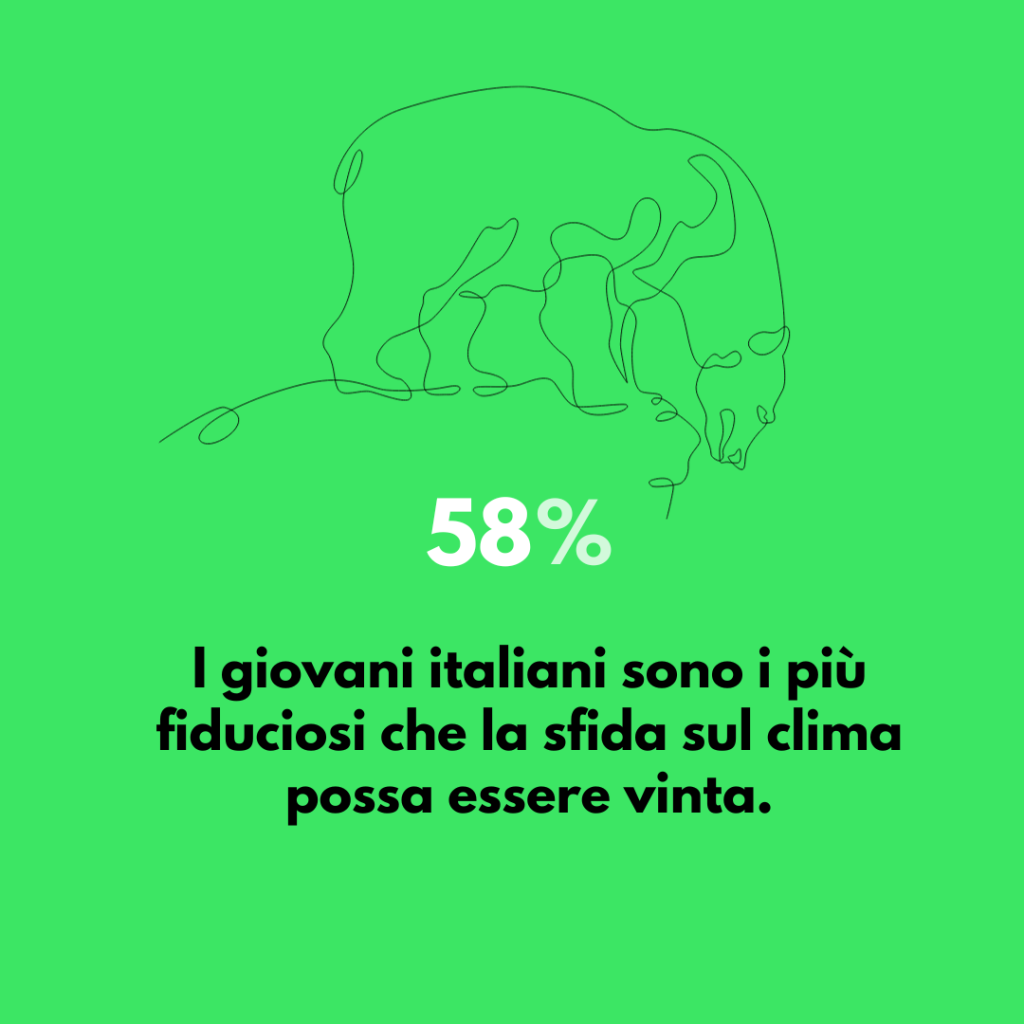Al di là dei suoi esiti, nel 1917 la Rivoluzione d’ottobre simboleggia perfettamente il codice della rivoluzione novecentesca, l’idea cioè – diversamente da quelle che l’avevano preceduta e che avevano investito di volta in volta il terreno culturale, religioso e scientifico – di avere come compito una trasformazione radicale della società, uscendo dal modello di produzione e consumo esistente – quello capitalistico – per fondarne uno completamente nuovo: una rivoluzione proletaria.
Si ridisegna quindi il mondo politico e sociale. Come diceva uno dei protagonisti del secolo, Karl Marx, fino ad allora il compito della filosofia era stato quello di capire il mondo, da lì in poi quello di cambiarlo.
Da questo slittamento di paradigma si susseguono molte rivoluzioni, ma per comprenderne fino in fondo la matrice è necessario mettere a fuoco il grande cambiamento ideologico del ‘900, quello che negli auspici, nelle intenzioni, si configurava come una vera e propria scalata al cielo: il concetto degli ultimi che divengono primi, l’idea che la società capitalistica fondata sul profitto che espropria i lavoratori e le lavoratrici della loro stessa esistenza venga rovesciata e che questi ultimi si affranchino da ogni forma di sfruttamento e di alienazione, liberando con sé il mondo intero.
Un orizzonte enorme mai auspicato in precedenza e la politica provvede a questa idea rivoluzionaria quale sostanza storica configurabile per un lungo periodo. Il rovesciamento della società e dell’ordine esistente, il mutamento dei rapporti di classe con la liberazione degli oppressi. In questo cammino si inscrivono moltissime vicende, dalla Rivoluzione d’ottobre fino alla Cina di Mao Tse-tung e, negli anni più recenti, la Cuba di Castro. Ci sono stati momenti in cui tre quarti dell’umanità andavano sotto regimi che si sono chiamati post-rivoluzionari. Per la prima volta nasce una società senza proprietà privata, cosa oggi quasi inimmaginabile, in cui tutte le forme di organizzazione sono pubbliche – in realtà statuali – con un primo slittamento dall’originale interpretazione marxiana che dalla socializzazione passa alla statalizzazione dei mezzi di produzione, problema che poi si rivelerà alla base di una impossibilità di soluzione.
Tuttavia, come sappiamo, questa rivoluzione, soprattutto nella sua capitale cioè l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, fallisce il compito storico: la nuova società nata per la liberazione si rivela anche portatrice di oppressione. Malgrado questo però quell’idea si rianima nel mondo in forme diverse: nella decolonizzazione ad esempio, nelle grandi lotte d’indipendenza, nelle rivoluzioni in Sud America a partire a quella del castrismo – solo per dare un’idea di come l’esperienza rivoluzionaria abbia lasciato un segno profondo nella storia del ‘900.
Interprete di questo sogno naufragato era stato il movimento operaio occidentale. In Europa a est c’era stata la Rivoluzione d’ottobre, mentre a ovest dai primi del ‘900 si era verificata una lunga ascesa delle masse proletarie per il riconoscimento della dignità, dei diritti, per l’uscita dalla povertà e dalla miseria, per la conquista di un potere per i lavoratori dentro e fuori dalla fabbrica. Un afflato che disegna il secolo intero fino all’ultimo grande sussulto della rivoluzione proletaria, quando durante il biennio rosso del ‘68 e ‘69 in Italia e nel Maggio francese si verifica il singolare incontro tra una generazione in lotta, quella degli studenti, e la rivolta operaia.
Si è discusso molto se questo secondo ciclo si possa propriamente chiamare rivoluzionario. In Europa in politica ha preso nomi diversi: comunista, socialista, laburista, termini diversi che tuttavia hanno lasciato il problema irrisolto. Una suggestione si può ricavare dalla formula che uno studioso francese del movimento operaio usò per definire una componente della sinistra italiana: riformista rivoluzionaria. Un’idea che si affaccia diffusamente negli anni 70, per la quale si può pensare a una trasformazione della società che preceda la conquista del potere invece di seguirla, anche sulla base della lezione appresa dal fallimento a est.
Questa storia si interrompe con la sconfitta del movimento operaio in occidente, che comincia negli anni 80 con quello che Luciano Gallino chiamerà il rovesciamento della prospettiva di classe, in cui sono i padroni a vincere contro i lavoratori e non il contrario. È da lì ci si avvia verso la rivoluzione capitalista e la globalizzazione. La rivoluzione che era stata proletaria, diventa all’ingresso del nuovo millennio, una rivoluzione capitalista, una rivoluzione che si affaccia con intento totalitario. Rivoluzione restauratrice e al tempo stesso profondamente innovativa sul piano della tecnica, della scienza, della tecnica, dei rapporti tra capitale finanziario, capitale produttivo e Stato. Una vera e propria grande controriforma che avviene in alcuni Paesi in modo tumultuoso, con la conquista reazionaria del potere, ma che è inscritta in un processo storico il cui motore è proprio la trasformazione del lavoro, della società e delle culture attraverso il cambiamento complessivo dello scenario mondiale.
È un nuovo capitalismo quello che si afferma nel nuovo secolo; e per un momento, circondato da apologeti che ne magnificano le sorti, sembra che possa avere successo. Ci sono opposizioni ma si tratta di fenomeni circoscritti, e la ristrutturazione capitalistica porta con sé una ristrutturazione dei rapporti di forza a favore delle classi dominanti.
Senonché è proprio questo trovarsi senza avversari da parte del nuovo capitalismo, che Bernie Sanders chiama uber-capitalismo, a innescarne la crisi. Senza il grande oppositore storico, il capitalismo sregolato produce in sé la propria crisi, sia sul piano ecologico con la crisi climatica, che su quello economico con la produzione di diseguaglianze fino a ora sconosciute (famosa la formula di Occupy Wall Street “We are the 99%”) e della crisi della democrazia essendo il supercapitalismo incompatibile col sistema democratico. Esso concentra infatti le decisioni nelle mani di pochissimi individui e produce uno svuotamento progressivo del sistema rappresentativo, con parlamenti ridotti a cassa di risonanza degli esecutivi e gli esecutivi come concerto di istituzioni dominate dalle ideologie di mercato.
Dunque il nuovo terreno di confronto è quello della crisi. Una crisi che a livello mondiale si manifesta con l’avvento della guerra. In questo capitalismo covano le tre grandi crisi – economica, ecologica e sociale – e si manifesta un mondo completamente destabilizzato, opposto a quello promosso dalle illusioni della globalizzazione, che avrebbe dovuto unificare il mondo attraverso l’unificazione dei mercati. Con un mondo scomposto in potenze, semi imperi e potentati ci troviamo oggi a confrontarci con una crisi di civiltà. La vittoria del capitalismo non ha prodotto una nuova fase di sviluppo, ma l’avvicinamento alla catastrofe.
E tuttavia nel processo di transizione tra il secolo della rivoluzione e l’avvio della controrivoluzione sorgono ipotesi rivoluzionarie di diversa natura: i femminismi, i nuovi movimenti studenteschi e la prospettiva ecologista. Dopo la sconfitta del movimento operaio è in questi che possiamo ricercare una possibilità di evoluzione.
L’appuntamento
Nell’ambito di Giorni di storia festival – Rivolte e rivoluzioni, in programma a Sesto Fiorentino (info qui), Fausto Bertinotti, oggi, 29 novembre (ore 18) Fausto Bertinotti tiene una conferenza dal titolo Il significato della rivoluzione nel ‘900.