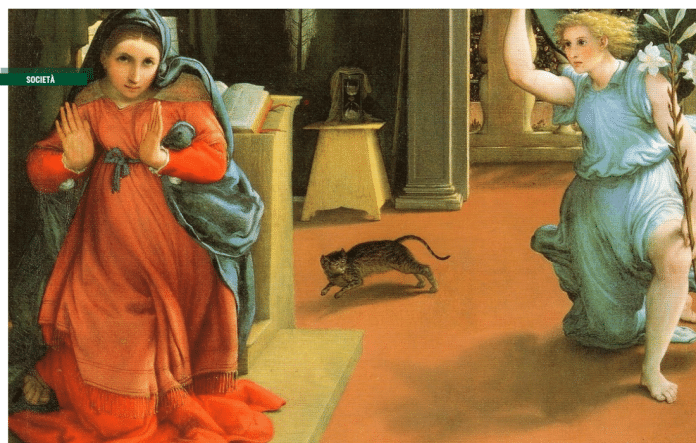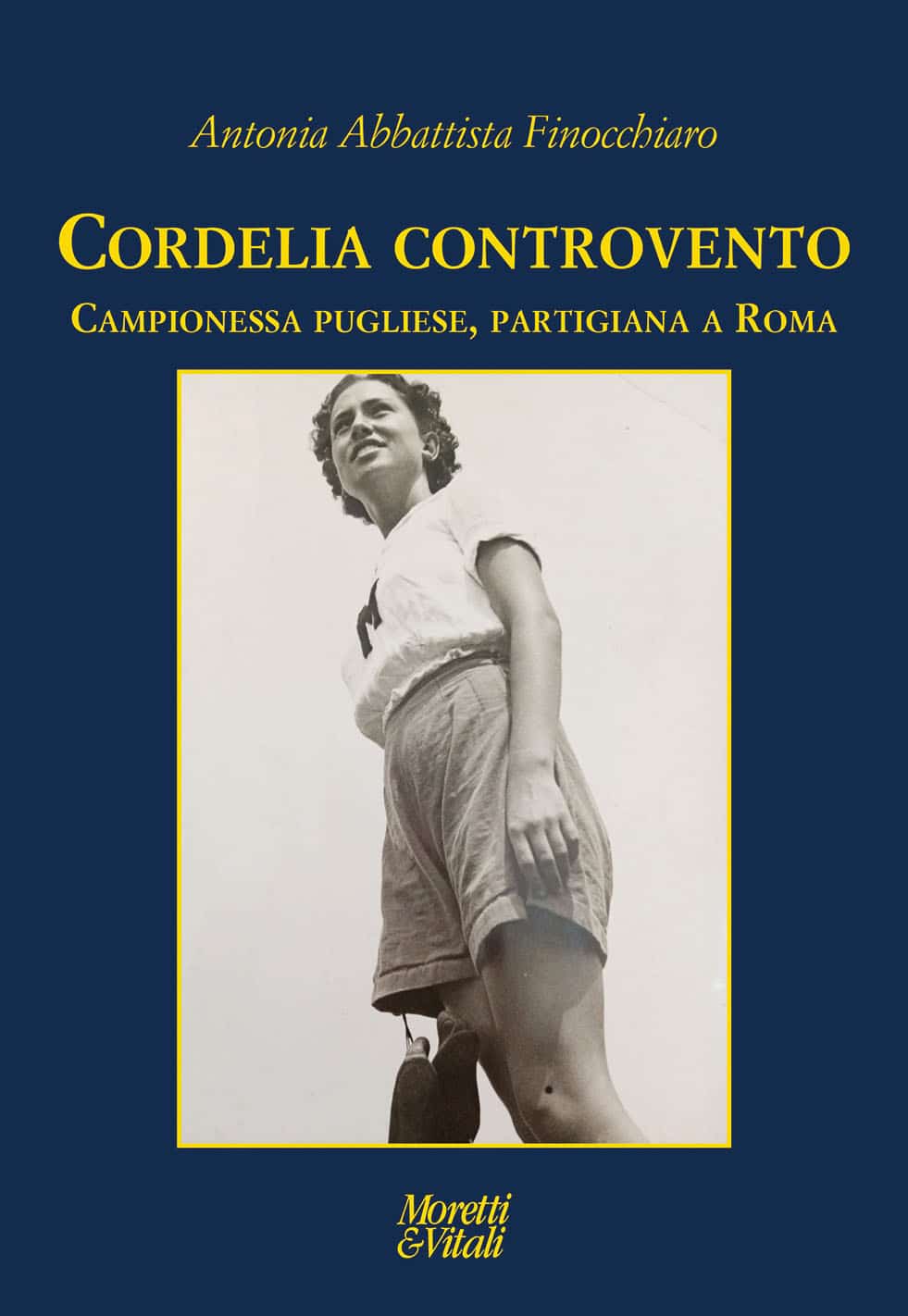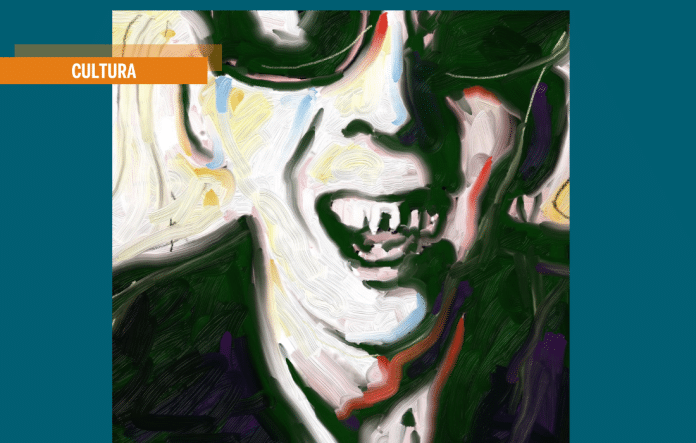Nel greco antico indagare si esprime con historein, fare storia. Questa coincidenza ha un significato simbolico fondativo per la cultura dell’Occidente. La disciplina che indaga il passato nasce, nella geniale lingua dei Greci, come equivalente di esplorare, conoscere Se si vogliono decifrare i fatti e inquadrarli in un ordine esplicativo, occorre ricostruirli storicamente. E in questo lemma si racchiude un nostro archetipo culturale: ogni volta che il presente ci pone di fronte a un fenomeno nuovo e complesso noi ci rivolgiamo al passato, tentiamo di scorgere da dove esso si è originato, per esaminarlo nel suo svolgersi nel tempo e comprenderlo. Perché la storia, come ricordava uno storico del ‘900, Edward P. Thompson «è la scienza del contesto», il sapere che connette i frammenti dispersi dei fatti e li rende intellegibili.
Dovrebbe dunque essere per noi indiscutibile che la guerra in Ucraina non si possa oggi comprendere senza fare storia. Ma su questo drammatico evento (è del 14 dicembre la notizia dell’avvio dei negoziati per l’adesione di Kiev all’Unione europea ndr), che occupa da quasi due anni la scena del mondo, si fronteggiano due opposte interpretazioni. Una è quella che resta alla cronaca, schiacciata sugli episodi del presente: il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l’Ucraina, un Paese sovrano, violando il diritto internazionale. Verità in sé ineccepibile e da condannare: la guerra è morte e distruzione. Ma questa interpretazione è manchevole di historein, di indagine, sulla catena di eventi disposti nel tempo con logiche di causalità che l’hanno provocata.
Tutto si spiega superficialmente e in maniera ingannevole con una motivazione che fa presa sull’immaginario collettivo: l’espansionismo della Russia comandata da un feroce dittatore. Le versioni più semplici sono il materiale privilegiato per la manipolazione totalitaria dell’opinione pubblica. Ma questa interpretazione, che si ferma alla cronaca, che non colloca gli eventi nella giusta disposizione temporale (quando comincia l’accerchiamento Nato e quando la Russia invade la Georgia e poi la Crimea, regione russa da sempre), che era dominante agli esordi, è cominciata a venir giù man mano che si è cominciato a fare storia, a gettare lo sguardo sul passato. Solo la ricerca storica, in questo caso, ad esempio, l’analisi di fonti archiviste americane desecretate, mostrano che nel 2001, tradendo gli impegni di non espansione nell’Europa orientale fatta ai sovietici, la Nato si era allargata di ben 1600 km verso i confini della Russia. Nel 2004 furono ammessi nell’Alleanza altri due stati, tra cui Romania e Estonia, quest’ultima confinante con la Russia. Ma nel 2008, con il “Memorandum di Bucarest” fu inclusa la seguente dichiarazione: «abbiamo concordato oggi che questi paesi /Ucraina e Georgia/ diventeranno membri della Nato» (B. Abelow, Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina, Fazi 2023, pp.17-18) Quindi i tanti orecchianti che vedono nelle annessioni di Mosca, fermi alle cronache manipolate dei giornali occidentali, la prova dell’espansionismo imperialistico russo, sbagliano clamorosamente e commettono un’ingiustizia di valutazione morale e politica. La Russia, ingannata da tante promesse americane tradite, intimorita dalla ritirata unilaterale degli Usa dai tanti trattati sui missili balistici atomici, hanno cercato di reagire a quel che era diventato un palese accerchiamento, una minaccia alla propria esistenza.
La storia più nota e più recente, ha poi mostrato come alla base dell’invasione russa ci fosse anche la guerra civile, la persecuzione e i massacri della popolazione nelle province russofone, da parte di Kiev. Si è dunque soprattutto scoperto che il supporto difensivo degli Usa all’esercito di Kiev era il camuffamento di una strategia di guerra predisposta da tempo.
Ora il copione si ripete con l’attacco di Hamas ad Israele, del 7 ottobre: un atto di guerra, ma insieme un pogrom contro la popolazione civile. Sulla condanna di quell’azione non è possibile alcuna discussione. Ma l’episodio sanguinoso, su cui naturalmente si concentra l’orrore e la condanna generale, finisce con l’esaurire l’intera storia dei rapporti tra Israele e la Palestina. Non soltanto vengono cancellati 75 anni di guerre, la dispersione del popolo palestinese dopo il 1848 e dopo il conflitto del 1967, ma soprattutto la creazione di un lager di nuovo conio, una novità clamorosa nella storia contemporanea: la detenzione di un intero popolo nell’angusta striscia di Gaza. Ebbene chi si azzarda a ricordare che cosa può spiegare, come si possa fare historein dell’attacco di Hamas, viene processato sul posto per connivenza col nemico. L’accusa di antisemitismo, diventato da anni un dispositivo retorico per impedire ogni ragionamento storico, rendere legittimo ogni sopruso che lo Stato d’Israele compie contro i Palestinesi, viene riusato per giustificare la Strage degli innocenti che si consuma a Gaza. In Italia è da tempo all’opera uno squadrismo giornalistico che tenta di far tacere chiunque vada oltre la condanna moralistica e le retoriche di contorno e si avventura nel compito di comprendere. Di fare storia. E in questo momento lo squadrismo è ancora più intollerabile, perché Israele con i bombardamenti su Gaza, sta trasformando l’asservimento silente degli ultimi 20 anni in un massacro definitivo.
Ora si dice che la storia la scrivono i vincitori. Verità indiscutibile. Ma non nel senso che tra i vinti non possa sorgere qualche storico che, sine ira ac studio, racconti come sono andate realmente le cose. In Iraq potrebbe esser nato uno storico che scriverà con quale proditorio arbitrio gli Usa hanno bombardato e invaso il suo Paese, provocando circa 150 mila morti, senza che dal suo popolo sia mai venuto alcun danno od offesa agli Americani. Ma resterebbe un libro senza eco. La storia degli sconfitti si scrive con il silenzio. Infatti, quell’aggressione è da tempo dimenticata, obliate sono le responsabilità degli Usa, non diversamente che per la Libia, e l’Afghanistan. Infatti non è tanto la storia scritta che conta, ma la memoria collettiva che alla fine s’impone.
Ora è evidente che un diverso andamento della guerra in Ucraina, con la vittoria della Nato, lo smembramento della Federazione russa coi suoi 26 stati e 160 gruppi etnici, destinati probabilmente a deflagrare, come in Jugoslavia, in una sanguinosa guerra civile, avrebbe dato all’Occidente la possibilità di un racconto del conflitto che già conosciamo. La vittoria della democrazia e dei valori occidentali su un’autocrazia asiatica, la sconfitta di un tiranno, la liberazione dei popoli. E’ almeno dalle crociate medievali che la storia, intesa come memoria dei popoli, l’Occidente la scrive così. Ma questa volta appare estremamente difficile ripetere il vecchio copione. La Russia non ha perso la guerra, non è crollata economicamente, Putin non solo appare saldo al potere, non solo non è riducibile a un tiranno pazzo, ma mostra di avere attorno un gruppo dirigente capace di visione strategica, di governare un Paese non diviso, in grado di grandi sacrifici, proprio perché ingiustamente minacciato. E non pretendo che i commentatori occidentali comprendano quanto dell’autoritarismo che governa la società russa di oggi sia anche frutto della permanente minaccia alla sua sicurezza, che inizia nel lontano 1918, con il tentativo dell’Armata Bianca, sostenuta da corpi di spedizione europei e americani, di soffocare la Rivoluzione d’Ottobre.
Anche il popolo palestinese, sconfitto nel 1948 e nel 1967, è stato privato della sua storia. L’umiliazione e la disperazione di milioni di persone sono scomparse per anni dalla coscienza del mondo. Ma oggi, con il massacro di Gaza, comunque si concluda il conflitto, si chiude una pagina di storia mondiale. La Russia non ha perso la guerra e la questione palestinese, dominata dall’appoggio Usa a Israele, è ancora tragicamente aperta. Le esortazioni alla moderazione del presidente Usa Biden, rivolte al governo di Israele in queste settimane, costituiscono un’espressione di suprema ipocrisia, una finzione crudele. Utili per mascherare responsabilità dirette, per non macchiare di altro sangue le mani dei governanti americani. Gli Usa hanno sostenuto per 75 anni tutte le scelte di quello Stato, anche le operazioni meno difendibili, delegittimando irrimediabilmente la potestà delle Nazioni Unite. E oggi supportano con armi ed equipaggiamento l’esercito d’Israele che devasta e uccide a Gaza. Hanno inviato due delle loro grandi portaerei nel Mediterraneo Orientale a far da guardia, perché nessuno osi disturbare Israele mentre compie i suoi quotidiani massacri.
Oggi dunque si chiude una pagina sanguinaria e per l’Occidente si pone un problema impossibile da aggirare: come raccontare la storia di un fallimento seriale. La guerra in Iraq non ha portato la democrazia, ma il terrorismo endemico, la Libia è stata ricacciata ai suoi originari conflitti tribali, l’Afghanistan è ritornato ai Talebani, l’Ucraina è semidistrutta, Gaza muore e Israele è oggi ancora più insicura. Il discredito sarà incancellabile e getterà la sua ombra sui decenni a venire. Questa volta la storia degli sconfitti non si potrà scrivere col silenzio. Centinaia di migliaia di ucraini sono morti per niente, per l’ennesimo calcolo sbagliato degli Usa e dei suoi alleati, per il delirio di onnipotenza del gruppo dirigente di un impero che tenta di frenare il suo declino con la violenza delle armi. L’insicurezza di Israele e le sue vittime, e migliaia di palestinesi uccisi, appaiono ormai solarmente quale esito della strategia americana. Ora potrà apparire cinico dirlo, ma questo tragico scacco, questa disfatta senza appello delle politiche americane e Nato, è una condizione perché l’Ue ritrovi le ragioni ideali per cui era nata. E si apre per noi, per i democratici radicali e per i pacifisti di tutto il mondo, la possibilità di un nuovo racconto, che chiami in causa le responsabilità delle élites Usa ed europee, e le costringa a rispondere dei loro errori e delitti ai propri popoli e a quelli degli sconfitti.
Nella foto: Gaza city, 2009 (wikimedia)