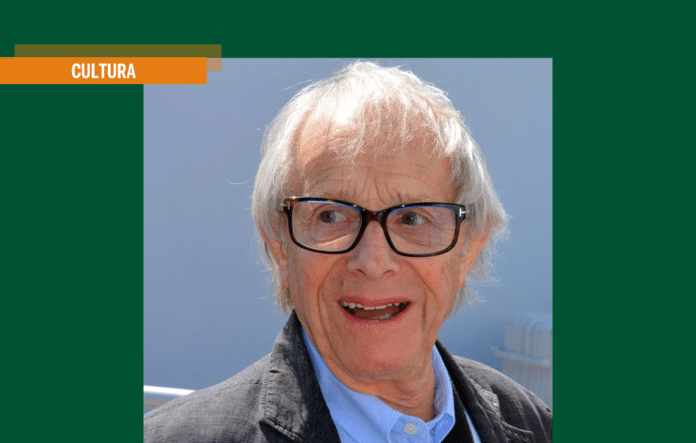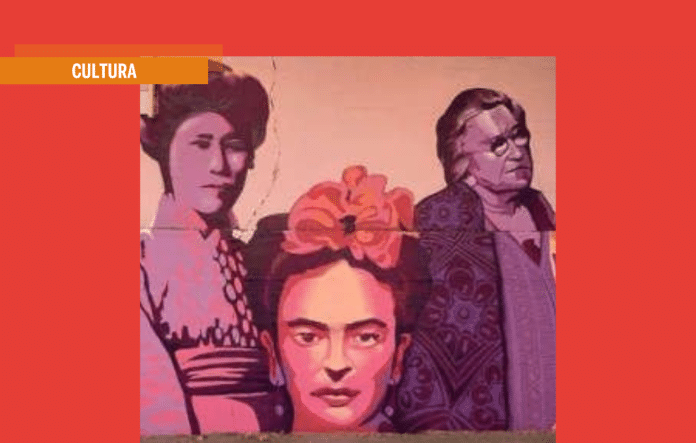Alla cerimonia funebre nel Duomo di Milano per le sei vittime dell’incendio scoppiato nella “Casa di riposo dei coniugi” il 21 luglio di questa rovente estate, c’era poca gente. Eppure l’amministrazione comunale aveva proclamato il lutto cittadino. Al clamore e alla commozione suscitati dalle dirette televisive che raccontavano l’intervento dei vigili del fuoco, l’apprensione dei familiari dei 173 ospiti della struttura, la concitazione degli operatori impegnati a salvare persone e cose, è subentrato il silenzio, il repentino abbandono della notizia, il disinteresse generale. Certo, la magistratura continua ad indagare per accertare le responsabilità di chi, in due lunghi anni, non ha trovato il tempo di rimettere in funzione i sensori anti-fumo, gli impianti anti-incendio, i sistemi di allarme andati in tilt, ma questo “incidente”, ultimo di una lunga serie, dimostra quanto sia precaria e vulnerabile la condizione degli ospiti delle strutture cosiddette protette. Dopo ogni incidente, versate le consuete lacrime di coccodrillo, sembra che ci sia fretta di dimenticare, di cambiare discorso. Invece è più che mai importante approfondire la discussione sulle residenze sanitarie assistite (Rsa) e sugli oltre 300 mila anziani/e che attualmente vi soggiornano.
Perché l’ultimo miglio della nostra vita deve essere appaltato a privati che lucrano sulla vecchiaia? Perché molti anziani devono andare in un “mortuaire” (obitorio), come con triste e appropriata ironia, gli anziani e le anziane francesi chiamano la casa di riposo? Che cos’è la residenza per anziani se non la riproposizione in chiave moderna dell’ospizio? Chi scrive abitava da bambino a Catanzaro in una via dove c’era l’ospizio e ricorda i lamenti e le urla strazianti delle persone rinchiuse in quelle mura. In seguito ho appreso che l’ospizio era una delle “istituzioni totali” – al pari del manicomio, dell’orfanatrofio, del carcere, del riformatorio -, luoghi di segregazione finalizzati a tutelare la comunità da individui ritenuti pericolosi o “incapaci” di badare a sé stessi (anziani, pazzi, orfani, ladri, ecc.). La reclusione in uno di questi istituti, che hanno avuto il loro periodo d’oro nel XIX e XX secolo, voleva dire perdere ogni rapporto col mondo esterno, essere cancellati dalla vita civile, diventare invisibili. Nella seconda metà del novecento, grazie alle grandi battaglie sui diritti, le cose sono senza dubbio cambiate, ma per una sorta di riflesso condizionato tendono continuamente a riprodursi. Forse che, ancora oggi, nelle Rsa non è violata sistematicamente la dignità e la libertà di persone deboli e indifese? Non è forse calpestato il diritto alla vita privata e, in alcuni casi, lo stesso habeas corpus?
Sono ormai innumerevoli le relazioni dei carabinieri del Nas e i procedimenti giudiziari che documentano un quadro di degrado di centinaia Rsa, nelle quali sono stati trovati cibi e farmaci scaduti, rilevate carenze igienico-sanitarie, anche nella preparazione dei pasti, riscontrati casi di maltrattamento, di omissione di soccorso, di abuso nella somministrazione dei farmaci. Una realtà che contraddice il contenuto delle invitanti brochure in cui viene pubblicizzata un’assistenza di qualità in posti dotati di comfort di ogni genere e, magari, immersi nel verde. A Milano, la notte dell’incendio, c’erano solo cinque infermieri (su 173 ospiti) e nessun medico. L’assistenza quotidiana degli anziani è prevalentemente affidata a pochi operatori, scarsamente qualificati e sottopagati. Sempre più spesso sono lavoratori stranieri (migranti latino-americani e dell’est europeo), reclutati tramite apposite agenzie. Una forma di reclutamento che dalle Rsa si sta propagando all’intero sistema sanitario, per la strutturale carenza di personale. Inoltre, il sistema di accreditamento di questi istituti è del tutto inadeguato e inefficiente, anche per una colpevole disattenzione delle amministrazioni regionali, competenti in materia. Mancano i controlli, numerose strutture (circa 700, secondo alcune stime) operano senza autorizzazione e al di fuori di qualsiasi convenzione con gli enti locali. Non si conosce nemmeno il numero esatto delle Rsa, comunque denominate.
L’istituzione Rsa, dunque, non risponde ai bisogni degli anziani perché promuove quello che dovrebbe essere evitato: la dipendenza, l’abbandono e l’isolamento, le malattie, i contagi (ricordiamoci della pandemia). Rappresenta una risposta culturalmente e socialmente arretrata, e ciononostante gode di buona salute, forte di un fatturato di 15mila miliardi a livello europeo. Il mondo delle Rsa è in mano a società multinazionali e ad altri attori privati che costituiscono una lobby potente. La sua ragion d’essere deriva dalla carenza drammatica di assistenza domiciliare, di centri riabilitativi e, più in generale, di servizi socio-sanitari sul territorio. La sua forza attrattiva sta negli indici demografici. L’Italia passerà dagli attuali 7 milioni di over 75 agli 8,2 milioni del 1930 (dati Istat) e la multinazionale Korian, azienda leader delle case di riposo, si prepara a investire per soddisfare una domanda in forte espansione (gli ottantenni sono già 4 milioni). L’ad di Korian Italia, Federico Guidoni, ha recentemente annunciato lo sviluppo della rete di Rsa, nonché la realizzazione di una “filiera della cura” fatta di assisted livings (appartamenti protetti), di poliambulatori e servizi vari sul territorio. Nel giro di pochi anni gli imprenditori della silver economy, facendo affidamento sui generosi sussidi pubblici, prevedono di diversificare e raddoppiare l’offerta riguardante la terza e quarta età.
A sostegno delle Rsa agisce inoltre una forte motivazione culturale. Oggi la vecchiaia è rifiutata, negata, nascosta. Viviamo nel culto della bellezza, della forma fisica, della cura estetica, spinte fino all’esasperazione. L’apparenza fa premio sull’essere. Nella società dello spettacolo, in cui l’ego viene nutrito e coccolato in tutti i modi, in cui domina il mito del successo e della corsa al denaro, i vetuli (i vecchietti) non godono certamente della stessa considerazione in cui erano tenuti nell’antica Roma. Per loro sono tempi duri, sono schiacciati e messi fuori gioco dalla competizione quotidiana che coinvolge tutti, additati come “matusa”, esempio negativo di lentezza in tempi che pretendono velocità. E sociologi, economisti, psicologi, giornalisti non perdono occasione di presentare come insanabile la contrapposizione tra giovani (penalizzati) e anziani (privilegiati). Una narrazione falsa, smentita clamorosamente dalla pandemia, che ci ha consegnato una generazione di anziani falcidiata dal Covid-19, e una generazione di ragazzi segnata dal disagio, privata del diritto di vivere la loro età.
Il capitalismo, nella sua fase più avanzata e caratterizzata da straordinarie innovazioni tecnologiche, ci consegna una società smarrita e sofferente, frammentata in tanti particolarismi e interessi corporativi, ai quali la sinistra finora non è stata in grado di dare una risposta unificante. Divisioni e chiusure egoistiche hanno invece trovato la loro sponda politica in una destra conservatrice e reazionaria. Aiutata, è bene aggiungere, da un’informazione manipolata e a senso unico, impegnata subdolamente a distogliere l’attenzione dai problemi veri – la pace, la contraddizione tra ambiente e sviluppo, quella tra ricchi e poveri, il dramma dei migranti – e a creare diversivi che alimentano, spesso artatamente, contrapposizioni di ogni tipo (intergenerazionali, razziali e di genere), usando la vecchia tecnica del divide et impera.
Con il furore ideologico che li caratterizza, gli apologeti del sistema capitalistico considerano un peso di cui sbarazzarsi tutti quelli che «non sono utili allo sforzo produttivo del Paese» (copyright di Giovanni Toti, governatore della Liguria). In questo schema, i primi a essere messi da parte e sacrificati sono gli anziani, i più deboli e i più fragili. Anche in questo caso, fa scuola il modello americano, fortemente orientato all’istituzionalizzazione: quando la salute e l’autosufficienza vengono meno, diventa “naturale” risolvere il problema in una casa di riposo. I vecchi entrano così in luoghi che si trasformano in trappole per la loro salute e per la loro vita. Se l’obiettivo della gerontologia è l’invecchiamento in buone condizioni fisiche e psichiche, la “limitazione “funzionale”, che spesso è la causa che porta a varcare la soglia di una Rsa, innesca un processo che porta a ulteriori limitazioni. La Rsa, insomma, diventa un’incubatrice di nuove malattie e, comunque, di perdita di autonomia. La resistenza al cambiamento è forte anche perché l’istituzionalizzazione, con tutti i suoi limiti, appare tuttora l’unica risposta credibile e realistica all’invecchiamento della popolazione. Ma è proprio così o si possono immaginare soluzioni più moderne e avanzate delle Rsa?
Quello che è successo alla signora Bice, 81 anni, pensionata delle Poste, “rinchiusa” in una residenza di Faenza, a seguito di una caduta, è emblematico. Rimessasi in sesto, ha espresso la volontà di tornare a casa sua, scontrandosi, però, con la contrarietà della figlia. Allora è fuggita dalla struttura che l’ospitava e, quando è stata rintracciata, ad una giornalista di Rai uno (“La vita in diretta” del 14 aprile 2023) ha dichiarato: «Voglio vivere e morire dove mi pare. Voglio tornare a casa. Ho nostalgia del mio appartamento. Lì mi sento libera, posso passeggiare quando mi pare, incontrare la mia amica, pranzare, uscire quando ne ho voglia. Mi manca la libertà. Che mi venga restituito tutto quanto mi è stato tolto e venduto». Ho ricordato questo episodio per dire che essere in parte o in tutto non autosufficienti non significa avere come destinazione obbligata una Rsa. Niente di più sbagliato. Con un adeguato supporto, molti vecchi potrebbero prolungare la permanenza nel proprio alloggio e nel proprio quartiere, continuando ad abitare in un contesto urbano e familiare dove ci sono i ricordi, il passato, gli affetti e le amicizie. Ma nelle parole della signora Bice, ex direttrice delle Poste, è possibile leggere in filigrana una sottile polemica con i familiari. Si tratta di un caso, non so quanto raro, di perdita di autonomia economica prima ancora che psico-fisica.
La mia simpatia e vicinanza sono tutte per la signora Bice, per il suo rifiuto di vivere in uno stato di emarginazione sociale e civile. Non è l’unica a ribellarsi, a chiedere di tornare a casa. Durante il Covid, molti “ospiti” delle Case di riposo hanno tentato la fuga, hanno scritto lettere strazianti ai familiari, raccontando l’isolamento e il senso di abbandono. In un recente sondaggio su anziani giapponesi over 75 – dal quale la regista Chie Hayakawa ha tratto spunto per il lungometraggio Plan 75 – gli intervistati, a larghissima maggioranza, si sono espressi in modo favorevole all’eutanasia. Pure in Giappone ci sono confortevoli case di riposo, ma la voglia di vivere di tanti anziani si spegne inesorabilmente. Si sa che il distacco dalle proprie cose, la mancanza di attenzioni e la perdita delle consuetudini quotidiane si riflettono sullo stato d’animo, accentuando il senso di avvilimento e di tristezza. È un problema che a diversi gradi coinvolge tutti i senior reclusi, al di là del reddito, del patrimonio, della qualità dell’assistenza. La Rsa comporta la morte civile, prima che naturale.
La vicenda della signora Bice ci ricorda che, malgrado le tendenze demografiche ci raccontino di una presenza e di un peso crescenti della popolazione anziana, lo “spazio vitale” degli over 65 oggettivamente si restringe. La signora Bice fa parte della generazione cresciuta nei “trenta gloriosi”, che ha vissuto da ragazza il miracolo economico, è stata partecipe delle grandi lotte operaie e delle grandi conquiste sociali: le case popolari, la scuola dell’obbligo, il servizio sanitario nazionale, lo statuto dei lavoratori. Una donna che ha studiato, lavorato e lottato, non disponibile a subire in silenzio. La sua generazione precede di qualche anno quella dei baby boomer, settantenni ancora (relativamente) in buona salute. I baby boomer – a cui appartiene anche chi scrive – sono i prossimi candidati a occupare la stanza di una Rsa. È la ruota della vita, si dice. Ma la signora Bice indica una strada alternativa alle case di riposo. Chi lo dice che la ruota debba girare sempre in un’unica direzione?
“Meglio nella propria casa”, questa è l’alternativa. Se dentro e fuori le mura domestiche si creano condizioni favorevoli, può allontanarsi nel tempo lo spettro del ricovero in una struttura residenziale protetta. Il problema diventa quello di intervenire sulle abitazioni degli anziani per trasformarle e renderle adatte alle esigenze dell’invecchiamento, utilizzando appropriati dispositivi di sicurezza, la domotica e altre dotazioni tecnologiche (apparecchiature di telesoccorso e di telecontrollo), creando un ambiente sicuro e confortevole. Diventa anche importante l’eliminazione di barriere architettoniche, dentro e fuori l’appartamento. La casa può diventare il primo luogo di cura, è lo è già oggi per un milione di persone anziane che ricorrono ad un/a badante, una variante senza dubbio positiva (per chi se lo può permettere) rispetto al ricovero in una Rsa. È fondamentale, però, ripensare la tipologia e le caratteristiche dei servizi per gli anziani, reinterpretandoli in modo più dinamico e flessibile, e relazionandoli con le altre risorse territoriali. Servono sia servizi di assistenza domiciliare oggi del tutto carenti sia servizi di supporto e completamento, quali la mensa o i pasti a domicilio, la lavanderia, il taxi, il telesoccorso, ma anche l’aiuto per fare la spesa, le piccole manutenzioni in casa. Bisogna agire, insomma, per potenziare i servizi socio-sanitari sul territorio, con particolare riguardo all’assistenza continuativa (long-term care), garantendo all’occorrenza che personale qualificato si rechi presso il domicilio degli anziani. L’insieme dei servizi elencati rappresenta una forma innovativa e moderna di residenzialità protetta che rispetta la dignità e i diritti degli anziani, senza allontanarli dalla propria casa. Una nuova modalità dell’abitare che potrebbe finanziarsi con lo spostamento graduale e programmato delle risorse oggi impegnate nelle Rsa (circa sette miliardi di euro) verso i servizi sociali e sanitari alla domiciliarità.
Sono linee d’intervento contenute nella legge delega per l’assistenza agli anziani, frutto del lavoro di una commissione che ha lavorato quando ministro della salute era Roberto Speranza. A gennaio dovrebbero essere approvati i primi decreti legge, ma le misure previste rischiano di essere stravolte e contraddette dalla rimodulazione del Pnrr. Oltre al taglio degli investimenti sul rischio idrogeologico e sulla rigenerazione urbana, sono stati cancellati centinaia di milioni di euro destinati al rafforzamento della medicina territoriale, tramite una rete di case di comunità e di servizi di assistenza primaria e prevenzione, indispensabili per le persone fragili e per gli anziani. Se saltano gli investimenti per i presidi socio-sanitari sul territorio si fa un favore a chi vuole continuare ad aprire Rsa, facendo profitti sulla pelle degli anziani.