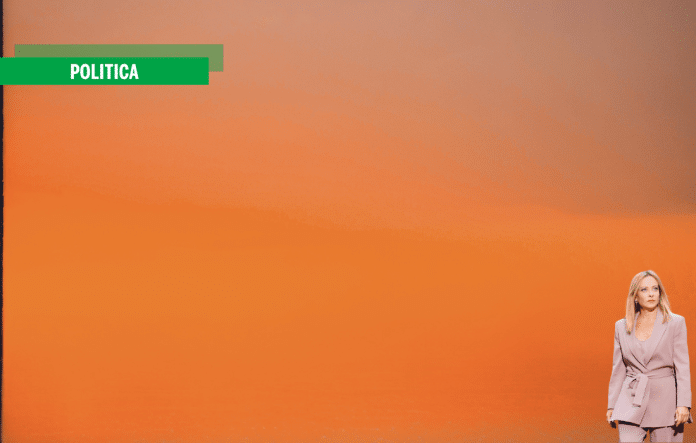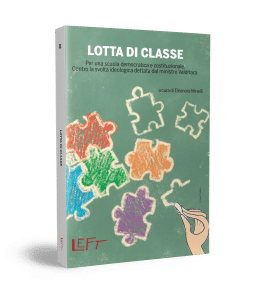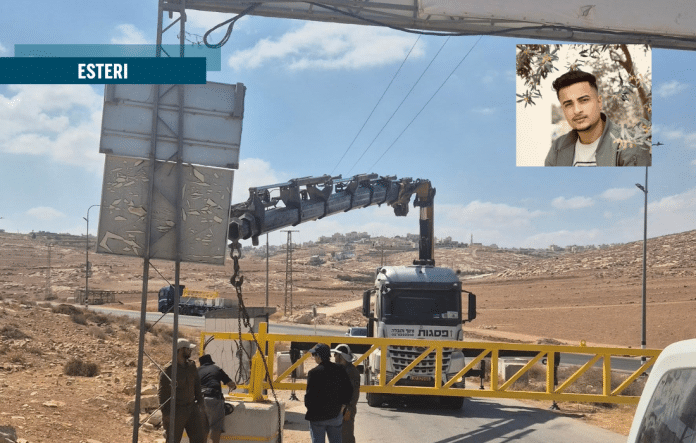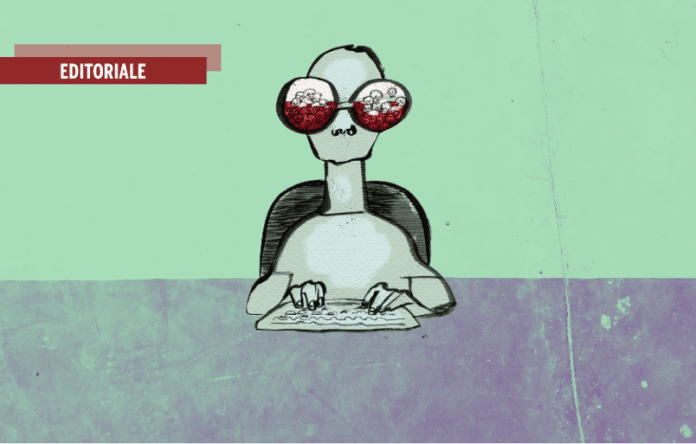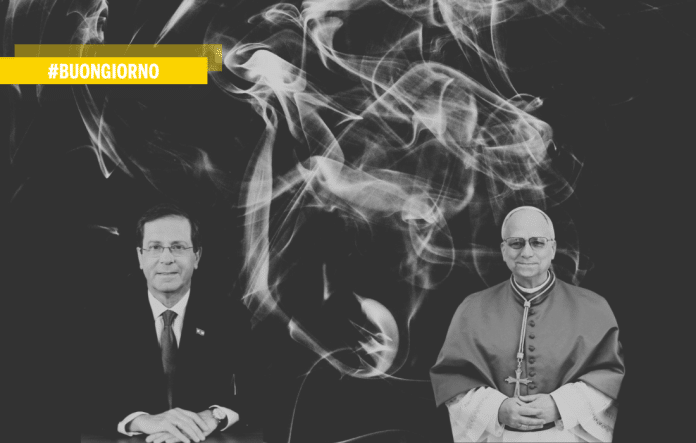È sgradevolmente facile accorgersi, una settimana dopo l’altra, che quello che chiamiamo, in sintesi, “carrello della spesa” si fa sempre più costoso a onta del calo dell’inflazione. Qual è il punto?
Riporta l’Istat, nella rilevazione dei dati provvisori dei prezzi al consumo in agosto, che “secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,1% su base mensile e del +1,6% su agosto 2024 (da +1,7% del mese precedente)”. Ma se “la decelerazione del tasso d’inflazione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +17,1% a +12,9%) e non regolamentati (da -5,2% a -5,9%) e, in misura minore, a quella dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,5% a +0,2%), invece sono in accelerazione i prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +5,1% a +5,6%) e lavorati (da +2,8% a +3,0%), quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,7% a +2,9%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,3% a +3,5%)”.
E questa è una tendenza alla crescita dei prezzi che procede con costanza da molti mesi. Insomma: se l’inflazione media (cioè la media dei prezzi di tutti i suoi componenti), che tra il 2021 e il 2023 cresceva a un ritmo intorno al 10%, oggi si attesta (ci riferiamo ai dati consolidati dell’Istituto di statistica relativi a giugno) all’1,7%, la variazione dei prezzi dei beni alimentari rispetto allo stesso mese di giugno del 2024 segna il +3,7%.
Ci sono ragioni contingenti e specifiche per l’aumento dei prodotti alimentari, come gli effetti sempre più pronunciati del cambiamento climatico e, di conseguenza dei, purtroppo, sempre più consueti eventi estremi che si producono.
Fatto sta che qui si fanno brutalmente evidenti gli effetti dell’andamento dei salari nel nostro Paese. Come siamo messi in questo momento della storia? Confrontiamo la situazione del nostro Paese con quella del resto d’Europa, partendo dall’assunto, ormai arcinoto che, di fatto, sono ormai oltre trent’anni che, in Italia, i salari sono praticamente fermi.
Secondo le previsioni Ocse nel 2025 i salari nominali italiani – cioè l’importo indicato nella busta paga che va distinto dal “salario reale”, che rappresenta il potere d’acquisto effettivo di quel salario nominale – dovrebbero aumentare del 2,6%. Una crescita che è ben inferiore a quella di molti Paesi europei dove gli incrementi percentuali sono molto più alti. Facciamo qualche esempio vicino a noi: Spagna (19%), Germania (18%), Francia (14%).
In definitiva, nel 2025, l’andamento delle retribuzioni in Italia si fermerà ad aumenti contenuti e ad un livello retributivo medio significativamente inferiore alla media europea. La crescita è lenta e la posizione di lavoratrici e lavoratori italiani gravemente svantaggiata rispetto al resto dell’UE.
E se i salari medi cresceranno di quel 2,6% e comprare da mangiare costa oltre il 3% in più (ma come ci dicono i dati congiunturali provvisori di agosto andiamo sopra al 5%) farsi i conti in tasca diventa tristemente facile.
Si vocifera che il Governo cominci a pensare di inserire nella legge di Bilancio 2026 una forma di “tassa piatta”, insomma a forfait, sulle componenti variabili dei salari, come straordinari e lavoro notturno e nei giorni festivi. Naturalmente, tutto va bene per rimpolpare le asfittiche retribuzioni del nostro Paese. Ma, come al solito, il Governo Meloni non va oltre progetti di interventi spot, non strutturali.
E questo succede anche perché un grande e definitivo problema resta sul tavolo. Ossia, proprio l’assenza di un “tavolo”. Quello del confronto – oltreché con le opposizioni che ha segnato tutte le leggi di Bilancio di questo Governo – con le parti sociali. Un tavolo serio, che serva a progettare politiche economiche e industriali di largo respiro senza le quali il Paese non uscirà da questo pantano. Un Governo malato di solipsismo e autocelebrazione non è per nulla utile a un Paese, lo dimostrano i dati, in cui diventa sempre più difficile – come dice l’adagio popolare – “mettere insieme il pranzo con la cena”.
L’autore: Cesare Damiano, già sindacalista e parlamentare in tre legislature, è stato ministro del Lavoro ed è presidente dell’associazione Lavoro & Welfare


 Foto di
Foto di