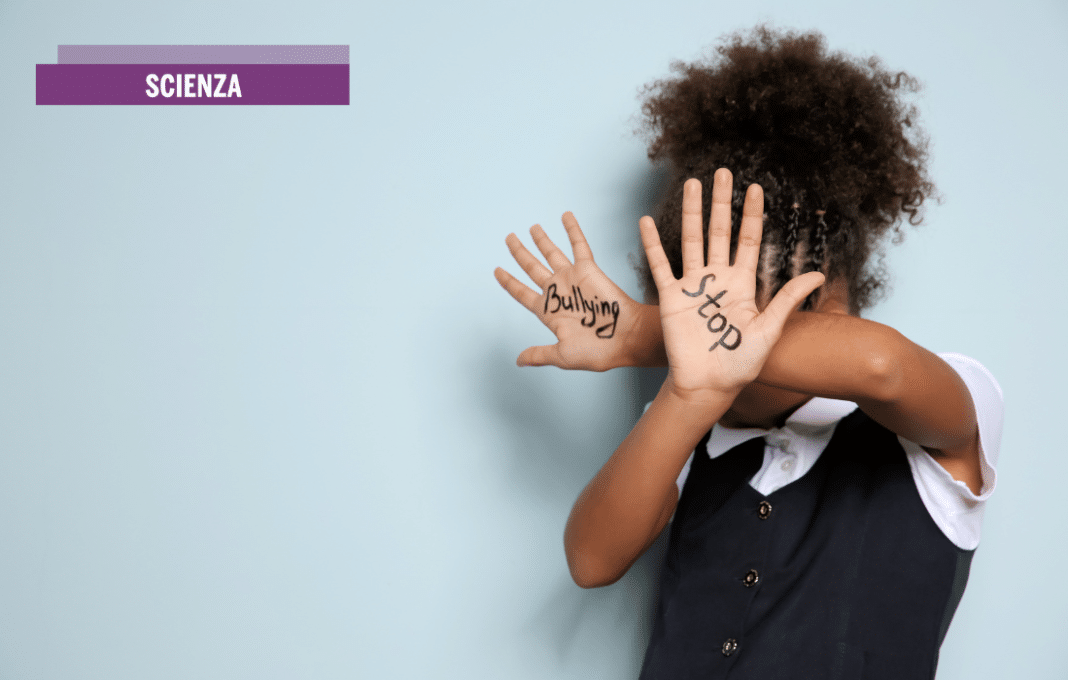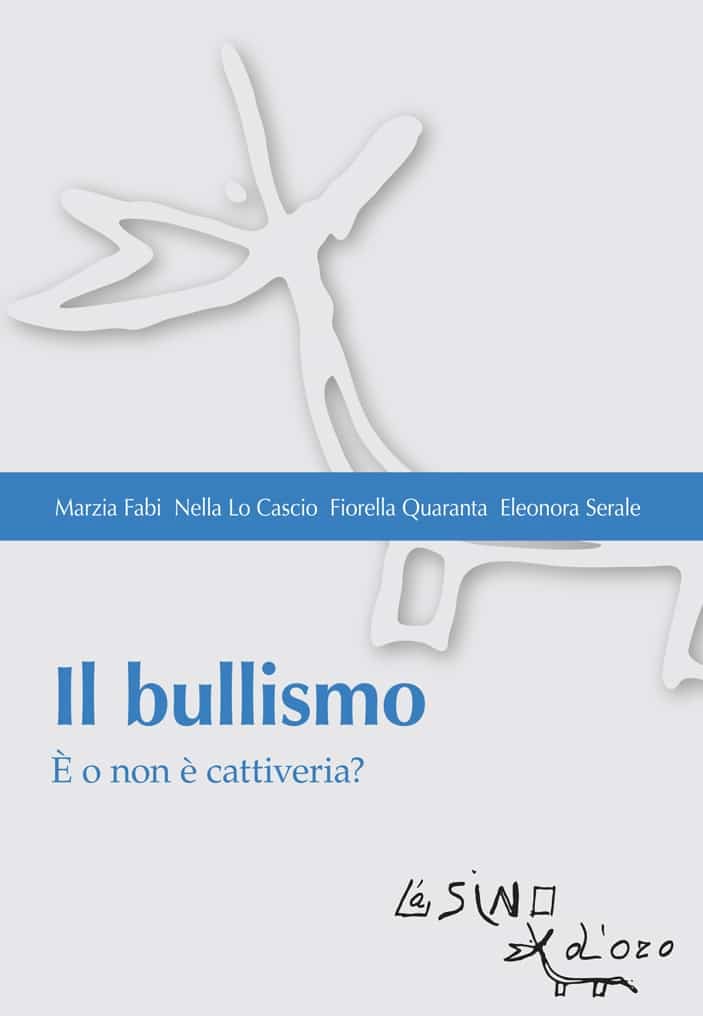“Quando mi sveglio la mattina comincia il mio inferno. Non voglio alzarmi. Alzarmi significa andare a scuola. Non ce la faccio. Mi viene la nausea al pensiero. Le gambe si paralizzano. La rabbia che provo rimane tutta dentro, mi sento scoppiare. Dai ce la puoi fare mi dico. Non possono farti nulla. Sei forte. No, non ce la faccio, sono più forti loro. Fai schifo, ciccione, levati dalla nostra vista, sparisci. E io sparisco veramente”.
Le parole che abbiamo letto colpiscono per la loro crudezza, soprattutto se immaginiamo il dolore di chi le prova, spesso un ragazzo o una ragazza poco più che bambini, talvolta bambini stessi.
Torna in mente quel che ha scritto sui social di Lodo Guenzi, leader dello Stato Sociale: «Mi chiamavano Cinzia, come il nome di una bici da donna». Il cantante, per la prima volta, rivela di essere stato “bullizzato” da ragazzino perché “troppo esile, effeminato, biondino”.
Ormai si parla ovunque di bullismo, un fenomeno sociale dilagante e pervasivo, che vede coinvolti bambini e adolescenti e preoccupa genitori, insegnanti e la società in generale. Così pericoloso che Amnesty International lo ha definito una violazione dei diritti umani, perché mina l’identità psico-fisica di chi lo subisce. La diffusione del bullismo rappresenta quindi una sconfitta per la società intera.
Ancora più pericolosa è la deriva virtuale del bullismo, il Cyberbullismo, che trova terreno fertile, tra i ragazzi, nella grande diffusione dell’uso di social network. Un fenomeno attraverso il quale ragazze e ragazzi, nascondendosi dietro l’anonimato dello schermo, possono diventare ancor più aggressivi e violenti. La rete amplifica l’onnipotenza di chi agisce la violenza, che è dunque molto più subdola e difficile da contenere e da sconfiggere. Le vittime sono continuamente sottoposte a insulti e denigrazioni attraverso messaggi postati sui social o foto condivise sulle chat e, in questo modo, non si sentono sicure neanche a casa loro. Episodi del genere si sono purtroppo verificati anche durante la fase, da poco conclusa, di didattica a distanza: è di maggio la notizia di una ragazza disabile insultata e offesa sulla chat di classe da alcuni compagni durante una videolezione di musica.
Il fenomeno è presente tra i giovani in modo trasversale; le ricerche rilevano dinamiche di bullismo-vittimizzazione in circa un ragazzo su quattro, con un picco tra la fine delle elementari e le scuole medie, per poi decrescere verso gli ultimi anni delle superiori.
Ma cos’è il bullismo? Cosa si nasconde dietro le azioni violente compiute dal bullo?
Per prima cosa dobbiamo delinearne bene le caratteristiche per riuscire a riconoscerlo e distinguerlo dallo scherzo, che ha ben altro significato. Uno scherzo presuppone una relazione alla pari tra i protagonisti e ha come obiettivo il divertimento di entrambi. Anche se può ovviamente capitare di fare uno scherzo che risulterà di cattivo gusto.
Il bullismo è un’altra cosa. Già negli anni 70 lo psicologo svedese Dan Olweus lo ha definito “un’oppressione psicologica o fisica, reiterata nel tempo, esercitata da una persona o da un gruppo nei confronti di un’altra persona o di un altro gruppo percepiti come più deboli”.
Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono l’intenzionalità di fare del male, la persistenza nel tempo, l’asimmetria nella relazione, evidente nella scelta da parte del bullo della sua vittima, e la necessaria presenza di spettatori e/o gregari.
La domanda che abbiamo posto come sottotitolo del nostro libro: “È o non è cattiveria?”, è ovviamente retorica.
Non pensiamo affatto alla cattiveria che rappresenterebbe una condizione ineluttabile e insita nell’essere umano. Siamo convinte che gli esseri umani nascano sani e naturalmente non violenti, e allora per comprendere ma soprattutto per prevenire ogni espressione di prevaricazione dobbiamo cambiare radicalmente il modo di pensare. Dobbiamo pensare che dietro all’atto violento si nasconda un malessere che può e deve essere ascoltato.
Quello che colpisce è come il bullo mostri una totale mancanza di risonanza affettiva e di empatia verso l’altro. Sembra privo di sensi di colpa e tende a scaricare la responsabilità sulla vittima. Dato che non pensiamo che queste siano caratteristiche connaturate all’essere umano, tanto più se si tratta di un adolescente, dobbiamo andare a ricercare nel contesto familiare e culturale in cui il bambino cresce quei possibili fattori che possono costituire un terreno fertile per lo sviluppo di questa “disumanità”. Molte ricerche hanno mostrato come i “bulli” abbiano spesso alle spalle famiglie troppo autoritarie o distaccate emotivamente. Spesso si tratta di ragazzi che respirano fin da piccoli un clima violento e punitivo, più o meno manifesto.
Inoltre, si è visto che è proprio il contesto culturale di riferimento ad influire maggiormente sull’incidenza del bullismo.
Se il ragazzo è inserito in un contesto sociale in cui la prepotenza e la sopraffazione tra le persone vengono considerate normali, in cui qualsiasi difficoltà è vissuta come segno di “debolezza”, rischierà di generalizzare, nei diversi ambiti della sua vita, una modalità alterata di rapportarsi con gli altri, non basata sull’interesse e la valorizzazione delle diversità come fonte di conoscenza ma come legge del più forte, dove il più forte non è altro che il più violento.
I luoghi di aggregazione in cui possono verificarsi gli episodi di bullismo sono diversi ma il contesto scolastico è quello in cui avvengono con maggiore frequenza. La scuola è il luogo della crescita personale e culturale, quello in cui bambini e ragazzi vivono gli anni cruciali per lo sviluppo e la definizione della propria identità: si separano gradualmente dalle figure genitoriali e cercano sempre di più il contatto con i pari. È anche il luogo della socializzazione: si impara e si cresce insieme. Per cinque o sei giorni alla settimana e per almeno metà della giornata, il confronto con compagni e insegnanti è continuo. Nonostante di bullismo a scuola si parli molto, spesso si interviene solo in caso di atti gravi e manifesti. Come mai? Il bullismo è un fenomeno subdolo, perché il bullo agisce, generalmente, nei momenti o negli spazi in cui è più difficile essere visto dagli insegnanti o dal personale scolastico: i cambi di aula, i bagni, gli spogliatoi, il percorso di ingresso o uscita dall’istituto. Esistono varie forme di bullismo: una diretta in cui la violenza è pressoché fisica e verbale e una indiretta, più pericolosa e ancora più difficile da individuare che si manifesta con l’annullamento dell’altro e l’esclusione dal gruppo. Come se il ragazzo o la ragazza presa di mira non esistessero. È una forma subdola e silenziosa ma può avere conseguenze anche molto gravi sulla vittima che, sentendosi invisibile, può convincersi di non contare davvero nulla. Gli insegnanti, con un’adeguata formazione, professionale e personale, possono avere un ruolo importantissimo. Sicuramente l’attenzione ad eventuali campanelli d’allarme permette di intervenire tempestivamente. Ciò che a nostro avviso può fare la differenza è la relazione: il clima in classe è strettamente legato al rapporto di fiducia e rispetto che l’insegnante riesce ad instaurare con gli studenti; solo stimolando la collaborazione e il dialogo in classe è possibile promuovere la coesione all’interno del gruppo, fondamentale per evitare lo sviluppo di dinamiche di prevaricazione o esclusione. È necessario, ovviamente, coinvolgere anche i genitori, come avviene in molte iniziative di sensibilizzazione, progetti o programmi di prevenzione attuate negli istituti scolastici in collaborazione con forze dell’ordine, servizi territoriali e associazioni.
Possiamo scorgere in questi programmi di prevenzione proprio il tentativo di promuovere un cambiamento culturale partendo dall’idea che il debole, lo “sfigato”, non sia in realtà la vittima di atti di bullismo ma chi non riesce a rapportarsi all’altro se non sulla base della sopraffazione e della prepotenza. Per chi si occupa di prevenzione del bullismo nei vari contesti risulta evidente che non può esserci prevenzione laddove non venga scardinata una cultura che ritiene gli esseri umani malvagi o costituzionalmente malati per loro stessa natura. Se quindi il bullismo non viene derubricato a una forma di violenza insita in chi l’agisce ma considerato il risultato di qualcosa che non è andato come avrebbe dovuto nello sviluppo psichico di quella persona, è possibile prevenirlo e laddove sia intercettato, intervenire con una finalità terapeutica. La psicoterapia, in particolare la psicoterapia di gruppo si rivela molto utile nel trattamento sia di vittime che di bulli. Attraverso il rapporto con gli altri e il confronto, infatti, i ragazzi possono iniziare ad affrontare le proprie difficoltà relazionali che, come abbiamo detto, sono alla base del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Solo così si potrà tentare di modificare o addirittura evitare lo sviluppo degli effetti devastanti nel breve e nel lungo periodo che queste forme di violenza possono determinare.
Le autrici: Marzia Fabi è psicologa e psicoterapeuta; Nella Lo Cascio e Fiorella Quaranta sono psichiatre e psicoterapeute; Eleonora Serale è insegnante.
Questo testo è uscito originariamente su Left il 26 giugno del 2020 in occasione dell’uscita del loro libro Il bullismo. E’ o non è cattiveria? (L’Asino d’oro edizioni)