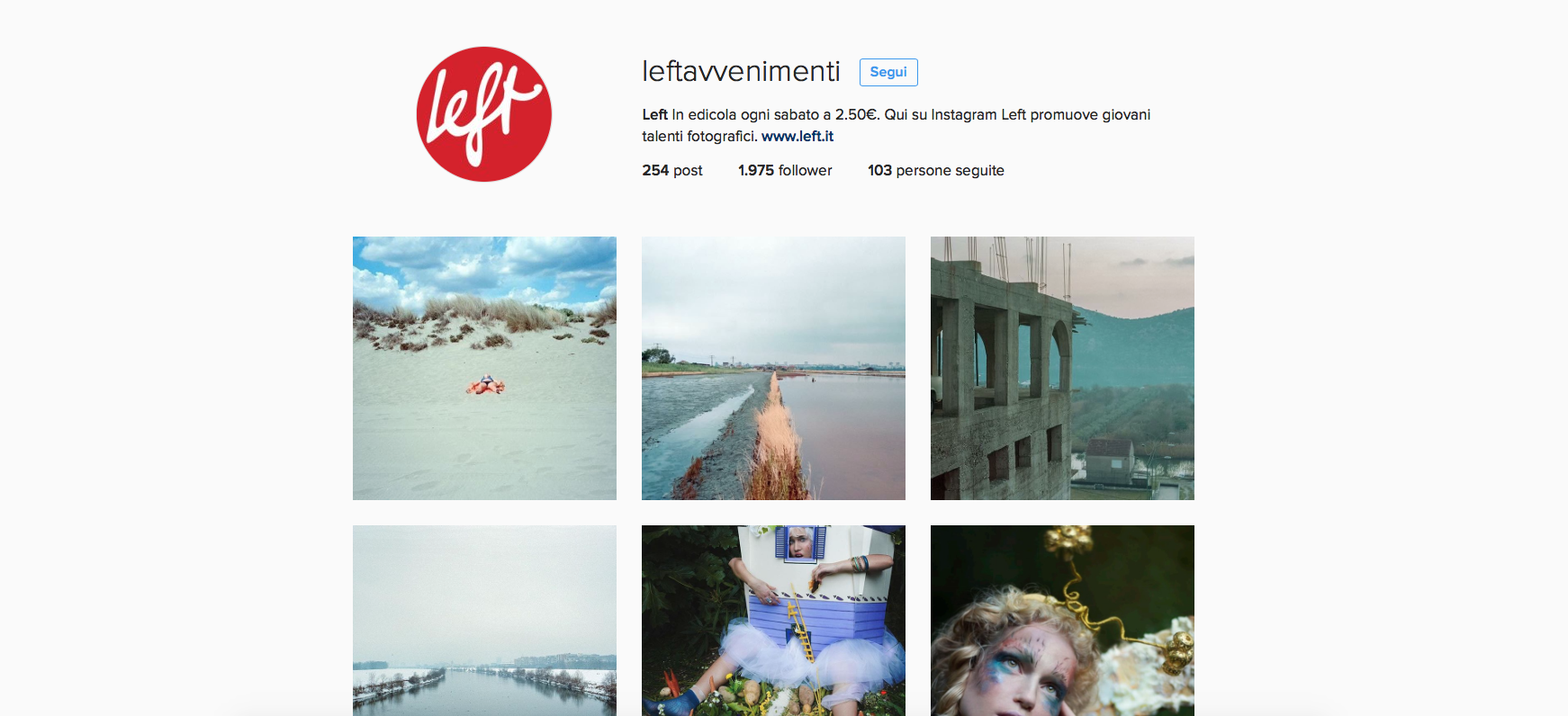“Non è il mio presidente”, migliaia in strada contro Trump a New York

New York – erano decine di migliaia, convocati con il tam-tam digitale. Tanti, un fiume in piena, molti giovani. Appuntamento alle sei, sotto la pioggia a Union square. Obbiettivo: arrivare sotto alla Trump tower, trenta isolati più su. «Sono qui perché ho paura – dice Jill, studentessa di medicina afroamericana, grandi occhiali e, a differenza di molti qui, un’aria per niente alternativa – In questi anni abbiamo fatto dei passi avanti come società e speravo di farne ancora. Le cose che ha detto Trump sono la negazione di questi anni in cui sono cresciuta».
Alle sei, uscendo dalle scale mobili della metropolitana ci si ritrova in una piazza piena, dove è difficile camminare, con un passaggio creato dalla polizia per chi torna a casa.
La piazza rimbomba di slogan: «No allo stupro», «Black e muslim lives matter», «La figa morde» (allusione al “prenderle per la figa” di Trump) e poi, naturalmente, «Fuck Donald Trump», «No Justice, No peace». Jeffrey, cappello da baseball dei St. Louis Cardinals in testa, è entusiasta della partecipazione: «Non mi aspettavo tanta gente, non ci sono organizzazioni, non ci sono sindacati, è una reazione spontanea, se anche i gruppi organizzati si muoveranno gli impediremo di fare le cose peggiori». La preoccupazione di molti è quella per le minoranze: se Trump si muoverà nella direzione dichiarata, ci sono milioni di persone che vivranno nella paura. La buona notizia in questo senso è che la proposta di deportare i musulmani è scomparsa dalla home page della campagna: un contor è spararle ai comizi, ora le cose forse cambiano (ma così Trump farà infuriare la sua base).


Già, le organizzazioni sindacali, i gruppi che organizzano migranti o quelle afroamericane non ci sono, si stanno curando le ferite e hanno appena terminato uno sforzo per cercare di mandare gente a votare. Ci sono persone normali e tanti studenti. Come a New York, manifestazioni ci sono state anche a Oakland e Berkeley nell’area di San Francisco, a San Diego, Seattle, Austin, Atlanta, in Connecticut (e sicuramente altrove). Quella della città del nuovo presidente però è la più grande. E a Columbus circle, accanto a Central Park ce n’era un’altra.
Altro brutto video della grande manifestazione (per parametri US enorme) #TrumpProtest pic.twitter.com/bb1Um8q9Bk
— martino mazzonis (@minomazz) 10 novembre 2016
Dopo circa un’ora il serpente si muove verso la Trump Tower (nel mediocre video qui sopra l’inizio della sfilata) e manda il traffico caotico di Manhattan in tilt. Piove ed è l’ora di punta. Tra la folla abbiamo incontrato Michael Moore, che prima non vuole parlare e poi dice a un collega britannico: «Voi siete usciti dall’Europa, noi ieri abbiamo votato per lasciare l’America. Questo tipo è il contrario di tutto ciò che dovremmo essere. Non siamo mai stati all’altezza delle nostre aspettative. Con lui non lo saremo mai». A chi gli chiede, che si fa? Morre risponde: «ci sono 5 cose da fare le ho scritte sulla mia pagina Facebook». Siamo andati a guardare: prenderci il partito democratico, farla finita con i sondaggisti, cacciare tutti i rappresentanti che non faranno con Trump l’ostruzionismo che i repubblicani hanno fatto con Obama, smetterla di dire che si è scioccati, se lo siete è perché non aveti visto quanto la gente stesse soffrendo, ripetere a tutti quelli che incontrate “Clinton ha preso più ” (ovvero bisogna riformare il sistema elettorale).
Ecco Michael Moore in strada
#Michael Moore at rally anti-Trump pic.twitter.com/9sIN7Z5sHF
— roberto festa (@rob_festa) 10 novembre 2016
Oakland, California
Oggi si è fatto vivo anche Bernie Sanders, che con un comunicato stampa ha detto: «Gli americani hanno votato contro lo status quo (una frecciatina a Hillary), se Trump volesse occuparsi delle sofferenze di chi lo ha votato, noi progressisti siamo pronti a collaborare. Se continuera con l’odio, il bigottismo, il razzismo e il sessismo che hanno connotato la sua campagna, faremo strenua opposizione». La sinistra democratica c’è ed è l’unica forza in campo in questo momento. Quel che esce a pezzi da queste elezioni è il partito democratico – e forse anche quello repubblicano per come lo conoscevamo.
“Don’t deport my friends.”
Anti-Trump protesters as far as the eye can see on the streets of Oakland, California tonight. pic.twitter.com/mnsgUBN68e
— Fusion (@Fusion) 10 novembre 2016
La profezia di Michael Moore su Trump (confermata dai numeri di chi lo ha votato)

New York – Cosa pensano e cosa vogliono gli elettori di Trump? Ci sono quelli di destra, certo. I razzisti del Sud, pure. I ricchi che non vogliono pagare le tasse. Anche loro. Ma tutti e ciascuno di costoro votavano repubblicano già nel 2008 e nel 2012. Su Left abbiamo provato a parlare spesso dei blue collars, i lavoratori bianchi, che in realtà sono una categoria più grande: i bianchi senza istruzione superiore. Pur contando sul fatto che gli altri, gli elettori delle minoranze, giovani e metropolitani avrebbero comunque raggiunto la maggioranza e dato la vittoria a Hillary Clinton, appariva chiaro che lo slancio della campagna del nuovo presidente degli Stati Uniti veniva da loro. Sono quelli che Hillary ha chiamato basket of deplorable – massa di miserabili è la traduzione migliore. Più rozzi, più stanchi, più appassionati di auto che di yoga, restano il primo gruppo sociale d’America. In calo, destinati ad estinguersi, certo, ma capaci di contribuire in maniera sostanziale alla vittoria – specie in un sistema presidenziale nel quale chi prende più voti non è detto che vinca.
Il voto di martedì è stata una loro vittoria. Gli Stati che Clinton ha perso a sorpresa sono tutti quelli con una certa tradizione democratica e sindacale, con una paesaggio caratteirzzato dai barn, i fienili rossi delle fattorie e dalle ciminiere spente e dove, fuori dalle città, il paesaggio economico e sociale è difficile e accidentato. Di quella crisi e quella sofferenza ci hanno detto gli esperti con i quali abbiamo parlato, ci hanno raccontato le persone della middle class che non partecipano alla frenesia della Borsa o alle gioie dell’economia digitale che impazza sulle coste Est e Ovest. In tutta quell’area del Paese che un tempo era florida, volenterosa e guardava con fiducia e sobrietà al futuro – la retorica è americaneggiante apposta – la fiducia è scomparsa e rabbia o inquietudine sono la normalità. Iowa, Indiana, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, Michigan hanno voltato le spalle ai democratici o lo avevano fatto già nel 2012. Quelli sono gli Stati dove le fabbriche e le miniere hanno chiuso.
Chi in quei posti ci vive lo sa: fuori dalle città le cose non vanno, c’è un boom di eroina e antidolorifici e i redditi stagnano. Lo sa bene, ad esempio, Michael Moore, che di quella America è un portavoce. La sua Flint (andate a rivedere il primo documentario, Roger and Me), in Michigan è uno specchio perfetto di quella realtà. Mesi fa, sul suo sito, Moore aveva scritto un articolo dal titolo: Perché Trump vincerà. Ne riprendiamo alcune parti e confrontiamo le sue affermazioni con i dati della notte elettorale.
«Benvenuti alla nostra Brexit in stile Rust Belt (la cintura della ruggine, come si chiama questa zona). Credo che Trump si concentrerà sui quattro stati blu nella Rustbelt e dei Grandi Laghi – Michigan, Ohio, Pennsylvania e Wisconsin. Quattro stati tradizionalmente democratici – ma ciascuno di essi ha eletto un governatore repubblicano dal 2010 (solo in Pennsylvania non è così). Alle primarie del Michigan hanno votato più repubblicani (1,32 milioni) che democratici (1,19 milioni)».
Come è possibile che a tratti nei sondaggi Trump sopravanzi Hillary si chiedeva Moore? «Beh forse è perché ha detto (giustamente) che il sostegno di Clinton al NAFTA ha contribuito a distruggere gli stati industriali del Midwest…Trump, all’ombra di una fabbrica Ford, ha minacciato la società che vuole chiudere una fabbrica e portarla in Messico di imporre una tariffa del 35% su ogni auto importata da quel Paese». Il commercio internazionale, cresciuto nell’era Clinton, è una delle chiavi, dunque.
«Da Green Bay a Pittsburgh, questa, amici miei, è la nostra Inghilterra centrale (quella che ha votato la Brexit) – in crisi, depressa, che non ce la fa, le ciminiere sparsi attraverso la campagna con la carcassa di quello che usiamo chiamare la classe media. Arrabbiati, amareggiati, con o senza lavoro, traditi dall’economia reaganiana (la trickle down economics) e abbandonati dai democratici che raccontano loro le cose giuste ma poi sono pronti a strofinarsi con un lobbista di Goldman Sachs che alla fine dell’incontro gli staccherà un assegno pesante».
Non ha tutti i torti Moore: le persone che hanno votato Trump e non Clinton sono soprattutto queste. Il repubblicano ha preso il 52% dei voti nelle contee dove il reddito medio è tra i 20 e i 30mila dollari (con un reddito così in molte città si muore letteralmente di fame), ha vinto nelle contee dove la gente è meno istruita con il 70% dei voti, ha vinto nelle zone rurali spopolate, nelle contee sotto i 20 mila abitanti, dove Clinton è in media sotto al 30%. Clinton vince tra i più poveri a livello nazionale solo perché a votarla ci sono le minoranze. Con un problema: l’entusiasmo generato da Trump tra certe fasce di popolazione non è inversamente proporzionale a quello generato da Clinton. La partecipazione al voto – non ci sono ancora numeri definitivi, è stata bassa e questo significa che neri e latinos non sono corsi in massa alle urne. E nemmeno i giovani: Hillary ha vinto nettamente tra gli under 44, ma evidentemente le persone con più di 45 anni sono andate a votare molto di più. E ormai le elezioni sono un esercizio nel quale occorre portare la tua gente a votare. Quelli di Trump votavano per, quelli di Hillary contro, e tutto sommato la speranza – per quanto mal riposta – è un carburante migliore della paura.
Michael Moore parlava anche di maschilismo, facendo dire all’elettore maschio bianco tipo: «Il mondo maschilista, 240 anni di dominico sta volgendo al termine. Una donna è in procinto di prendere la guida! Come è potuto succedere? C’erano segnali, ma li abbiamo ignorati. Nixon, il traditore, ha imposto la regola che le ragazze a scuola posono fare tutti gli sport. Poi le abbiamo lasciate pilotare i jet commerciali. Prima abbiamo visto Beyoncé prendere d’assalto il campo al Super Bowl di quest’anno (il nostro gioco!) con un esercito di donne di colore, pugni alzati, a dichiarare che il nostro dominio è finito»
Un senso di potere che se na va genera mostri. E infatti Trump vince tra i maschi sposati, i due quasi pareggiano, con Clinton in lieve vantaggio, tra le donne sposate, Hillary vince tra gli uomini non sposati di poco e tra le donne non sposate di molto. Questo vuol dire che: le donne non si sono sentite offese oltre una certa misura da Trump, non sono corse in numeri eccezionali per fermarlo. E anche che la famiglia standard, sebbene in ritirata, è ancora la maggioranza del Paese.
Nel suo articolo, il regista di Angry White Men parlava anche di politica: «Ammettiamolo: Il nostro più grande problema qui non è Trump – è Hillary. Lei è estremamente impopolare – quasi il 70% degli elettori la ritiene inaffidabile e disonesta. Lei rappresenta il vecchio modo di fare politica». Moore spiega poi come gli elettori di sinistra, quelli di Bernie Sanders, pur votando per la candidata democratica, non si daranno da fare. La mancanza di entusiasmo è una delle chiavi di queste elezioni.
Poi c’è la paura dell’uomo bianco, che non sempre è razzismo, ma distanza: Clinton ha perso 62% a 33% in tutte le contee dove la popolazione è bianca all’85%. Gli Usa sono un Paese dove un cittadino su sette è nato all’estero. Bene, Trump ha stravinto in quelle contee dove il 97% almeno dei cittadini è nato negli Stati Uniti. C’è un’America nativista, inquieta e che per otto anni ha masticato amaro guardando Barack e Michelle Obama che si è presa la sua rivincita.

Ne parliamo anche su Left in edicola dal 12 novembre
Tra arte e monnezza. Alig’Art 2016 il festival sulla sostenibilità
Una chiamata alle armi per riflettere sull’ambiguità della società, per svelare ogni ipocrisia sull’ambiente. Tutto questo ad Alig’Art 2016, un Festival speciale che durerà, 24 ore, senza interruzioni per parlare di sostenibilità. Dalla cucina con grandi chef all’agricoltura con il recupero delle terre abbandonate, dall’architettura sociale alla musica d’avanguardia, dalla finanza con il risparmio etico all’economia con i freelance sul palco, tutto questo è Alig’Art 2016 – “E’ la fine del mondo!”. La quinta edizione della manifestazione cagliaritana, in programma il 12 novembre 2016 nel capoluogo sardo, che fa del riciclo e della lotta allo spreco (aliga in sardo vuol dire spazzatura, rifiuto) il centro dei suoi saperi, ritorna con una formula rivoluzionaria. Una non stop frenetica (dalle 9 del sabato fino alle 9 della domenica) di incontri, l’Expo con opere d’arte provenienti da tutta Italia create con materiali di recupero, giochi di comitato, dj set e video proiezioni notturni. Tra gli ospiti: i giornalisti di PandoraTv e Megachip; lo sceneggiatore di Nathan Never Bepi Vigna; i laboratori di Game Design e di Introduzione alla Chimica delle Estrazioni per piccoli scienziati; le installazioni di Saverio Todaro (artista poliedrico torinese) e i fili d’arte di Pietrina Atzori (erede della grande Maria Lai) e tanti altri. Da non perdere: la presentazione in anteprima di una guida turistica illustrata sulla Sardegna, “Mia e Pepe in Ogliastra”, dedicata ai giovani viaggiatori consapevoli. In una parola una manifestazione che mette in luce le contraddizioni del reale, le due facce della medaglia di una quotidianità sempre in bilico tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, tra il sostenibile e l’insostenibile. Ma soprattutto uno dei passaggi di questa piccola rivoluzione che a Cagliari sta coinvolgendo i quartieri popolari. Non a caso la kermesse ha luogo nel Borgo di Sant’Elia, anticamente “barrio” dei pescatori e poi dello spaccio, oggi al centro di un cammino di profonda rigenerazione urbana e rivitalizzazione culturale. Il Festival è nato a Cagliari sei anni fa come collettiva di opere di artisti e design realizzate con materiali di scarto. Negli anni molti architetti, artigiani e artisti italiani hanno partecipato all’evento fino ad arrivare al quinto compleanno. La manifestazione è diventata un evento che coinvolge tutta la città.Tra gli ospiti delle passate edizioni: Tellas, Mary Zygouri, Daniele Pario Perra, Neeva, Marinella Correggia, Daniel Tarozzi, Antonello Ottonello, Ico Gasparri, Serena Piccinini, Cecilia Viganò, Andrea Bartoli, Florinda Saieva, Rocco Lombardi e tanti altri. Negli anni poi il Festival, oltre all’Expo, si è allargato a convegni sulle buone pratiche e a incontri con esperti. All’ultima edizione il sociologo americano Alan N. Shapiro e i contadini catalani di Agroecologia. Grande successo per le residenze d’artista.
#InstaLeft gli orizzonti fotografati da Benedetta Ristori
Il profilo Left di Instagram questa settimana sarà curato da Benedetta Ristori. Ecco alcuni dei suoi scatti e una presentazione per conoscerla meglio.

Benedetta Ristori, è una fotografa freelance di 28 anni, che attualmente risiede a Roma. Il suo lavoro si basa sulla tensione che esiste tra una forma, sia astratta che geometrica e lo spazio che essa occupa. Concetti fondamentali della sua ricerca stilistica sono: la decadenza, l’ abbandono, il vuoto e un nuovo approccio all’ideale di bellezza classica. Nel 2014 Benedetta è stata intervistata da Vanity Fair – Style.it per la sezione fotografi emergenti. Nel 2015 si è aggiudicata un posto tra i finalisti del ‘Next Photographer Award’ by D&AD ‘ in collaborazione con Getty Images. Nel 2016 una delle foto del suo progetto sui lavoratori notturni “Lay Off” ha vinto il premio per la categoria People al 16 ° Concorso fotografico del Smithsonian Magazine. Attualmente si sta dedicando ad alcuni progetti personali di fotografia documentaristica.
Chissà se il “popolismo” di Bernie avrebbe vinto. Di certo saremmo stati fieri di aver combattuto con lui
Non ci stiamo al gioco del “se fosse stato candidato Sanders”. Non è la realtà. Resta però il fatto che Hillary Clinton rappresentava la continuità di un sistema che ha avuto la sua faccia “buona” (i presidenti democratici) e la sua faccia “cattiva” (quelli repubblicani), ma non è mai uscito dall’alveo del capitalismo per come lo conosciamo. Quello che ha alimentato le disuguaglianze, che non ha mai smesso di tenere in conto gli interessi delle lobby e della finanza e un po’ meno quelli delle persone comuni. Gli americani lo hanno annusato. E hanno reagito così. A destra. Quello che non hanno capito è che il miliardario Trump nello stesso sistema ci è cresciuto e fatto affari. Il resto era propaganda: quella della paura dei bianchi di essere “minacciati dalle minoranze”, pericolose. Trump come Brexit? Forse, in un certo senso. Certo l’uscita al momento è a destra e questo è preoccupante per la sinistra. Almeno quella che vorrebbe esserlo davvero.

Perché diciamolo, e noi di Left lo abbiamo fatto per mesi, con Bernie, avremmo raccontato un’altra storia. Non possiamo dire che avrebbe vinto: logica vuole – ma basta guardare prima i sondaggi e poi l’esito del voto per capire che la logica con queste elezioni c’entra poco – che la destra e “Wall street” avrebbero arginato la sua avanzata.
Ma non è al risultato elettorale che ci riferiamo, quanto alla capacità di mobilitazione e ai temi che Bernie ha messo sul piatto fin dalle primarie. Le disuguaglianze, i salari da fame, le pari opportunità, l’ambiente, la sanità, la distanza dai privilegi e dalle lobby (quella delle energie fossili in primis): erano le parole d’ordine di Sanders, ve la ricordate la sua campagna? A future to believe in o Feel the Bern. Evidentemente l’elettorato ha percepito che in bocca a Hillary, moglie di quel president Bill, erano appiccicate, poco sentite. E meno peggio per meno peggio ha scelto il peggio. Funziona così. Lo leggerete sabato, di meno peggio in meno peggio arriva il peggiore. Perché se davvero l’alternativa non c’è, ma solo troppe sfumature di grigio, si rischia che venga fuori il nero.

Tutta quella connessione sentimentale dei Millennians per Bernie non ha mai trovato casa nella campagna di Hillary. Nessuna empatia, nessun incontro sentimentale né ragionato. Non sono servite le uscite degli Obama e i comizi di Bill tra gli ex operai delle città industriali in crisi. Chi ascoltava sapeva che Hillary non sentiva come priorità i loro bisogni, non sentiva di partecipare a nessuna lotta. Come forse avrebbe sentito con Sanders. Che al becero populismo trumpiano avrebbe contrapposto il suo “popolismo”, il suo amore per il popolo, per quello stare prima di tutto e tutti dalla parte di chi sta peggio. Non avrebbe vinto forse Sanders, ma quanto saremmo stati fieri oggi di aver combattuto al suo fianco? Magari dimostrando che una sinistra alternativa e non delle riformine o delle riforme “meno peggio” e meglio di niente, è possibile. E ottiene anche risultati importanti.
Illustrazioni di Antonio Pronostico

Leggi il numero speciale di Left dedicato a Bernie Sanders
Mujica: «Gli americani che votano Trump? È la stanchezza della classe media»

«Ci sono nordamericani che voteranno per Trump», ha avvertito Pepe Mujica circa un mese fa: «È la stanchezza della classe media statunitense». Ci ha visto lungo l’ex presidente dell’Uruguay, che ha confermato timori e analisi anche durante una recente intervista a Left (sabato prossimo in edicola il resoconto dell’incontro). Ha ricordato il caso dei lavoratori metallurgici negli Stati Uniti, che continuano a guadagnare «quanto guadagnavano i loro nonni». Poi alla vigilia del voto, dall’Italia ha aggiunto: «Non mi preoccupa tanto se vincerà Trump perché passerà, tutti i presidenti passano. Mi preoccupa di più la gente che lo voterà, che rimarrà. È una classe media che, vivendo nell’incertezza, attribuisce le colpe ora ai cinesi, ora ai messicani. In realtà sta esprimendo una patologia».
Il fatto è, riflette Pepe, «che negli Usa come in Europa, davanti alla concentrazione di ricchezza e ai benefici nelle mani di pochi, la grande moltitudine della classe media vota Trump o, per esempio in Francia, grida “La Francia ai francesi”. Questa contraddizione è all’interno delle destre di tutto il mondo, perché l’economia è globalizzata». Insomma, se la scelta è tra Trump e Hillary – «anche Clinton è abbastanza conservatrice» – prende corpo il paradosso: «Si vendono i candidati come se si vendesse un prodotto, e questo è dovuto alla tecnologia. La rivoluzione informatica contemporanea avrà pesanti ripercussioni istituzionali nella forma di democrazia del futuro».
A proposito di contraddizioni e paradossi. Due anni fa, Eric Trump, il figlio 29enne di Donald, in visita presso la perla turistica dell’Uruguay, Punta del Este, aveva detto: «Mi piacerebbe conoscere il presidente Mujica, spero in uno di questi viaggi di avere la possibilità di conversare con lui. Mi piace molto il suo stile di vita», così riporta El Pais. «Ma quello che mi piace di più di Mujica è che, mentre in altri Paesi i presidenti sono molto preoccupati della loro apparenza, lui no… quindi mi rinfranca vedere un presidente che non si preoccupa tanto dei beni materiali, di quello che possiede, ma che conduce uno stile di vita più semplice, del popolo. È un bene vedere un presidente così». È bella la sobrietà, quella degli altri però.
La mucca di Bersani, il Vaffaday di Grillo. Le reazioni alla vittoria di Trump

«Il voto americano parla anche di noi», scrive Pier Luigi Bersani che è uno dei primi a commentare la vittoria di Donald Trump. Il ragionamento dell’ex segretario dem sembra filare: «Nel mondo ripiega la globalizzazione», dice, «si affacciano protezionismi e pensieri aggressivi verso le persone e le merci di fuori. Gli establishment interpretano la fase precedente, in via di superamento. Ovunque, anche in Europa, c’è una nuova destra in formazione. Non è una destra liberista, è una destra della protezione». Deve aver cambiato idea rispetto al sostegno al governo Monti, ma il discorso di Bersani fila, sì: «Se vogliamo impedire che vinca ovunque», continua, «dobbiamo attrezzare una sinistra larga che abbandoni le retoriche blairiane delle opportunità, delle flessibilità, delle eccellenze e scelga la strada della protezione sulla base dei propri valori di uguaglianza». Parla ai suoi e a Renzi, Bersani, è evidente: «Per dirla in bersanese», chiude, «la mucca nel corridoio sta bussando alla porta».
La mucca è quella della metafora già rivolta a Renzi, per avvertirlo che spostando il partito a destra ci si scopre a sinistra e lì, saltati gli schemi, arriva «la destra della protezione». La metafora per gli iniziati delle beghe del Nazareno è chiara, ma Renzi per ora (pronto a agitare lo spauracchio Trump per il referendum) si limita a una replica istituzionale. «Il mondo saluta l’elezione di Trump», ha detto alle agenzie: «a nome dell’Italia mi congratulo con lui e gli auguro buon lavoro convinto che l’amicizia resti forte e solida». Renzi, archiviate le cene con Obama e richiamata Boschi che ha passato inutilmente la notte al comitato Clinton, dice che «questo è il punto di partenza per tutta la comunità internazionale anche al netto di certe diffidenze da campagna elettorale». «È un fatto politico nuovo», ha concluso, «che assieme ad altri dimostrano come siamo in una stagione nuova». Questo è quello che concede alla sorpresa: «Chi l’avrebbe detto che Trump avrebbe vinto? Eppure è così e noi abbiamo rispetto, collaboreremo con la nuova presidenza Usa e al rapporto tra Usa e Ue».
Molto meno istituzionale, al solito, è Beppe Grillo che dà così il là ai grillini: «Ci sono delle quasi similitudini fra questa storia americana e il MoVimento. Siamo nati e non se ne sono accorti, perché abbiamo un giornalismo posdatato che capisce quando qualcosa è già successa. Ed è già troppo tardi. Siamo diventati il primo MoVimento politico in Italia e non se ne sono accorti, se ne stanno accorgendo adesso e ancora si chiedono il perché. Andremo a governare e si chiederanno “ma come hanno fatto? hanno raccolto la rabbia ecc. ecc.”.», dice il leader del Movimento. Riprendendo così la teoria secondo cui il Movimento è, in Italia, l’argine a una destra populista. «Trump ha fatto un VDay pazzesco», è l’urlo. Sicuramente è la risposta all’assenza di una sinistra. Come dice Bersani. Troppo tardi.
Farage, Le Pen, Wilders: ecco chi festeggia Trump su Twitter
I mercati internazionali nel panico, la classe politica che si dispera e i lettori di tutto il mondo che guardano agli Stati Uniti: la vittoria di Donald Trump ha scatenato reazioni negative un po’ ovunque.
Eppure, anche in Europa, c’è un popolo di Donald, un’area politica che ha seguito con il sorriso in volto lo spoglio delle elezioni Usa.
Nigel Farage, il leader dello Ukip, è stato attivo su Twitter durante tutta la notte. Un primo messaggio in bacheca è arrivato alle 04:00 del mattino: «I movimenti dei mercati suggeriscono che ci potrebbe essere una seconda ‘Brexit’». Due ore dopo, Farage ha commentato la vittoria in Florida: «Mi ricorda il momento ‘Sunderland’» – uno snodo cruciale durante lo spoglio del voto sulla Brexit che aveva indicato la probabile vittoria del fronte per l’uscita dall’Ue. Alle ore 05:00 arriva invece il tweet dei quasi-festeggiamenti: «Sembra che il 2016 diventi l’anno di due grandi rivoluzioni».
In Olanda, Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà, ha twittato alle 05:00: «Florida e Utah con Trump. Il popolo americano si sta riprendendo il proprio Paese. Così faremo anche noi».
Delle ore 07:00 invece, il tweet di augurio da parte di Marine Le Pen: «Congratulazioni al nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, e al popolo americano, libero»!
Del tutto sfacciato Lutz Bachman, il leader del movimento islamofobo Pegida, che alle 08:00 commenta in maniera sessista: «Beh Hillary, nella Casa Bianca il posto per le donne, oggi come allora, rimane quello sotto alla scrivania».
Leggi anche:
Spagna – El Pais – De Guindos alle prese con il deficit di bilancio e le richieste della Commissione: sarà difficile fermare l’austerity
Germania – Euronews – La polizia tedesca arresta membri del gruppo di coordinamento dell’ISIS in Germania
Francia – Le Monde – Poliziotti ancora in strada per protestare contro l’insicurezza sul lavoro
La maggioranza silenziosa smentisce tutti ed elegge Donald Trump

New York – La peggiore campagna della storia d’America si è conculsa nel modo peggiore immaginabile. Ohio, Pennsylvania, forse Michigan e Wisconsin tutta la cintura industriale in decadenza ha voltato le spalle ai democratici che votava da diverse elezioni e deciso di credere a quel che le ha raccontato Donald Trump. La gente che Bruce Springsteen canta nelle sue ballate più strazianti vuole tornare a contare. E per farlo si affida alle promesse di un candidato che parla come loro, non ha mai governato nulla, né è mai stato eletto, non ha fatto il militare.
È stata una notte lunghissima, molti Stati sono assegnati per pochi voti, ma fin dalle prime proiezioni tra i democratici serpeggiava lo sconcerto. Per ogni Stato si aspettavano con ansia i dati delle contee dove vivono le minoranze e delle città. E a New York, la città di Trump, ma sua nemica, tutti nei bar, per strada, nella metropolitana non si staccavano dai cellulari o dagli schermi per capire cosa stesse succedendo. A New York, i giovani di successo l’America che ha votato Trump non la conoscono. Nel Bronx, a Staten Island, invece, probabilmente, molti vecchi figli di immigrati lo hanno votato. Anche loro sentono che il sogno americano gli sta evaporando tra le mani.
Nelle città e nelle aree dove vivono le minoaranze Hillary ha vinto, ma con molti meno voti di quelli necessari per portare a casa lo Stato. E molti meno di quanto ne prese Obama nelle stesse contee. Per i democratici è un disastro: perdono la Casa Bianca, non riprendono il Senato. E ora Trump nominerà un giudice alla Corte Suprema facendola tornare conservatrice – e la giudice Ginsberg, liberal, è più che ottuagenaria.
La voglia di tornare a contare delle aree rurali, delle contee marginali, delle piccole città dove le high street si sono svuotate di negozi e nulla sembra rimpiazzare quel che scompare ha vinto sullo scarso entusiasmo dei giovani e delle minoranze. E le donne non si sono spaventate abbastanza. Oppure i maschi si sono spaventati molto loro all’idea di eleggere una donna. La volontà di tornare a contare ed “essere grandi”, ha cambiato la storia della politica americana. La rivolta dell’elettorato americano contro Washington ha spazzato via la candidata che come nessun altro rappresentava l’establishment. I democratici si mangeranno le mani per quattro anni per aver scelto di dare carta bianca a a Hillary Clinton, una pessima candidata che non ha saputo stringere una relazione con la gente – lo hanno fatto al posto suo Obama, Biden, Michelle e Sanders, ma sulla scheda c’era il suo nome.
Per mesi abbiamo erroeamente sostenuto che Clinton era una pessima candidata ma che contro Trump ce l’avrebbe fatta. Niente di più sbagliato: Hillary avrebbe potuto vincere contro un altro pezzo dell’establishment, contro Jeb Bush, o contro un candidato ultraconservatore come Ted Cruz. Non contro l’uomo che aveva una storia da raccontare, la raccontava bene e si comportava costantemente in maniera opposta al senso comune. Il senso comune dei media e di Washington.
Come in Francia, Gran Bretagna, Ungheria in forme diverse e peculiari, anche gli Stati Uniti hanno ceduto al populismo. Non è una novità. Non tanto e non solo perché il populismo, questo connubio di parole per il popolo diseredato, rabbia e – qui – di una specie di razzismo non esplicito (o meglio, non teorizzato) ha una storia, vanta dei partiti e delle figure che hanno condizionato la vicenda politica nazionale – il People’s party a fine 800, Huey Long, governatore della Louisiana a inizio 900. Ma perché dalla vittoria di Obama a stanotte, abbiamo assistito solo a vittorie della protesta, degli outsider contro il potere. Contro la stessa Hillary, contro Obama nel 2010, di Obama contro il miliardario Romney, negli anni di Occupy Wall Street. E poi al successo clamoroso dello stesso presidente eletto e di Bernie Sanders alle primarie. Molti che votarono Obama otto anni fa, oggi hanno votato repubblicano. È una contraddizione solo se la giudichiamo con parametri tradizionali. Se registriamo il fatto che la gente è stufa e stanca, ha paura del futuro e non trova risposte, allora capiamo perché si affida a chi annuncia il cambiamento. Qualsiasi esso sia.
Parlando alla platea entusiasta e incredula ha parlato di unire il Paese, avere grandi rapporti con tutti i Paesi, sognare in grande, elogiato Hillary Clinton. È un personaggio che vuole piacere a tutti e ha promesso di lavorare con i democratici, parlato di infrastrutture. Ha moderato il suo messaggio, insomma. Come e se riuscirà a farlo è difficile da dire: il partito che lo ha accettato controvoglia è più conservatore di lui, odia più di lui i democratici e si prepara a una vendetta sena prigionieri per far dimenticare gli otto anni di Obama. Nemmeno questo sarà facile: togliere l’assicurazione sanitaria a 20 milioni? Stabilire che il matrimonio gay non è più costituzionale?
Clinton non ha parlato. Mandando in platea il capo del suo staff, John Podesta, ha fatto l’ennesima pessima figura: chi perde concede con un discorso. Lei forse parlerà oggi (domani in America). La sua carriera politica è finita. Il 2016 ha spazzato via le dinastie Bush e Clinton.
I democratici e la campagna Hillary2016 hanno sbagliato mille cose. Dato per scontato il voto ispanico contro il nemico dei messicani, quello degli afroamericani, non hanno avuto un messaggio, una narrazione e hanno sottovalutato Trump. Il nuovo presidente se ne è infischiato dei sondaggi, nonha seguito le regole della politica, ha snobbato i media ma ha saputo usarli a suo piacimento nonostante fossero quasi tutti schierati contro di lui. E violando le regole ha vinto. Facendo perdere i poteri forti – coni quali cercherà di stringere alleanze – e smentendo sondaggisti e media che evidentemente non conoscono il Paese che raccontano. La maggioranza silenziosa, quella che si rivoltò contro gli anni 60, i diritti civili ed elesse Nixon dando via alla rivoluzione conservatrice, non parla con i sondaggisti ma vota. E oggi ha cambiato la faccia dell’America e del mondo. Cosa ci sia da aspettarsi davvero non lo sappiamo. Non è ancora mattina in America.