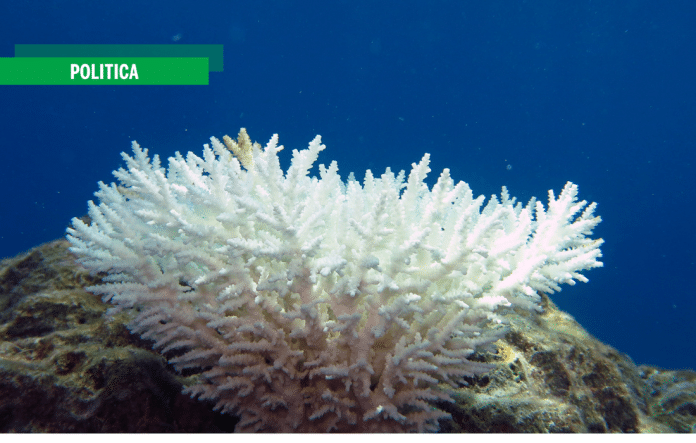Mentre percorriamo la strada sterrata che da Siteki si inoltra nell’altipiano di Lubombo, Richard solleva una mano dal volante per indicarmi alcune persone poco distanti da noi. In una pozza di fango, tra le sterpaglie dei campi dell’arido inverno sudafricano, una donna sta china con i piedi nell’acqua. Vicino a lei, due bambini fanno la spola tra la pozza e una carriola, portando dei secchi di plastica, per lo più rotti, che la donna riempie con l’acqua putrida che esce dal fango. Acqua verde, opaca e maleodorante, raccolta dal terreno tra pezzi di tronco e rifiuti messi lì da qualcuno per evitare che le bestie calpestino la preziosa sorgente. Tutto intorno l’altipiano appare deserto, povere case a qualche centinaio di metri, qualcuno a piedi in lontananza. L’acqua è poca nella stagione secca e questa donna, come molti altri nelle aree rurali dell’Eswatini, cammina per chilometri tutti i giorni, con i bambini e la carriola, per trovarla.
Richard mi spiega queste cose mentre scendiamo dal fuoristrada e ci avviciniamo alla signora. A sentire l’odore che ci avvolge quando arriviamo alla pozza verrebbe da pensare che quell’acqua sia per le bestie, se non fosse che la donna alza il secchio appena riempito, lo avvicina alle labbra e beve un sorso prima di rimettersi a pescare tra la terra e i rifiuti quell’acqua che servirà per le bestie, ma evidentemente anche per la famiglia. Dopo aver scambiato qualche parola, salutiamo la donna e i bambini mentre riprendono la raccolta. La scena che ci lasciamo alle spalle è una delle tante che, tra queste montagne, raccontano di una situazione molto articolata e complessa.
L’accesso all’acqua potabile è uno dei grandi temi dello sviluppo dell’Africa e si ricollega spesso a problematiche sociali e politiche ben più profonde; il Regno di Eswatini, incastonato nella zona montuosa tra Sudafrica e Mozambico, è paradigmatico. Ultima monarchia assoluta del continente, sconta l’incapacità di rispondere alle necessità di servizi di base dei suoi abitanti, dispersi nelle aree rurali lontane dalle principali città. Circa un quarto della popolazione vive fuori dai contesti urbani, in zone caratterizzate da un tasso di povertà e da una disoccupazione strutturale molto elevati, a cui va aggiunta la quasi totale mancanza di servizi pubblici che dovrebbero garantire diritti di base come l’accesso alle cure, l’istruzione e la distribuzione dell’acqua potabile. In assenza di un serio intervento pubblico, i servizi essenziali sono spesso forniti dalle organizzazioni umanitarie internazionali, che si sostituiscono di fatto a quella che dovrebbe essere l’azione governativa e che generano così una dipendenza strutturale dagli aiuti dall’esterno. Oltre a condizionare politicamente il Paese, questa situazione diventa ancora più problematica con la riduzione dei finanziamenti alle organizzazioni internazionali e ai progetti di sviluppo che si sta verificando negli ultimi anni.
L’atto più clamoroso è quello della chiusura dell’Usaid a opera del presidente americano Trump all’inizio del suo secondo mandato, ma anche l’Unione europea sta progressivamente riducendo gli stanziamenti, rischiando così di generare crisi molto gravi in contesti vulnerabili come nel caso dell’Eswatini. Da queste dinamiche emerge come necessario un approccio non assistenzialista dell’intervento umanitario che permetta di generare pratiche e servizi garantiti nel lungo periodo, questione fondamentale nel caso della fornitura dei servizi essenziali. Per capire l’importanza dell’accesso all’acqua potabile bisognerebbe sentire l’odore di quell’acqua che potabile non è, e bisognerebbe vedere gli sguardi persi di quei due bambini con i secchi in mano per capire cosa significa vivere con meno di un dollaro al giorno.
Basterebbe questo per rendersi conto di quanto siano importanti i progetti che cercano di porre rimedio a situazioni simili. Di queste dinamiche parlo con Richard Masimula, coordinatore per l’elaborazione dei piani locali di adattamento e per la componente acqua in Eswatini, mentre riprendiamo la strada. Richard lavora per Cospe, un’organizzazione di cooperazione internazionale attiva qui e in molti altri Paesi, con progetti a sostegno delle comunità rurali e con iniziative di inclusione, giustizia sociale e di partecipazione democratica. Lavora da anni con le comunità di queste zone, sembra conoscere ogni persona e ogni buca che incontriamo lungo la strada di sassi e polvere. Dopo pochi chilometri Richard mi indica un’altra pozza. Attorno, un altro mondo. Una ventina di persone, uomini e donne, giovani e meno giovani, con fango e polvere mischiati addosso. In mano hanno badili, picconi, pezzi di stoffa. Alcuni vestono di stracci o con i vestiti della festa. Due di loro hanno giacche blu da lavoro, sono infangati come gli altri e ai piedi hanno stivali di gomma bucati, parte di una divisa che li distingue dal resto del gruppo: sono i due tecnici del servizio idrico pubblico per le zone rurali, il Rural Water Supply.
Sono qui per trasformare l’acqua putrida delle fonti in acqua pulita, potabile, per tutta la comunità. Non con un miracolo, ma applicando conoscenze e tecniche per costruire filtri di terra e pietre. Richard mi accompagna verso il campo mentre indossa anche lui la giacca da lavoro. Camminando, mi descrive cosa stiamo per vedere. Strutture apparentemente rudimentali di terra e pietre: la costruzione dei filtri si basa sull’impiego di materiali reperibili in loco e sulla trasmissione di competenze che permettano agli abitanti di replicarli e manutenerli, senza dipendere dall’aiuto di altri. Per cominciare, una volta individuata la fonte e liberata dalle sterpaglie, si scava un piccolo canale per indirizzare l’acqua verso una pozza scavata appositamente alcuni metri più a valle. Lungo il canale vengono messe delle pietre, in modo che l’acqua corrente, passandovi in mezzo, depositi sabbia e terra.
Nella pozza viene posizionato il filtro vero e proprio, un cilindro di cemento riempito di pietre: l’acqua, con l’aiuto della fisica, lo riempirà dal fondo e sgorgherà da un tubo. Pulita. Da qui proseguirà il suo percorso verso le vasche di raccolta e verrà controllata e analizzata periodicamente per assicurarne la potabilità. Bastano pochi giorni per costruire un filtro, il lavoro è faticoso e completamente manuale, ma la sincera e numerosa partecipazione della comunità permette di distribuire bene gli sforzi. «Oggi c’è poca gente», mi dice una donna mentre mi passa vicino, «perché c’è il consiglio della comunità». Mi fa capire che di solito sono persino di più. Nel silenzio della campagna, rotto solo dalle voci e dal lavoro della terra, sembrano non percepirsi altre questioni che, soprattutto nelle città, risuonano in modo più evidente ma che hanno comunque riflessi nelle periferie.
L’Eswatini sconta problemi politici profondi, emersi con forza nelle violente proteste del 2021. Giovani sempre più istruiti ma senza lavoro e senza prospettive hanno iniziato a chiedere riforme e un’apertura delle istituzioni in senso maggiormente democratico e partecipativo. La monarchia ha risposto con una sanguinosa repressione e con la persecuzione degli attivisti coinvolti nelle proteste. Alcuni sostengono che la violenza della polizia e dell’esercito sia stata dovuta a una sostanziale incapacità, da parte del governo, di ascoltare le istanze della popolazione, abituato com’è a prendere ordini ed eseguire le direttive della Corona. Dalle proteste è emersa una richiesta di partecipazione che non è stata colta, che resta latente e che dovrà svilupparsi tentando altre strade, più graduali ma più radicali nelle premesse politiche. In questo senso la presenza di organizzazioni come Cospe assume un’importanza non solo economica, ma anche sociale e politica, che riguarda l’introduzione e il sostegno di dinamiche partecipative che emergono come istanze nella società civile, nelle città come nelle zone rurali.
Nelle città il fermento è più evidente e si esprime in organizzazioni e movimenti civili e culturali, pur senza sfociare in esplicite richieste politiche, essendo i partiti formalmente vietati dalla legge. Nelle campagne la situazione è più complessa, in quanto la necessità di soddisfare i bisogni primari sembra prendere il sopravvento sulle altre questioni. Considerare solamente questo aspetto nell’analisi e nell’intervento significherebbe ricadere in un assistenzialismo fine a sé stesso. La lungimiranza del lavoro che si svolge qui sta invece nel connettere le questioni di base con le istanze partecipative attraverso pratiche che permettono di esprimere e soddisfare entrambe queste necessità.
È sufficiente passare una giornata nei campi, tra questa gente, per rendersene conto. Nonostante le persone al lavoro siano molte, pochi parlano e anche la voce dei tecnici si sente di rado: non c’è bisogno di molte indicazioni, ognuno sembra sapere cosa deve fare. La loro presenza è però importante: quando non ci sono, la qualità e i ritmi di lavoro calano, probabilmente perché manca una guida pratica. Per ovviare a questo, al gruppo di lavoro vengono lasciati dei compiti che saranno verificati al giro successivo, tipicamente dopo una settimana: terminare la posa delle pietre, piantare i pali per i recinti, proteggere le opere con i teli impermeabili. Più delle indicazioni è importante l’esempio che i tecnici danno agli altri. Attraverso la loro pratica instancabile fanno percepire l’urgenza di quello che stanno facendo, di un progetto che avrà un impatto enorme sulla salute e sul futuro della comunità. Insegnando il lavoro a chi li segue, trasmettono competenze e conoscenze tecniche, ma anche un’attitudine al lavoro collettivo, alla cura dei beni comuni e all’autoresponsabilizzazione.
Il coinvolgimento attivo dal basso fa sì che questo tipo di progetti abbiano profondi impatti sociali. I fondi per implementarli, pur arrivando da organizzazioni non governative internazionali (in questo caso dalla cooperazione tedesca del Giz – Deutsche Geselleshaft fur internationale Zusammenarbeit), vengono impiegati sulla base di valutazioni delle necessità locali, attraverso pratiche partecipative e di risk assessment per i vari territori: si individuano zone a rischio e si progettano soluzioni che siano in grado di ridurlo. L’accesso all’acqua potabile è uno dei maggiori fattori di rischio per la salute collettiva nelle zone rurali. Nella progettazione dei filtri la scelta è quella di intervenire coinvolgendo gli attori direttamente interessati, gli abitanti stessi, in modo da ridurre la dipendenza dagli aiuti esterni e generare pratiche che possano essere replicate e sviluppate dalla comunità stessa.
Un approccio di questo tipo ha effetti diretti sulla popolazione non solo in termini di salute, ma anche di riduzione di vulnerabilità sociali e politiche, spesso causa ed effetto del disagio. Comunità resilienti, partecipi e più sane hanno un minor impatto in termini di sanità pubblica e di dipendenza dagli aiuti governativi, spesso completamente assenti e messi in ginocchio dalla riduzione degli aiuti internazionali su cui si basava il sistema pubblico. Il governo stesso tende ad appoggiare queste iniziative, come testimonia la presenza dei tecnici del Rural Water Supply. Di fatto il sistema pubblico viene sollevato da oneri di cui non riesce o non vuole prendersi carico e, al tempo stesso, accetta più o meno tacitamente che nuovi valori e nuovi modelli di partecipazione vengano sviluppati o incentivati. Talvolta ostacoli e intromissioni derivano dalle autorità locali, in quanto percepiscono queste iniziative come qualcosa che le scavalca: l’attivazione dal basso per far fronte a problemi quotidiani delegittima un’autorità che non è in grado di risolverli.
Un ultimo aspetto fondamentale da considerare è quello dell’indipendenza dagli aiuti. Importare tecnologie aliene obbligherebbe a far sempre affidamento su entità esterne per il funzionamento e la manutenzione degli impianti. Questo sarebbe problematico sia a livello di singolo progetto, in quanto metterebbe a rischio la continuità di un servizio essenziale, sia a livello aggregato: un Paese che si basasse su questo sistema diverrebbe dipendente dagli aiuti e dall’intervento esterni, che potrebbero diventare strumenti di influenza politica e ingerenza economica, quando non fonti di vera e propria dipendenza se considerati su larga scala. In questo senso l’influenza dei Paesi occidentali, i maggiori investitori in progetti di sviluppo, si può rilevare in vari modi. L’ultimo e più eclatante episodio riguarda i rapporti con gli Stati Uniti: recentemente cinque migranti detenuti nelle carceri americane per gravi reati sono stati deportati in Eswatini.
Come riporta Afp, questi prigionieri sono stati messi nelle stesse carceri dei parlamentari imprigionati per le proteste del 2021, rivelando quindi un’ulteriore problematica di tutela dei diritti umani nel Regno. Emerge quindi come necessario prestare la massima attenzione nel programmare interventi che non vadano ad alimentare queste dinamiche e che rendano possibile uno sviluppo indipendente e partecipativo. Quando il sole comincia a calare nessuno si è ancora fermato per riposare né per mangiare. Un po’ di stanchezza si comincia a percepire sui volti e la luce mette in risalto il sudore sulla pelle dei visi. Mi dicono che le tonalità di pelle più scure sono associate alla povertà, al lavoro all’aperto, nei campi. Qui effettivamente sono tutti molto scuri e molto abili nel lavoro della terra.
A fine giornata hanno fango ovunque, chi ha gli stivali li ha pieni, chi è a piedi nudi è come se avesse gli stivali, tanto è spesso lo strato di fango. Le mani fanno un tutt’uno con la terra, le lavano nell’acqua sporca e le asciugano strofinandole sulle cortecce degli alberi. Gli sguardi sono sereni, come quelli di chi ha fatto un buon lavoro. Mentre dal vicino villaggio arrivano alcune donne con le pentole a segnare la fine della giornata, l’ultima questione è quella della protezione delle fonti e dei filtri. L’impianto viene sigillato con teli, terra e argilla, in modo che le piogge non vadano a contaminare l’acqua di sorgiva; vengono tagliati alberi e fronde per coprire temporaneamente le zone di lavoro. Tutto attorno verranno piantate le reti per evitare il calpestìo delle bestie e delle persone di passaggio. All’interno della recinzione si lasceranno crescere gli alberi e tra pochi mesi si vedrà ben poco di quel che è stato fatto in questi giorni. Se ne vedranno gli effetti per molti anni a venire. Sebbene possa sembrare un piccolo spaccato di una realtà complessa, da questo punto di osservazione si possono vedere molte cose.
Si può osservare un Paese che cambia dal basso, dalle comunità che lo compongono. Comunità che sviluppano ed esprimono valori e istanze costruite nella vita quotidiana, che diventano necessità e patrimonio comune; principi che, pur non essendo urlati nelle piazze, entrano a far parte della cultura collettiva, della pratica di tutti i giorni, e così sedimentano e diventano base di partenza per le generazioni future.
Testo e foto di Nicola Bonardi