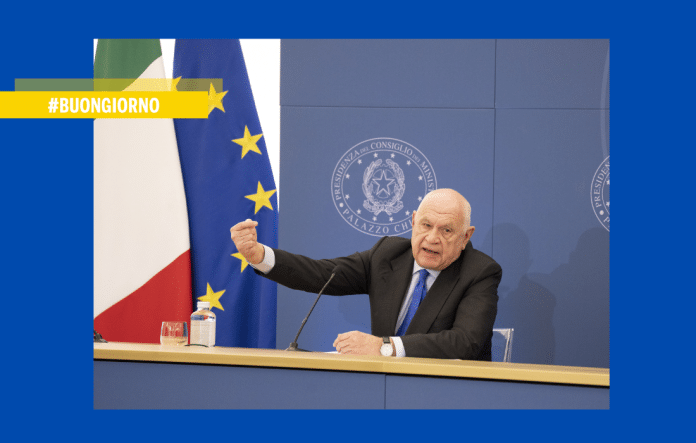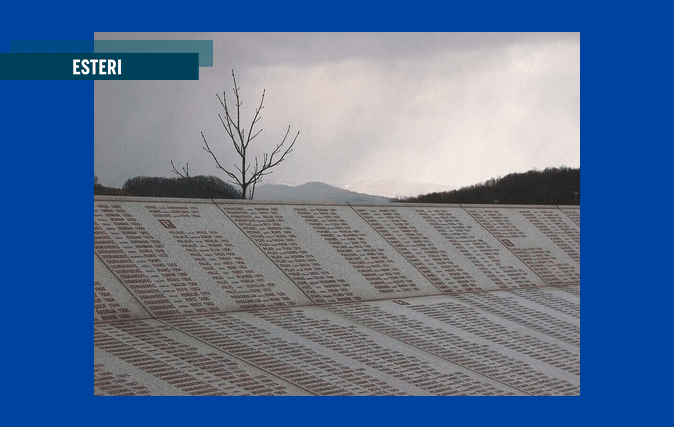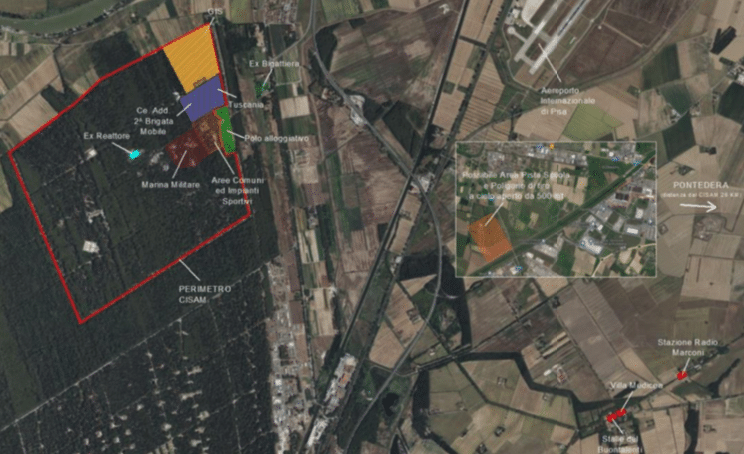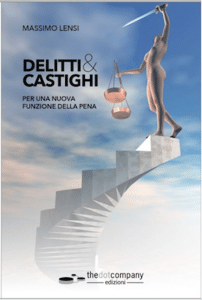Tra i protagonisti della decima edizione dell’Elba Book festival che si apre il 16 luglio c’è Niccolò Nisivoccia. Con “la storia di ognuno” punta a riportare la scrittura a un approccio empatico e inclusivo. Lo abbiamo intervistato
Scrivere è prestare attenzione alla realtà, è prendersene cura attraverso l’uso della parola. Su questo tema interviene il 16 luglio, alle 21:30, lo scrittore e giurista Niccolò Nisivoccia inaugurando il primo dibattito del festival dedicato all’editoria indipendente, “Alla ricerca di un’attenzione collettiva”, insieme al graphic journalist Gianluca Costantini e a Laura Paracini, attivista di Ultima Generazione, moderati dal giornalista Stefano Biolchini. Oltre alla conoscenza interiorizzata del paesaggio isolano, aspro quanto rigoglioso, a portare nuovamente Nisivoccia sul Tirreno è stata la pubblicazione de La storia di ognuno, edito di recente da Castelvecchi. Si tratta di dieci vissuti accomunati dal soggiorno nella Casa della Carità di Milano, della metropoli più frenetica del nostro Paese, avendo trovato in essa un luogo di accoglienza. Uomini, donne, giovani, anziani, famiglie intere, italiani, stranieri, profughi, richiedenti asilo: abbandonando qualsiasi posa o barriera stilistica per abbracciare un approccio empatico, l’autore ha passato in rassegna «un’umanità composita e dolente», ossia chiunque abbia avuto bisogno di essere accolto e ascoltato, al di là di qualunque categoria o classificazione superficiale del dolore e delle difficoltà.
«Alla base della della nostra casa c’è la capacità semplicemente umana e umanitaria di mettersi dalla parte dell’altro. Difatti la struttura potrebbe offrire anche solo un letto, una doccia, un pasto, un supporto psicologico o legale, un’assistenza diurna. Ma anche qualcosa di più, a chi lo volesse, a chi fosse disponibile a riceverlo; potrebbe offrire sostegno nella ricostruzione di un futuro, ad esempio, nello studio o nella frequentazione di un corso professionale, o nell’apprendimento di un mestiere», racconta Nisivoccia.
Da subito si palesa un libro di incontri, che ha composto con la necessità di elidere il suo “io”, per quanto illusorio. «Ho tentato di farlo scomparire affinché affiorasse solo l’io di chi di volta in volta si espone. Tuttavia l’io di chi scrive è comunque sempre presente, sebbene contro la sua volontà; perciò mi sono concentrato su una forma di riscrittura, il più possibile neutrale e aderente alla versione orale dei miei protagonisti. Ogni storia è frutto di svariati incontri con chi me l’ha riportata: loro parlavano, io prendevo appunti – cercando di rispettare persino la consecuzione delle parole che mi venivano riferite, come se le stessi registrando – ma senza anteporre uno strumento fisico, un gesto meccanico e lontano dalle sensazioni che il ritmo delle singole voci mi avrebbe trasmesso a presa diretta. È una serie di testimonianze che andavano salvate dall’oblio per il grado di coinvolgimento che producono nel lettore».
Vite che non sono la mia (Adelphi, 2011) è un celebre titolo di Carrère. E anche queste sono vite distanti, spesso estreme, ma che potrebbero riguardarci. Certo, il suo punto di vista rimane esterno. Dunque in cosa consiste questo avvicinarsi con l’altro da sé?
«L’identificazione nella vita di un altro non è mai veramente possibile, e lo è ancora meno quando le culture di appartenenza sono diverse. Pensarlo sarebbe non solo illusorio, ma anche ipocrita, e addirittura arrogante. Non a caso, nella premessa cito una pagina di un giornalista canadese, Matthieu Aikins, che ha viaggiato per mesi dall’Afghanistan all’Europa insieme a un migrante fingendo di esserlo a sua volta, e traendone poi un volume illuminante, Chi è nudo non teme l’acqua (Iperborea, 2023). Aikins avrebbe il diritto di rivendicare un’identificazione nell’esistenza di un migrante costretto a lasciare il suo Paese: ha viaggiato non solo con uno di loro, ma come loro, mettendo in pericolo il suo corpo e il suo presente».
Eppure il premio Pulitzer è il primo ad ammettere che un’identificazione non sia possibile…
«Cito testualmente le sue parole quando dice che non può pretendere di essere stato davvero un rifugiato, tantomeno di capire cosa significhi esserlo, e quando ribadisce che la sua epica inchiesta intende mostrare tale impossibilità. Riconoscerla è doloroso, poiché vorremo fossimo riconosciuti come tutti uguali, e che uguaglianza e solidarietà alla fine vincessero su tutto. Ma i confini esistono anche dentro di noi e non possiamo trascenderli con un atto di volontà.
Il concetto di attenzione presuppone che l’ascolto non sia sottovalutato. Ma in assenza di esso come potrebbe l’incontro con l’altro toccare l’interlocutore sotto pelle e misurarne i limiti?
Finendo per scompaginare il suo ordine precostituito e, ahimè, pregiudiziale. In primis, è una questione di rispetto: ascoltare significa riconoscere al prossimo che abbiamo davanti una sua autonoma e singolare dignità di essere, offrendogli il tempo e lo spazio per manifestarsi oltre le apparenza. E senza pretendere di sovrapporle intellettualismi, manierismi, interpretazioni di sorta. Ma soprattutto senza sovrapporle né il nostro sguardo, né il nostro vocabolario, né i nostri registri. Da un certo punto di vista, raccontare una storia altrui con parole nostre rischia sempre di essere anche un gesto violento. Il nostro sguardo sugli altri, a maggior ragione se provenienti da situazioni o contesti diversi dai nostri, quali che siano, è sempre uno sguardo non solo presuntuoso, ma pure invadente e di matrice coloniale.
In sostanza, ascoltare significa predisporsi al dialogo, restituendosi un senso a vicenda, nell’alternanza fra parole e silenzi. Ecco, lei rimarca un desiderio di condivisione e di vicinanza; il desiderio di sporgersi verso il mondo che aveva già messo nero su bianco con Il silenzio del noi (2023). Perché persevera nel recupero di un soggetto comunitario e aggregante?
Raccontare è un modo per fare i conti con i propri traumi. In arabo il termine “parola” proviene da “ferita” e parlare diviene un metodo per cui si curano ferite con altre ferite, sentendosi lacerati e purificati al contempo. I segmenti privati che ho raccolto nel volume condividono fragilità e disperazione. Sono vicende di guerra, esilio, abbandono e dipendenza dalla droga: ognuna contiene una luce, però, motivata dagli scarti del destino. Non sono trame di romanzi e per le persone che ho avuto di fronte, rivelarsi è valso per riconciliarsi con il proprio passato.
Elba book festival 2024
Da martedì 16 a venerdì 19 luglio, dopo il tramonto, nelle piazzette e lungo i vicoli di Rio nell’Elba, si svolgerà la decima edizione dell’Elba Book Festival. Scrittori, giornalisti, artisti e operatori culturali e tanti editori, Quest’anno gli stand saranno ventitré, tra cui Mimesis, Bietti, Le Plurali, Edicola Ediciones, Exòrma e Red Star. Tantissimi gli ospiti del direttore artistico Matteo Bianchi: da Carlo Lucarelli a Tomaso Montanari ( autore del recente, bellissimo Le statue giuste edito da Laterza)