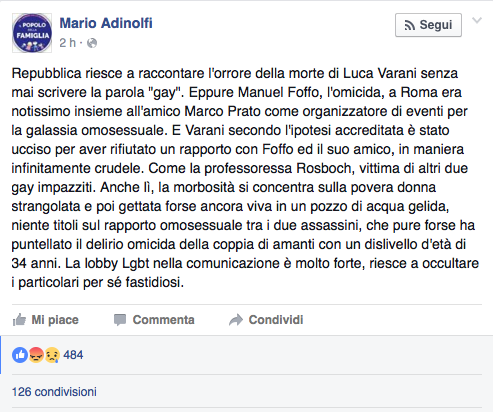Ogni giorno in Europa arrivano circa 2mila persone da Siria, Iraq e Afghanistan. Lo scorso ottobre l’Europa aveva stabilito che 160mila tra i rifugiati arrivati in questi mesi sarebbero stati ricollocati in diversi Paesi, una quota ciascuno. Quattro mesi dopo, ne sono stati ricollocati 700 e a Idomeni, come altrove, c’è la situazione che vedete ogni giorno nelle foto e nei filmati dei telegiornali e nella foto qui sopra: bambini, donne e uomini vivono così perché non ci sono risorse o volontà di dare loro una stufa, un tetto, una scuola.
Se c’è una cosa da ricordare di fronte all’accordo di principio (così lo definiscono, qui il testo in italiano) tra Europa e Turchia raggiunto la scorsa notte è proprio questa. Sarebbe difficile da implementare se ci fossero quell’unità d’intenti, partecipazione, volontà che invece mancano. Figuriamoci nella situazione data. Europa e Turchia hanno dieci giorni per limare l’accordo e discutere dei particolari, un nuovo summit è infatti fissato per il 17 e 18 marzo.
Cosa dice l’accordo
L’Europa ha accettato di raddoppiare la cifra destinata al governo di Ankara (6 miliardi di euro invece di 3), un programma più snello di visti di ingresso per i cittadini turchi e, questo il punto importante, l‘introduzione di un sistema di scambio di rifugiati: le persone che sbarcheranno illegalmente in Grecia, rifugiati o meno, torneranno forzatamente in Turchia, da dove, per ogni persona rispedita oltre l’Egeo, verrà ammesso un rifugiato siriano. L’idea di fondo dell’accordo è mandare un segnale: non si entra più se non si è rifugiati siriani e, anche se lo si è, occorre fare domanda da un Paese terzo e non prendere una barca. Così, dicono a Bruxelles, si disincentiva la migrazione economica, finiscono i morti in mare e la si finisce con le emergenze umanitarie come quella a cui assistiamo in queste ore a Idomeni. Infine c’è l’annuncio dell’accelerazione del processo di valutazione relativo all’ingresso della Turchia nell’Unione europea.
Qui cominciano i problemi.
Il primo è proprio riferito all’accordo dello scorso ottobre: perché stavolta i Paesi che hanno fatto di tutto per evitare di implementare l’accordo sulla redistribuzione dei rifugiati in base a quote stabilite (e assistenza economica) dovrebbero accettare di farsi carico dei rifugiati provenienti regolarmente dalla Turchia? Il premier britannico Cameron ha già detto che Londra non ci pensa nemmeno. Quello ungherese Orban – che ha diversi simpatici alleati – ha invece annunciato il veto. Insomma rimane difficile capire se in 4 mesi si sono mosse 700 persone già presenti in Europa, cosa dovrebbe rendere il nuovo sistema di accoglienza più efficace.
Non solo: l’accordo è in contrasto con le leggi internazionali. Se io rifugiato sbarco in Grecia e chiedo asilo, sono le autorità greche che devono valutare la mia posizione. Espellere – per quanto in un Paese terzo – è probabilmente una violazione della convenzione di Ginevra (1951). Rispedire persone in un Paese che viola pesantemente i diritti umani è poi una violazione certa: come verranno trattate le persone rispedite in Turchia? I curdi, gli iracheni, gli afgani, che fine faranno?
Infine, se l’Europa decide di accogliere una persona rifugiata dalla Turchia per ogni persona che dalla Grecia viene riammessa in territorio turco, più persone passeranno il mare, più persone lasceranno la Turchia. Ankara, insomma, ha un incentivo a far partire le barche. Quanto poi al problema di gestire la riammissione verso i Paesi terzi – ovvero quelli di origine dei migranti o richiedenti asilo che non avranno i requisiti per tornare verso l’Europa – la Turchia avrà a sua volta un problema enorme. Oppure no: rispedirà la gente a casaccio, che i diritti e l’incolumità di quelle persone sia garantita o meno (il problema di rimandare le persone in un Paese che non rispetta i diritti umani è anche questo).
La debolezza dell’Europa
Ieri a Bruxelles erano 28 contro 1 e sembra proprio che Ankara abbia avuto risposte positive su quasi ogni cosa che chiedeva. C’era un accordo quasi scritto prima di ieri, ma al suo arrivo a Bruxelles, il premier Davutoglu ha spiegato che le richieste erano altre, ha alzato il prezzo e i 28 hanno più o meno deciso di pagare. L’Europa è così debole, divisa al suo interno e in preda al panico per la crisi dei rifugiati e le sue conseguenze politiche – la crescita dei partiti xenofobi, l’impopolarità dei governi – che ha alzato le mani di fronte alle richieste di Ankara. Non è un problema di dignità o nazionalismo europeo, ma un segnale di debolezza. Nello stesso momento esatto in cui Ankara accelera nel suo attacco ai diritti umani in Kurdistan e alla libertà di stampa – oggi un’altra irruzione in un’agenzia di stampa di opposizione – l’Europa non trova di meglio che cedere alle richieste di Erdogan su tutta la linea. Certo, ci sono i richiami ai diritti umani. E certo, il premier Davutoglu a Bruxelles ha giurato di essere un difensore della libertà di espressione.
Ma la verità è un’altra: la Germania voleva un accordo a tutti i costi e la Commissione vede la cooperazione con la Turchia come l’unica strada possibile per uscire in qualche modo dalla crisi dei rifugiati. Le altre strade – come anche le quote interne – sono fallite e il clima politico è tale che non sembrano esserci altre vie. Di fronte a una crisi vera l’Europa è divisa più che mai. E così la bozza di accordo – vedremo tra dieci giorni se se ne troverà uno – è debole in ogni senso: è una sconfitta politica, segna un precedente (chi gioca scorretto vince) e, quanto ai rifugiati, non affronta il problema vero: garantire un’accoglienza decente a queste migliaia di persone e lavorare per restituire loro un futuro.
Come si vive a Idomeni in questi giorni: le foto