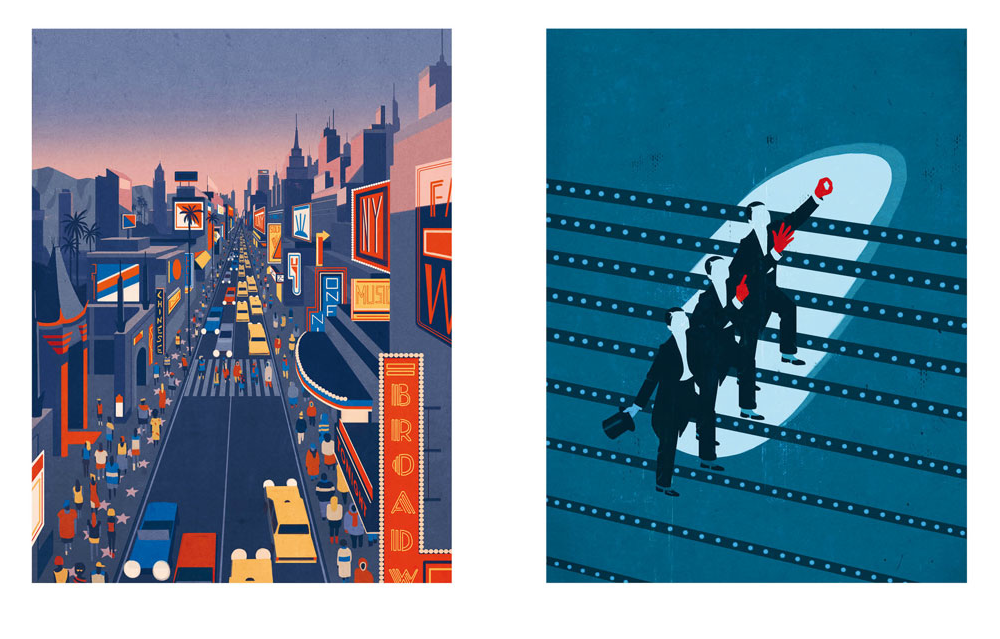In esclusiva per l’Italia, le Officine dell’Immagine di Milano fino al 16 aprile, ospitano una personale di Gohar Dashti, fotografa e artista iraniana capace di sintetizzare in uno scatto, come le sue improbabili e affollate scalette d’aereo in mezzo a radure desolate, le situazioni drammatiche, a volte addirittura paradossali, che si trovano a vivere profughi e migranti. Oppure capace di raccontare la tragedia della guerra attraverso un disarmante ritratto di ragazzi che cercano di costruirsi una casa nel deserto. Nata ad Ahvaz nel 1980, Gohar Dashti vive e lavora a Teheran e a Boston e con il suo lavoro fotografico ha raccontato i fermenti culturali e di rinnovamento che attraversano il tessuto sociale iraniano, con una propria cifra stilistica originale, in cui l’amarezza è sempre venata di ironia, con una forte carica di denuncia, ma senza perdere la tenerezza.

«La raffinatezza del suo lessico, strettamente connesso a un’implicita connotazione autobiografica, si traduce in una simmetria creativa audace e incisiva, dove l’estetica dell’allegoria si scopre come costante elemento focale», scrive la curatrice Silvia Cirelli, artefice di questa mostra milanese intitolata provocatoriamente Limbo e che prende vita mentre il Florida Museum of Photographic Art dedica una ampia retrospettiva a questa artista diventata un punto di riferimento del pubblico più giovane in Medio Oriente e che ha riscosso molta attenzione con mostre al Victoria and Albert Museum di Londra e nei musei di Tokyo, Boston e Washington.
Limbo prende spunto dalla serie Stateless (2014-2015) realizzata in un remoto paesaggio desertico nell’isola di Qeshm, territorio iraniano sul Golfo Persico. Paesaggi desertici e radure desolate fanno da sfondo a ritratti malinconici di giovani che appaiono vulnerabili, senza mezzi, ma mai arresi, nemmeno nelle situazioni più difficili ed estreme, quando intorno a loro non ci sono più tracce di contesti urbani e abitabili.

«È questo silenzioso senso di abbandono e il dolore della separazione dalla propria terra, dalla propria cultura e storia – sottolinea Cirelli – ciò che hanno ispirato Gohar Dashti nella realizzazione di queste serie poetiche, un progetto che assorbe la sofferenza della difficile condizione di profugo ed esiliato, restituendo l’identità di una memoria a chi purtroppo, a causa di guerre, malattie o soprusi, è stato costretto ad abbandonarla».

Nei trittici del progetto Me, she and the others (2009), anch’essi in mostra a Milano, Gohar Dashti si occupa in modo particolare della questione femminile e del ruolo della donna nella cultura iraniana raccontando le donne al lavoro, nella propria abitazione e nelle strade, attraverso gli abiti e l’obbligo di indossare sempre il velo. Senza mai adottare uno sguardo giudicante, la fotografa iraniana cerca di cogliere il vissuto emotivo delle protagoniste e come cambia la loro immagine dentro e fuori casa, in un mondo musulmano che le costringe a nascondersi in pubblico. «Attraversato da molte contraddizioni socio politiche, l’Iran ha una millenaria e raffinata fisionomia politica, in cui convivono modernità e tradizione islamica, libertà creativa e di ricerca e dall’altro lato censura e conservatorismo – commenta Silvia Cirelli -. Il conflitto è molto aspro e la vita privata e pubblica sono nettamente separate tanto da sembrare opposte».
[social_link type=”twitter” url=”https://twitter.com/simonamaggiorel” target=”on” ][/social_link] @simonamaggiorel



 In Toscana il casus belli è stato il referendum che si è tenuto a Cutigliano e Abetone: pur con risultati contrapposti (un comune ha votato sì e l’altro no), a gennaio il consiglio regionale ha approvato la fusione dei due comuni. E l’intenzione della Regione è quella di tagliare ancora, visto che a fine legislatura, ha detto il presidente del consiglio regionale Giani, si arriverà da 278 a 250 comuni. La Regione spinge per le fusioni anche grazie a incentivi per i comuni che si fondono.
In Toscana il casus belli è stato il referendum che si è tenuto a Cutigliano e Abetone: pur con risultati contrapposti (un comune ha votato sì e l’altro no), a gennaio il consiglio regionale ha approvato la fusione dei due comuni. E l’intenzione della Regione è quella di tagliare ancora, visto che a fine legislatura, ha detto il presidente del consiglio regionale Giani, si arriverà da 278 a 250 comuni. La Regione spinge per le fusioni anche grazie a incentivi per i comuni che si fondono.