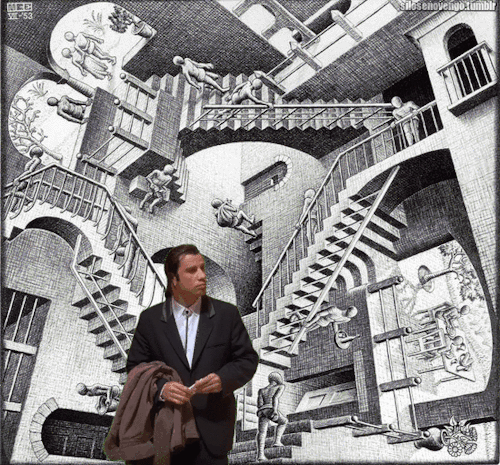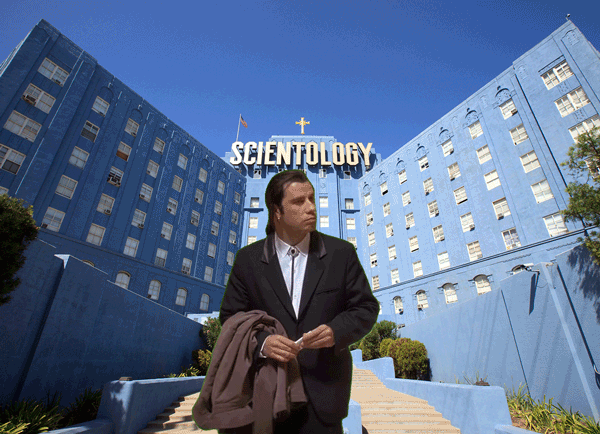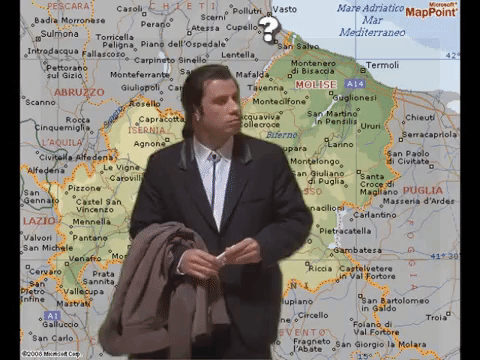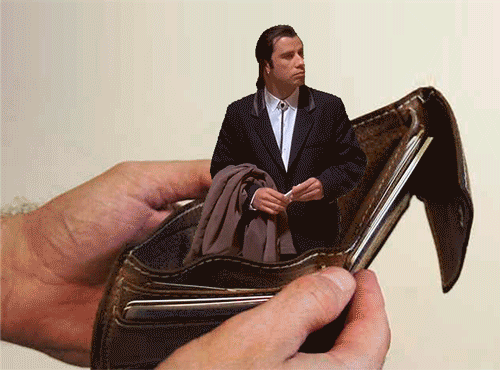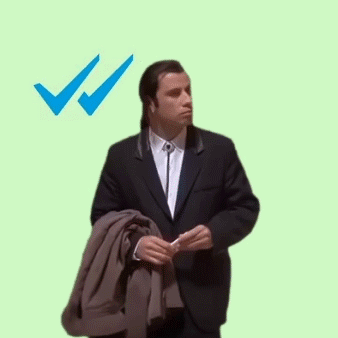La storia dell’arte non si insegna più nelle scuole dopo la riforma Gelmini, ma riscuote sempre più interesse in rete, dove negli ultimi anni sono nati molti siti che parlano di arte in modo competente, intercettando un interesse forte da parte anche dei giovani. Uno degli esempi migliori è Storie dell’arte. Abbiamo chiesto al critico e storico dell’arte Sergio Momesso che è il fondatore di raccontarci come è nata questa bella avventura.
Sergio, come è nato il sito Storie dell’arte?
Il primo post è uscito nel gennaio 2011, ma avevo cominciato a pensarci seriamente alla fine del 2010. Allora, dopo anni di esperimenti, mi limitavo ad usare i social, soprattutto Twitter, per condividere conoscenze e informazioni utili allo studio e alla ricerca, ma i miei interlocutori stavano quasi tutti fuori d’Italia, anche molto lontano. In Australia, per esempio, avevo amici attivissimi. Invidiavo molto la disinvoltura con cui i colleghi stranieri trattavano sul web di Raffaello e Michelangelo, Giorgione e Tiziano con la stessa cura e precisione con cui avrebbero scritto su una rivista accademica. Qui da noi invece questa apertura in fondo era guardata ancora come una macchia nel curriculum di uno storico dell’arte. Ovviamente, ciò mi sembrava una ristrettezza culturale insopportabile. Tra un social e l’altro avevo conosciuto anche colleghi italiani molto più giovani, liberi dai pregiudizi sull’uso della rete, e che spesso stavano completando il loro dottorato di ricerca. Tra questi c’era Serena D’Italia. A lei una sera di dicembre, via chat, anche se non ci eravamo mai incontrati (lei stava a Torino io a Treviso), ho chiesto di aiutarmi ad aprire un blog. Volevo creare un gruppo di lavoro non per far nascere l’ennesima rivista accademica, magari online, ma per una forma molto più semplice e informale di pubblicazione, alla portata di tutti e pure un po’ anarchica, per far circolare, con profondità, leggerezza e rapidità, conoscenze, bibliografie, segnalazioni e materiali troppo spesso confinati nelle università o in pubblicazioni quasi inaccessibili. Il gruppo si è subito ampliato e con l’aiuto di Marialucia Menegatti abbiamo trovato modi e strategie per farci conoscere ad un pubblico molto vasto.
Perché facendo un lavoro di studio e di ricerca hai sentito l’esigenza di confrontarti con il mondo della rete? Qual è l’obiettivo?
È stata l’esigenza di una apertura verso l’esterno, come raccomandava pure Giovanni Romano in quel libretto da cui abbiamo tratto il nome “Storie dell’arte”. Confrontarsi con la rete significa rendersi disponibili a discutere e a confrontarsi con chiunque, obbligandoci, in primo luogo, a parlare una lingua comprensibile. Ci si confronta infatti con problemi di comunicazione e di linguaggio. L’obiettivo iniziale di “Storie dell’arte” è stato quindi il desiderio di creare uno spazio, fatto di pubblicazioni quotidiane sul blog e sui social, dove mettere in circolazione conoscenze ed esplorare le potenzialità comunicative della rete, ricercando un linguaggio nuovo, adatto a questo tipo di strumento. Uno spazio sempre in evoluzione, che ci costringe positivamente a ricercare soluzioni nuove e a confrontarci con la realtà costantemente.
Roberto Longhi diceva che la storia dell’arte è una lingua viva, ma in molte scuole italiane, dopo la riforma Gelmini non viene più insegnata. Non è una contraddizione in termini per il cosiddetto Bel Paese?
In realtà le conseguenze di quella riforma sono un po’ più complesse. Le abbiamo discusse a lungo l’anno scorso: se nei licei classici le ore di storia dell’arte sono aumentate, seppur poco, nei professionali e nei tecnici sono sparite o ridimensionate. La vera cancellazione è avvenuta con l’eliminazione delle sperimentazioni. Ma il risultato, in ogni caso, è che la storia dell’arte nelle scuole è una materia che soffre da anni di un pericoloso ridimensionamento. Certo, è una delle molte contraddizioni del nostro Paese, ma credo lo sia ancora di più in un mondo dominato dalle immagini, dove tutto è stimolo visivo e dove quasi tutti i ragazzi ormai ragionano per immagini e avrebbero bisogno di sviluppare l’intelligenza visiva: quanto sono molto più ricchi di immagini e poveri di testi i manuali scolastici di oggi rispetto a quelli del passato! Studiare la storia dell’arte – e lo stesso potremmo dire per la musica – può essere fondamentale per l’educazione visiva di ogni persona sotto tutti gli aspetti. A mio avviso, che si chiami storia dell’arte o educazione visiva o qualcos’altro, questa materia dovrebbe essere fondamentale come l’italiano, l’inglese e la matematica. Ma ci si dovrebbe anche interrogare sulla qualità dell’insegnamento. Spesso mi viene in mente Amarcord di Fellini e la famosissima scena dell’insegnante di storia dell’arte di liceo che presenta ai ragazzi “Giotto, l’inventore della prospettiva”, inzuppando biscotti nel tè. È una stupenda presa in giro. Ma quante volte la storia dell’arte è stata bistrattata a scuola, tanto da dare ampio spazio a noia o disinteresse o ironia? Perché – ne ha parlato diverse volte Claudio Giunta – chi ha studiato storia dell’arte nelle facoltà di lettere, in quanto materia umanistica, e poi magari ha anche ottenuto un dottorato di ricerca in storia dell’arte non può insegnare ai licei scientifici o non può avere almeno un canale privilegiato per l’abilitazione all’insegnamento? Non credo sia solo un problema di classi di concorso, ma un problema politico e culturale molto serio.
Sul sito avete dedicato un interessante spazio proprio a Longhi, perché questa scelta? Si possono trasmettere e divulgare contenuti alti anche in rete? Che risposta avete avuto?
Non abbiamo mai nascosto la nostra formazione, nella quale il modo particolare di fare storia dell’arte di Longhi ha avuto un peso enorme. Il nostro primo post infatti parlava di “Storie dell’arte”, un libretto di Giovanni Romano che raccoglie saggi su Pietro Toesca, Roberto Longhi, Rudolf Wittkower e Giovanni Previtali. Abbiamo dato spazio a testi di Longhi, ma anche di Previtali, di Romano e rimesso in circolazione, traducendolo dal francese, un vecchio testo di Castelnuovo. Alcuni nostri post sono finiti nei programmi d’esame di alcuni corsi universitari. Quando ci è possibile utilizziamo o mettiamo semplicemente in circolazione testi importanti per la storia della critica d’arte o fonti antiche o testi letterari. Ogni tanto, da bravi blogger, pubblichiamo qualche intervista e ricerchiamo qualche intervento esterno. Tutto questo vorremmo continuare a farlo in modo informale, possibilmente senza retorica. A ciò si presta molto bene il linguaggio del blog. Intendiamo cioè perseguire l’idea che il web va “colonizzato” con contenuti alti, senza alcun limite in altezza, così come, sempre nel web, spessissimo, non c’è limite a cose di segno opposto. Vorremmo che dai motori di ricerca uscissero sempre più di frequente testi importanti e curati tanto quanto in un libro. Per questo crediamo sia importante, a discapito della velocità, controllare la redazione dei testi, anche solo le didascalie delle immagini. È un rigore che abbiamo imparato dai nostri maestri e ci pare ogni giorno più valido.
Il pubblico della rete è globale, ovviamente. Le nostre scelte hanno trovato un po’ alla volta un pubblico selezionato, che aumenta di giorno in giorno, grazie ad un mix di contenuti “alti”, più complessi e articolati nel blog, accanto a contenuti più semplici e apprezzabili in fretta nei social media. Beninteso, senza mai derogare al rigore di cui s’è detto: anche quando pubblichiamo una immagine su Facebook (circa una dozzina al giorno), ne controlliamo l’attribuzione, la cronologia, l’ubicazione e le informazioni tecniche per redigere una didascalia che è già, per noi, un frammento affidabile di ricostruzione storica e nello stesso tempo un esempio qualitativo da mandare in giro per il web.
In Italia negli ultimi trent’anni, con l’infelice slogan «beni culturali petrolio d’Italia» sono state attuate politiche di de-tutela, di indebolimento di presidi come le soprintendenze e talora anche di svendita di parti del patrimonio pubblico. Quale pensiero sostiene questa visione politica e dove porta?
Personalmente, non mi sembra ci sia un pensiero consapevole, quanto piuttosto il risultato di una cultura dove dominano incontrastate, come si dice, le logiche del mercato. Ma è una sofferenza che investe la cultura in generale. Se un’opera o un paesaggio o un documento storico non ci appaiono solo beni materiali, questo avviene perché li conosciamo, li abbiamo compresi e ne apprezziamo il valore o, meglio, i valori spirituali, come si diceva una volta. Ho la sensazione che, purtroppo, le politiche e gli interventi sulle strutture della tutela del patrimonio pubblico siano state spesso compiute da chi non solo non conosceva la storia dell’arte, ma non aveva talvolta neppure i rudimenti di una cultura visiva accettabile.
L’articolo 9 della Costituzione lega la tutela del patrimonio d’arte e del paesaggio alla ricerca e alla conoscenza, mentre l’articolo 3 dice che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana. Il rapporto con l’arte è un’esigenza profonda?
Certo. Come ho detto, il rapporto non solo con l’arte, ma con ogni testimonianza visiva – notoriamente il nostro paese è ricchissimo in questo senso – dovrebbe essere un momento fondamentale nella formazione di una persona. Non si tratta solo di aumentare le ore di storia dell’arte a scuola, ma di promuovere lo sviluppo di una cultura visiva consapevole. In questi anni sul web abbiamo imparato che la domanda di informazioni, precisazioni, materiali e, in una parola, di conoscenze è altissima, ma l’offerta è ancora troppo scarsa, non sempre all’altezza, raramente con un linguaggio comprensibile e spesso non sempre onesta. Non possiamo aspettarci che sia solo il sistema scolastico a dare questo tipo risposte. Molto si sta facendo, ma molto è ancora da fare.
[social_link type=”twitter” url=”https://twitter.com/simonamaggiorel” target=”on” ][/social_link] @simonamaggiorel