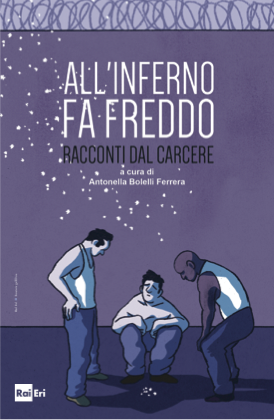(Parigi) L’avventura di Anne-Sophie Novel comincia due anni fa e si chiama “PlaceToBe”, una creative factory installata in un ostello vicino alla Gare du Nord per le due settimane della Conferenza Mondiale sul Clima di Parigi, la Cop21. Delusa dal fallimento della precedente conferenza di Copenaghen, Anne-Sophie si interroga sulle ragioni per le quali il messaggio ambientalista faccia così fatica a farsi strada nella mentalità comune. Le domande che si pone sono semplici: perché il peggior disastro annunciato di tutti i tempi non riesce a smuovere le folle? Perché non ci sono grandi manifestazioni in tutto il mondo per proteggere la cosa più preziosa che abbiamo, il nostro pianeta? La sfida è forse troppo distante dalle nostre preoccupazioni quotidiane? Non esiste un altro modo per parlare al mondo di questa emergenza?
La risposta che si è data è altrettanto semplice: il clima è un argomento complesso e stressante con il quale è difficile confrontarsi, provoca un senso di impotenza, di catastrofe imminente che ha un effetto paralizzante sulla gente. La comunicazione che è stata fatta finora sull’argomento non funziona. Bisogna raccontare un’altra storia capace di rovesciare il paradigma di sviluppo che ha condotto a questo stato delle cose. Gli interessi in gioco sono altissimi. E mentre i capi di governo fanno promesse che non potranno mantenere, occorre una mobilitazione dal basso che ci riguarda tutti. Adesso.
Incontro Anne-Sophie Novel nella hall della factory dove sta accogliendo Vandana Shiva, l’attivista politica e ambientalista indiana che ha deciso di stare qui durante i giorni della conferenza sul clima. Dormirà nell’ostello di “PlaceToBe” che dispone di 600 posti letto per militanti, giornalisti, artisti, esperti e chiunque voglia partecipare alle numerose attività previste nei prossimi giorni. Collegamenti radio, streaming televisivo, copertura dei social media, azioni concrete nella città: tutto ciò che accade qui dentro dovrebbe rimbalzare il più possibile all’esterno, proprio per evitare “l’effetto soufflé”, dice Anne-Sophie, che ha visto sgonfiarsi i buoni propositi di Copenaghen nell’arco di poche settimane, senza riuscire a coinvolgere la società civile che rappresenta invece uno strumento potentissimo di azione. Le persone devono sentirsi responsabili e coinvolte. Devono pensare che ciò che fanno o non fanno ha un impatto reale sulla vita quotidiana, sul loro star bene e su quello della collettività. L’argomento viene spesso trattato un modo moralistico o pessimistico, bisogna uscire dalla griglia riduttiva dell’ecologia perché la posta in gioco è la nostra stessa sopravvivenza.
Quali sono ad esempio le associazioni involontarie che facciamo quando pensiamo alla parola “ecologia”? Da un lato l’ecologia sembra legata a temi scientifici, scoperte di esperti che saranno anche vere ma che restano astratte, lontane dalla nostra esperienza quotidiana. La grande maggioranza degli studi sul clima dimostra l’esistenza di una stretta correlazione tra l’inquinamento e l’aumento della temperatura terrestre e prova che se nessuno fa niente nel 2100 la temperatura globale del pianeta aumenterà complessivamente di 4 gradi e di 6 gradi sulle terre emerse, in altre parole il caos, ma nessuno si straccia le vesti perché è come se non ci riguardasse, se non fossimo noi e i nostri figli a ritrovarci in questo caos dove l’acqua e il cibo si ridurranno drasticamente, la maggioranza delle specie animali e vegetali si estingueranno e molte delle terre emerse saranno sommerse provocando delle migrazioni di massa. Gli scienziati insistono su una data: 2030. Nel 2030 l’aumento della temperatura supererà i 2 gradi. Nel 2030 avrò 58 anni, i miei figli ne avranno 24 e 21. Praticamente è domani.
La parola “ecologia”, oltre ad essere considerata appannaggio di pochi esperti, può evocare anche un’ideologia militante e estremista, ci vengono in mente dei fricchettoni che si lavano poco, si vestono male, non mangiano carne, zappano la terra in comunità isolate e sono completamente disconnessi dalla modernità ecc… Ecco, sono queste percezioni sbagliate che devono cambiare, sostiene Anne-Sophie Novel.
Uno dei gruppi di lavoro al quale mi sono iscritta ha come titolo: “Dismantling the buying imperative”, (smantellare l’imperativo del consumo), ottimo argomento prenatalizio. Non che il clima a Parigi in queste ultime settimane inviti alla baldoria… Incontro persone da ogni parte del mondo, mi colpisce il fatto che molti di loro provengono dal sistema capitalistico neoliberista che rimettono in discussione. Ingegneri di multinazionali, esperti di marketing e finanza, promotori commerciali… persone che hanno deciso di cambiare vita dopo aver raggiunto livelli di malessere insostenibili. Uno dei principali ostacoli al cambiamento è proprio il fatto di sentirsi incastrati in un modello, senza riuscire nemmeno a immaginare un’alternativa possibile. Eppure le alternative esistono e coinvolgono un numero crescente di luoghi e di persone nel mondo. Come possiamo decolonizzare il nostro immaginario da concetti altamente intossicanti come il consumismo, il progresso e la crescita senza limiti? Per dirlo in altre parole: come faccio a spiegare ai miei figli che si può essere cool comprando di meno invece che comprando di più? Che anche un singolo gesto, moltiplicato per un grande numero di persone può fare la differenza? Che condividere dà più soddisfazione che possedere? Che la salvezza di tutti passa per una maggiore solidarietà tra nord e sud del mondo?
Al bar di “PlaceToBe” c’è una delegazione di indigeni australiani, un gruppo di artisti di strada congolesi, tre monaci nepalesi, molto rumore e un caffè annacquato. Le immagini della conferenza ufficiale sfilano sugli schermi che ci circondano. Dei ragazzi stanno montando un’installazione che dovrebbe spiegare come si forma il gas serra, altri stampano manifesti da appendere in giro per la città. Da qualche tempo ho l’impressione di oscillare pericolosamente tra la fiducia e la totale sfiducia nel genere umano. Quel che è certo è che stiamo ballando sull’orlo del baratro.






 Ed è proprio Yoko Ono con una tuba in testa, occhialetti neri tondi seduta come Marlen Dietrich ne L’Angelo azzurro, una delle dodici donne importanti scelte dalla fotografa. «Donne che hanno fatto cose importanti» ha detto alla presentazione del calendario a Londra Marco Tronchetti Provera per spiegare il nuovo corso dei calendari Pirelli che già, negli ultimi anni, va detto, avevano segnato una discontinuità con il passato. Ricordiamo solo quello con le immagini di SteveMcCurry del 2013.
Ed è proprio Yoko Ono con una tuba in testa, occhialetti neri tondi seduta come Marlen Dietrich ne L’Angelo azzurro, una delle dodici donne importanti scelte dalla fotografa. «Donne che hanno fatto cose importanti» ha detto alla presentazione del calendario a Londra Marco Tronchetti Provera per spiegare il nuovo corso dei calendari Pirelli che già, negli ultimi anni, va detto, avevano segnato una discontinuità con il passato. Ricordiamo solo quello con le immagini di SteveMcCurry del 2013.