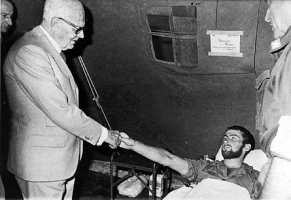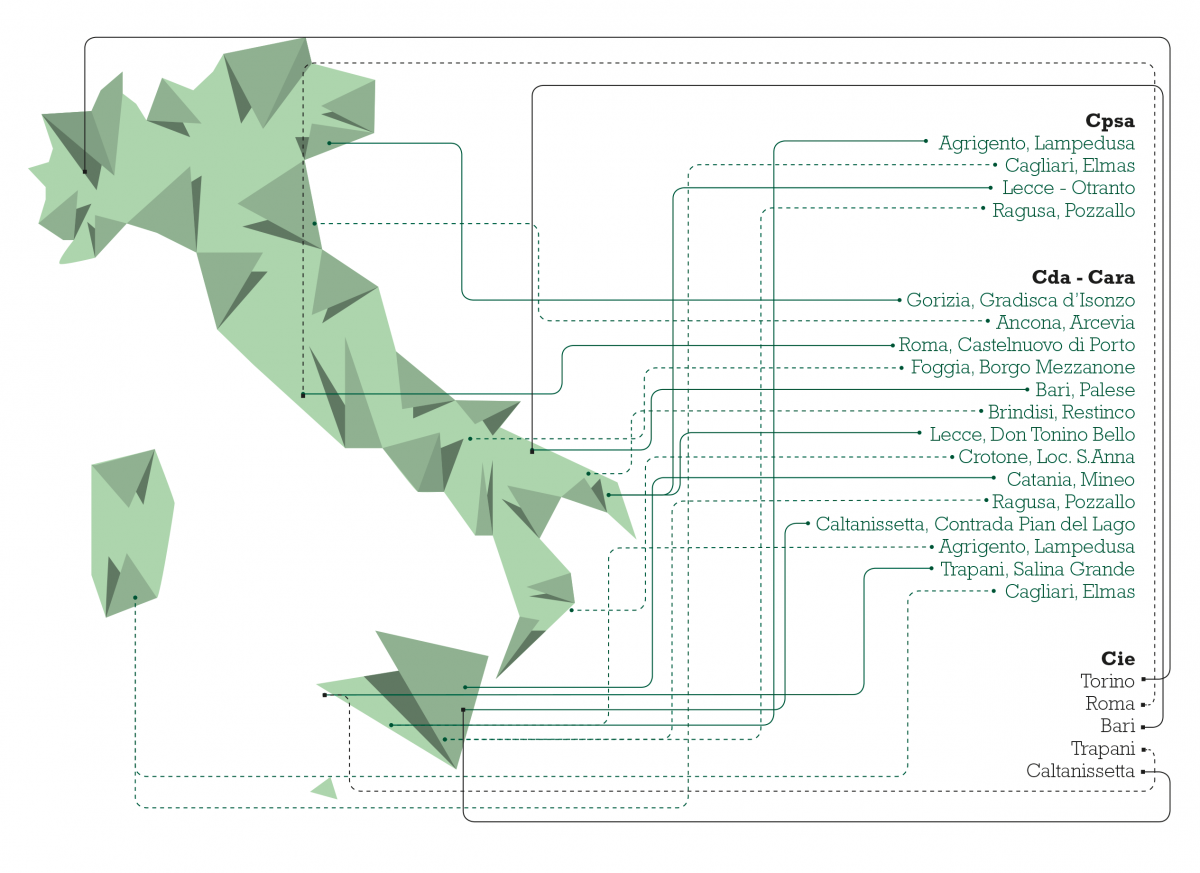In questi giorni la Casa Bianca lancia una campagna, un sito e dei servizi online per incoraggiare i residenti stranieri che hanno titolo per farlo a fare domanda di cittadinanza. Facendo questo, dice il presidente nel videomessaggio (qui sotto) ai ragazzi e ai loro genitori stranieri che sono nel Paese da decenni, acquisirete diritti e poteri, e potrete perseguire il sogno americano. «Siate cittadini» dice Obama agli 8,8 milioni di immigrati che hanno potenziale diritto alla nazionalità.
Ecco la conferma che il presidente nero è un musulmano, non nato negli Stati Uniti, deve aver pensato qualche seguace di Salvini (e Calderoli).
Negli stessi giorni in cui Obama registrava e faceva mettere online il suo messaggio, i candidati repubblicani alle primarie si sbracciavano per convincere gli elettori del loro partito che no, loro non faranno nessuna sanatoria per gli irregolari e che, anzi, risolveranno il problema dell’immigrazione rispedendo milioni di persone in Messico. Solo il senatore Marco Rubio e Jeb Bush, che hanno come forza quella di essere figure potenzialmente capaci di attirare voti moderati, parlano delle necessità di riformare la legge sull’immigrazione, ma, quando dibattono con i loro avversari schierati più a destra, li rincorrono. O almeno, nel dibattito Tv di mercoledì scorso è successo così.
Del resto, sia Donald Trump che Rand Paul hanno messo in discussione il diritto di suolo come titolo per acquisire la cittadinanza.
La risposta cinica è semplice: è un calcolo elettorale. Ogni ora negli Stati Uniti nascono più ispanici, asiatici e afroamericani che non bianchi e nei prossimi venti anni la demografia elettorale è destinata a cambiare in maniera drammatica. Non solo, i cittadini naturalizzati votano più degli appartenenti alle comunità che invece sono nati nel Paese. Dev’essere la voglia di esserci.
Le scelte di Obama e dei democratici in materia di immigrazione e diritti degli stranieri sono dunque un bieco calcolo politico: concedere diritti per assicurarsi una porzione di elettorato in crescita costante. Con gli afroamericani è andata così: dopo che Lyndon Johnson pose fine alla segregazione legale dei neri, questi scelsero i democratici. Da allora non li hanno più lasciati. Se pure fosse vero, sarebbe buon senso: i partiti politici parlano e devono parlare alla popolazione che esiste, non a quella che immaginano o desiderano.
 La nostra guida alle primarie repubblicane
La nostra guida alle primarie repubblicane
[divider] [/divider]
C’è anche un’altra spiegazione e riguarda il pragmatismo americano – e la storia di un Paese cresciuto grazie all’immigrazione. E anche la biografia personale di Obama.
Gli Usa, come anche l’Europa, sono un Paese che invecchia. Senza le minoranze e l’immigrazione presto ci si troverebbe con carenza di manodopera, mancato prelievo fiscale e un drammatico buco nel lavoro di cura e welfare – che è uno dei segmenti del mercato del lavoro in crescita, proprio a causa dell’invecchiamento della popolazione. Favorire ingressi regolari e stabilizzare famiglie ha come cascame quello di dare stabilità al tessuto demografico del Paese.
Avere più cittadini e meno immigrati significa anche rendere meno precaria la società, rafforzare il senso di appartenenza al Paese di milioni che ci abitano e si sentono ospiti.
Quanto al presidente, la sua visione è quella di un uomo di mondo in senso stretto. Obama è figlio di un kenyota, ha vissuto in Indonesia ed è cresciuto con dei nonni bianchi alle Hawaai, arcipelago pieno di asiatici. Una persona con una biografia simile sa bene che le identità contemporanee sono complicate – sulla sua ha scritto Dreams of my father, il libro che lo ha reso famoso – e che dare cittadinanza significa far sentire i non-cittadini che vivono, lavorano e moriranno negli Stati Uniti, parte di qualcosa. Non si tratta di essere di destra o di sinistra, ma pragmatici. Si tratta di saper guardare al futuro. Quello che non sanno fare i governanti europei, incapaci di dire qualcosa di sensato su un tema epocale che riguarda tutti. E che, come Jeb Bush e Marco Rubio, che rincorrono i loro avversari di destra, si fanno dettare l’agenda da Matteo Salvini, Viktor Orban e Marine Le Pen.
[social_link type=”twitter” url=”https://twitter.com/minomazz” target=”on” ][/social_link]@minomazz






 Quella guerra fece 20.000 vittime e distrusse un intero paese. Bombardamenti, bombe a grappolo e al fosforo, ridussero il Libano e la sua capitale ad un cumulo di macerie fumanti. Ed è nella periferia della capitale che l’esercito libanese ordinò lo sterminio finale. La guerra, iniziata nel giugno del 1982 su suolo libanese e condotta da Israele per combattere l’OLP, l’organizzazione per la liberazione della Palestina guidata da Yasser Arafat, stanziata ormai in Libano dal 1948, raggiunse il suo apice all’inizio del mese di settembre. Dopo l’attentato dinamitardo a Bashir Gemayel, da poco eletto Presidente del Libano, le forze israeliane, alleate del governo libanese, occuparono Beirut Ovest. Il generale dell’esercito israeliano Ariel Sharon decise di chiudere ermeticamente i campi profughi e di mettere cecchini sui tetti di ogni palazzo. Niente e nessuno poteva entrare nei campi. Ebbero quindi gioco facile le milizie cristiane libanesi, costituite dai falangisti: dinanzi a loro quasi solo donne, anziani e bambini.
Quella guerra fece 20.000 vittime e distrusse un intero paese. Bombardamenti, bombe a grappolo e al fosforo, ridussero il Libano e la sua capitale ad un cumulo di macerie fumanti. Ed è nella periferia della capitale che l’esercito libanese ordinò lo sterminio finale. La guerra, iniziata nel giugno del 1982 su suolo libanese e condotta da Israele per combattere l’OLP, l’organizzazione per la liberazione della Palestina guidata da Yasser Arafat, stanziata ormai in Libano dal 1948, raggiunse il suo apice all’inizio del mese di settembre. Dopo l’attentato dinamitardo a Bashir Gemayel, da poco eletto Presidente del Libano, le forze israeliane, alleate del governo libanese, occuparono Beirut Ovest. Il generale dell’esercito israeliano Ariel Sharon decise di chiudere ermeticamente i campi profughi e di mettere cecchini sui tetti di ogni palazzo. Niente e nessuno poteva entrare nei campi. Ebbero quindi gioco facile le milizie cristiane libanesi, costituite dai falangisti: dinanzi a loro quasi solo donne, anziani e bambini.