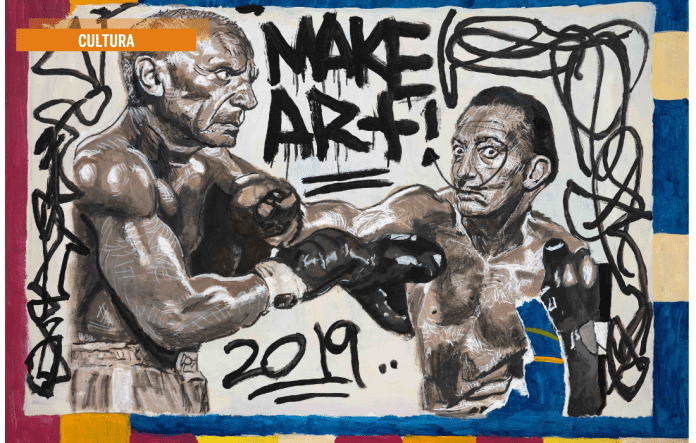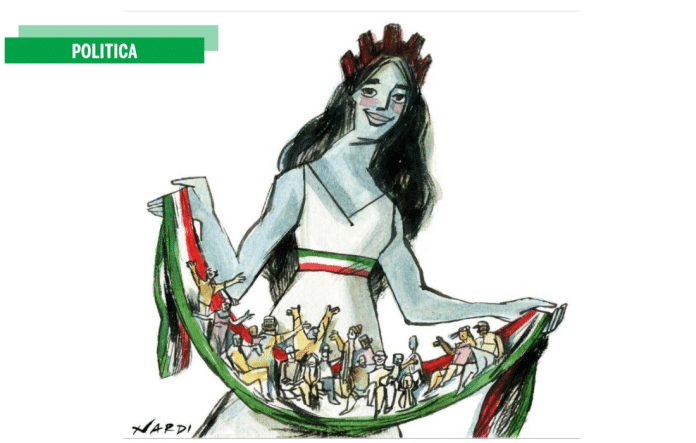Meloni a Pescara alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia ha ribadito: “E’ fondamentale accelerare verso una politica industriale comune nel settore della difesa, aumentare la collaborazione tra i nostri campioni nazionali in una logica di sovranita’ europea”. Ed era prevedibile.
Quel che mi preoccupa è il divario tra la capacità delle classi dominanti europee, in questi giorni, di delineare un sistema ed un’economia di guerra e l’afasia e irrilevanza delle forze democratiche; è un fatto inquietante e il segno di una sconfitta della politica. Non è sufficiente, infatti, esprimere da parte dei centrosinistra europei una vaga propensione pacifista. Occorre, mi pare, ripartire dai fondamentali, dalle strutture economiche che, attraverso le guerre, cominciano a delinearsi, così come dal clima che scuote e percorre i popoli, frastornati, spesso inerti.
Come rispondiamo al messaggio dominante nell’Unione Europea, nella Nato, nel governo italiano: “si vis pacem para bellum”, che sconvolge le Costituzioni postbelliche e lo spirito originario delle Nazioni Unite? La prima risposta è, a mio avviso, nelle continue ristrutturazioni e rivoluzioni del capitale. Il capitalismo, scriveva Marx, è, per sua natura, un sistema globale; “deve annidarsi ovunque, insediarsi ovunque , stabilire connessioni ovunque”. Come scrive Emiliano Brancaccio “la tendenza alla centralizzazione del capitale in sempre meno mani porta ad una analoga concentrazione del potere politico, talmente accentuata da entrare in contraddizione con le stesse istituzioni borghesi della democrazia liberale. “Spira un forte vento di destra fascista nel profondo perché politici come la Meloni possono presentarsi come alfieri del mercato, del suprematismo bianco neocoloniale e razzista e, insieme, una “sorta di canaglia anticonformista ed anti establishment, ben analizzata, di recente, dallo storico Quinn Slobodian nel libro Einaudi Il capitalismo della frammentazione, (qui la recensione di Left).
La soluzione è sempre quella di avere un movimento sociale dietro ad un programma politico di riforme. La dialettica è un bastardo che è molto difficile da aggirare”. L’identità europea si sta ridefinendo, confusamente e violentemente, in questa dialettica: la post democrazia di oggi riprende il tratto coloniale ancestrale, uno dei fondamenti delle vicende storiche europee, come risposta infame alla bancarotta della globalizzazione liberista. Il capitale, anche oggi, ha bisogno della guerra; e la guerra è “costituente” di un sistema complesso, che è strutturale, sociopolitico, geopolitico. La guerra militarizza la società, in tutti i suoi gangli, le sue reti, i suoi anfratti. E’ disciplina come pedagogia di massa. Abbatte la Costituzione. Basti pensare, in Italia, alla sconvolgente operazione congiunta di “autonomia differenziata” (secessione dei ricchi) più premierato, elezione diretta del “capo”, plebiscito, evanescenza del Parlamento, riduzione del Presidente della Repubblica a funzione notarile. La democrazia costituzionale tende verso la “democratura”, la “capocrazia“, come la chiama Ainis.
L’Unione Europea sta varando l’economia di guerra, già delineata nella relazione Draghi a livello internazionale (e, in Italia, dalla recentissima relazione di Panetta, governatore della Banca d’Italia). L’educazione, la formazione militari entrano nelle scuole, nelle Università, per inculcare principi nazionalisti, bellicisti. L’isteria dei poteri politici e militari assimila ogni critica al genocidio di Gaza all’antisemitismo, ogni critica alla Nato alla sovversione dell’ordine costituito. Vengono represse manifestazioni studentesche; vengono sospesi ed indagati insegnanti. Il ministro Valditara tenta di spegnere , con il maccartismo, il sapere libero, la criticità verso il potere costituito.
All’ex ministro greco Varoufakis, in Europa, è stato sottratto il diritto di parola. In Francia la presidente di un importante partito di opposizione di sinistra, Mathilde Panot, viene convocata dalla polizia a seguito della sua espressa posizione filopalestinese: un avvenimento inedito e particolarmente grave, di fronte al quale non si potrà essere inerti. Perché questa precipitazione? Perché la guerra è l’alibi; anzi, è l’occasione per il potere di educare all’ordine sociale, all’obbedienza gerarchica. L’obbedienza ridiventa la prima delle virtù. Troppi giornali, troppe riviste, troppi media hanno, insieme a Meloni, calzato l’elmetto.
La criticità scientifica, non massimalista, di Left è una luminosa eccezione. Posso avanzare, innanzitutto a me stesso, una domanda scomoda, da non sottovalutare: dove è finita la “intellettualità democratica”, tanto osannata dalle sinistre istituzionali? Occorre forse ancora comprendere quanto si sia elevato il livello dello scontro e, quindi, il pericolo della regressione. Il rapporto classico tra potere e masse lo illustra, con la lucida determinazione del militare , senza la ipocrisia dei politici, l’ammiraglio Bauer, altissima carica Nato:”Le situazioni stanno cambiando in fretta. Dobbiamo sapere che, per i problemi di sicurezza, per una difesa collettiva, gli apparati militari attuali non sono più sufficienti; vi è bisogno di più gente che sostenga gli eserciti. E’ l’intera società che deve sentirsi coinvolta in guerra, che le piaccia o no”. Siamo in guerra!