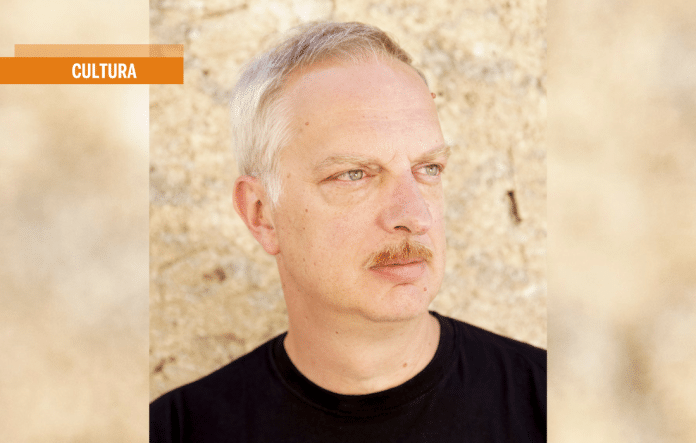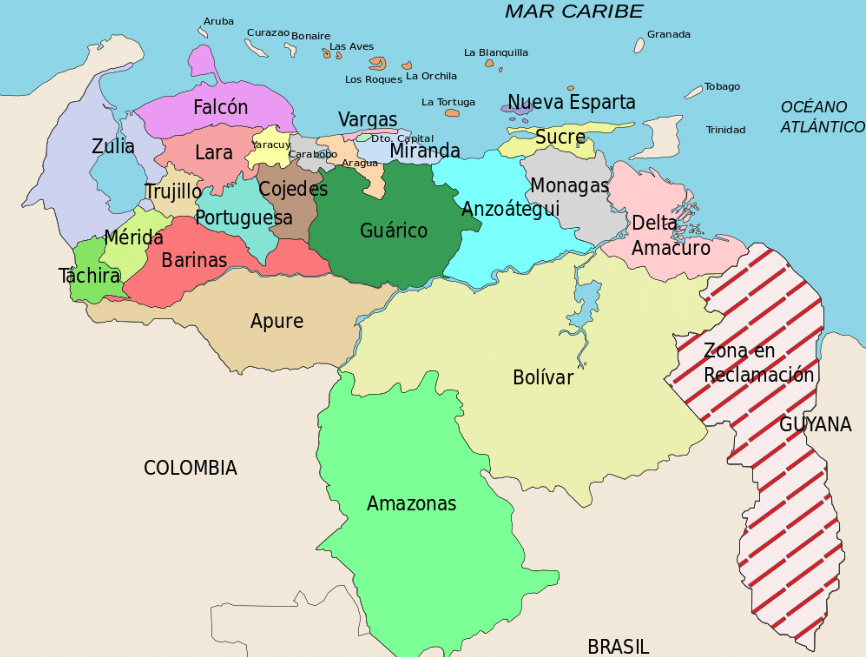Dalla stessa parte mi troverai, secondo romanzo di Valentina Mira edito da Sem, è nella dozzina dei finalisti del premio Strega. Ha portato fama alla giovane scrittrice, ma anche attacchi da parte di esponenti di destra e riviste vicine a Casa Pound, e ora perfino minacce di morte. È un libro politico, come Mario Sechi ha preteso che l’autrice ribadisse durante la trasmissione di La7 Otto e mezzo del 12 aprile
Ma la Divina Commedia non è forse un libro politico? Spero nessuno voglia discutere del valore artistico del poema il cui sesto canto di ogni cantica è esplicitamente politico, che tutti abbiamo studiato e di cui ricordiamo la definizione scolastica: «poema didascalico-allegorico, vuole insegnare le grandi verità morali e religiose attraverso l’utilizzo di immagini che hanno significato simbolico». Non a caso il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha individuato in Dante il fondatore del pensiero di destra in Italia (si legga in proposito l’articolo di Noemi Ghetti su Left online del 26 gennaio Dante era sì un conservatore ma finitela di scambiare la storia con le larve della storia). Poi anche Machiavelli e perfino Gramsci sono stati oggetto di tentativi di appropriazione allo scopo di costruire un’egemonia culturale della destra.
Dunque la disputa sulla legittimità della candidatura di un ‘libro politico’ come quello di Valentina Mira a un premio letterario resterebbe una questione di lana caprina – del resto se si aspira all’egemonia culturale si dovrebbe almeno ricordare lo zoon politikon di Aristotele! – se non fossimo nel momento storico in cui gli enti lirici, i teatri stabili, i musei, gli spazi pubblici di informazione, vengono presi d’assedio per impiantare nuova dirigenza fedele alla linea, e la Rai è trasformata con la ‘revisione’ della par condicio in un “megafono” della destra al governo, come giustamente denuncia il comunicato dell’UsigRai letto dai giornalisti al termine dei Tg della sera di tutte le reti il 12 aprile.
E ora sotto attacco sono anche i libri e i loro autori, gli intellettuali in genere – e tutti gli esseri umani lo sono, «non si può separare l’homo faber dall’homo sapiens», scriveva Gramsci. Lo storico e filologo Luciano Canfora, «pericoloso sovversivo» come lo definisce in un post di brillante ironia il professor Mario Lentano, la filosofa Donatella Di Cesare e il rettore Tomaso Montanari querelati rispettivamente da Giorgia Meloni e del ministro Lollobrigida, lo storico Davide Conti querelato dalla Rauti (qui il video della loro conferenza stampa congiunta all’Fnsi ndr).
E ancora: Antonio Scurati, autore della famosa trilogia su Mussolini, epurato dalla trasmissione Rai Che sarà: avrebbe dovuto leggere il suo monologo sulla Liberazione in vista del 25 aprile. La Rai smentisce che si tratti di censura, per dimostrarlo la presidente del Consiglio ha pubblicato in un post il testo integrale del monologo, (che intanto è diventato virale) con argomenti pretestuosi e insostenibili sul conto di Scurati. Serena Bortone in serata ha letto il monologo donatole da Scurati a Che Sarà (Rai3, 20 aprile). Scrive elegantemente Nicola Lagioia, vincitore un premio Strega con La ferocia ed ex direttore del Salone del libro di Torino, in un appello lanciato online, «quando il contesto si fa così meschino da suggerirti per quieto vivere di tacere, è proprio allora che bisogna parlare».
Riconoscenza e solidarietà a Valentina Mira, allora, giovane donna antifascista e femminista, minacciata di morte per avere scritto un libro su «una vittima di serie Z, Mario Scrocca, che fu accusato per il duplice omicidio di Acca Larentia del ’78, quasi dieci anni dopo, sulla base di una testimonianza de relato, molto traballante (…), e 36 ore dopo l’arresto viene trovato impiccato in una cella anti-impiccagione del carcere Regina Coeli»: cito Mira stessa, che in tv ha detto che il libro nasce dal suo incontro con Rossella Scarponi, vedova a soli 25 anni di Mario Scrocca, con il quale aveva avuto un figlio, Tiziano, 2 anni quando il padre morì, e dall’esigenza di restituire a questa famiglia se non giustizia, che ormai è troppo tardi, almeno interesse, “cura”. Ci informa Il Secolo d’Italia (11 aprile) che Federico Mollicone, presidente della commissione cultura della Camera dei deputati, dopo meticolosa disamina – ma sarà suo compito istituzionale, magari anche per ogni libro candidato a un premio letterario? -, definisce il romanzo di Valentina Mira «una sceneggiatura di qualche pessima fiction», e si continua a discutere se non sia invece faction, ovvero in termini meno dispregiativi narrazione faziosa, revisionismo storico.
Letto il libro, di tutto questo resta poco, i fatti storici che il romanzo – e sottolineo romanzo, perché durante la lettura svanisce ogni dubbio che lo sia – racconta onestamente come sono accaduti: la deposizione di fiori ad Acca Larentia da parte di Giorgia Meloni, nel 2008, tra le braccia tese e i cori inneggianti a Mussolini, la totale mancanza di prove non solo della colpevolezza ma anche del suicidio di Mario Scrocca. La ricostruzione è documentata e accurata. Le licenze letterarie sono altrettanto onestamente dichiarate, come quando nelle note per il lettore la scrittrice avverte che il racconto dell’arrivo inaspettato dopo tanti anni della copia inviata da un anonimo dei verbali degli interrogatori di Mario Scrocca in carcere, e quindi anche il contenuto di quei verbali, sono frutto di fantasia: non della sua, ma di quella di Rossella, che ha scritto un suo libro, Soli soli, come sono stati per anni Tiziano e lei. Mira lo scopre tardi, dopo aver già finito di scrivere, da Rossella, ma decide di lasciare quella scena così com’è perché il suo «resta un romanzo e non un saggio» e perché al lettore resti «un senso di ingiustizia addosso», che però non sia soverchiante, perché crede «nel potere dei libri e del rompere certi silenzi e dello spezzare certi tabù». Perché resti viva la speranza.
Dalla stessa parte mi troverai, come solo la vera letteratura sa fare, rompe il silenzio, e non solo su Mario Scrocca e intorno ai suoi cari, ma per tutti noi. Lo fa coraggiosamente, con la ricerca di una vita, della vita stessa della scrittrice, con uno stile sferzante, dalla paratassi serrata, come l’autrice stessa riconosce, e provocatorio, ma mai livoroso, come qualche detrattore ha insinuato. È un romanzo storico e al tempo stesso un’autobiografia, malgrado lo scarto temporale tra la sua giovane vita e la storia che racconta. Quella storia è anche sua, profondamente, perché è di ogni donna che voglia scoprire da dove viene la violenza degli uomini. A lezione di scrittura, racconta Valentina Mira, «ti dicono che non devi mai perdere di vista il perché stai scrivendo ciò che stai scrivendo». E lei lo sa, lungo tutto il libro: non è il senso di sorellanza che l’incontro con Rossella le ha fatto scoprire, nemmeno soltanto il senso di giustizia di fronte all’ingiustizia della storia di Mario. «Ha a che fare con qualcosa di più difficile da esprimere. In parte con una sorta di colpa da espiare: il fascismo dentro e intorno a me. Il mio ex, i miei piccoli e grandi compromessi per un briciolo d’amore (…) ché ero stanca e allora andava bene tutto, anche uno che dice “Viva il duce”», scrive nel capitolo Il cuore in queste pagine. E nel capitolo Liberazione, dal “suo” fascista, quello che ha capito – perché ri-conosceva bene la violenza, non certo per sensibilità – la sua storia, lo stupro subito da un altro fascista con la croce celtica al collo, e le ha detto «con la dolcezza fasulla che devono avere certi preti pedofili», «Io ti perdono», finalmente scrive le parole che non ha saputo dire: «Io non ti perdono e non ti perdonerò mai». Ecco perché scrive Mira. «Per provare a fornire anticorpi». Anticorpi contro la Negazione, titolo del capitolo in cui si scontra con il rovesciamento della verità del suo ex fascista che accusa lei, la vittima, di essere carnefice, come accade oggi pubblicamente nel nostro Paese: negazione privata, negazionismo di Stato.
Questo romanzo, la sua profonda onesta appassionata umanità, è davvero una buona dose di anticorpi contro l’annullamento della storia.