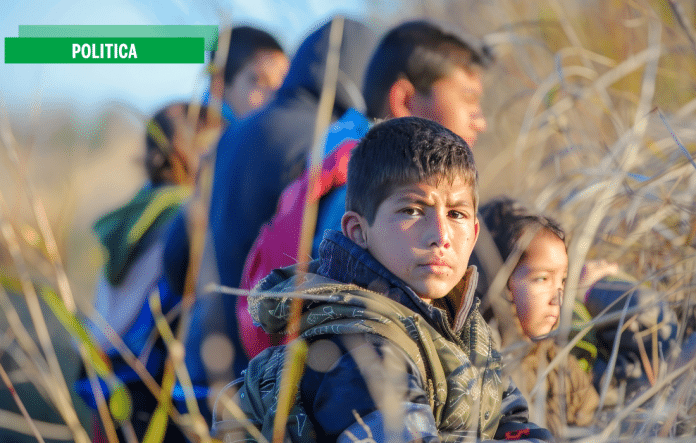La società digitale è diventata fabbrica e tutti noi siamo diventati la forza-lavoro – produttiva, consumativa, generativa di dati che i padroni delle piattaforme digitali organizzano, comandano e sorvegliano.Questo è il punto di vista del sociologo Lelio Demichelis che interviene alla Biennale Tecnologia a Torino (18-21 aprile) parlando del “totalitarismo della razionalità strumentale che per sua essenza è antisociale, ecocida e antidemocratico”. Ecco alcune sue riflessioni scritte per Left
La società è un’immensa fabbrica, ormai globale. E contro questa società trasformata in fabbrica – e dove ciascuno è mera forza lavoro – occorre praticare una critica radicale, andando così alla radice anche della crisi sociale e ambientale-climatica e la cui causa prima è quella razionalità strumentale/calcolante-industriale che è la premessa del capitalismo. Serve quindi una nuova Teoria critica da usare contro questa razionalità (come proviamo a fare ne La società-fabbrica. Digitalizzazione delle masse e human engineering, Luiss UP, 2023), sviluppandola dalla prima Scuola di Francoforte. Una razionalità che è diventata, a tre secoli dall’inizio della rivoluzione industriale, ma con antecedenti in Cartesio e Francesco Bacone, lo spirito del mondo e che è alla base oggi del totalitarismo tecnico e capitalista. Una razionalità totalmente “irrazionale”, ma che aveva catturato anche Marx e i marxismi con il loro mantra dello sviluppo delle forze produttive, Marx e Gramsci vedendo nella fabbrica il modello per la società socialista – senza però il capitalismo.
Una (ir)razionalità che è strumentale, perché finalizzata ad accrescere sempre di più il profitto privato; calcolante, perché tutto si basa sul calcolo e sulla ricerca dell’esattezza (oggi algoritmica), che però mai è sinonimo di giusto e di vero; e industriale, perché tutto è industrializzato e oggi lo è soprattutto la nostra vita intera come produttori, consumatori e generatori di dati. “To change the soul”- cioè cambiare l’animo della gente – è sempre stato l’obiettivo di ogni totalitarismo, e oggi di quello tecno-capitalista, per omologare/uniformare/standardizzare e soprattutto integrare i comportamenti umani e renderli calcolabili, prevedibili, pianificabili e quindi sfruttabili – e a questo servono appunto il management, il marketing e i social.
E da soggetti liberi e autonomi quali gli uomini potevano essere, almeno nelle premesse dell’Illuminismo, sono diventati oggetti, merci, nodi della rete. Passando dalla reificazione capitalistica dell’uomo, secondo Marx, alla datificazione tecnica di oggi e quindi rendendolo ancora meglio funzionale alle esigenze di accrescimento illimitato e irresponsabile del tecno-capitale: cioè produrre e consumare sempre di più, ma certo non per soddisfare i bisogni e l’esigenze dell’uomo e per la cura della Terra. E la società-fabbrica è allora la sublimazione totalitaria della razionalità strumentale/calcolante-industriale. E di totalitarismo della tecnica scriveva, nel 1964 il francofortese Herbert Marcuse: «L’apparato produttivo tende a diventare totalitario nella misura in cui determina non soltanto le occupazioni, le abilità e gli atteggiamenti socialmente richiesti, ma anche i bisogni e le aspirazioni individuali… La tecnica serve per istituire nuove forme di controllo sociale e di coesione sociale, più efficaci e più piacevoli», soprattutto grazie a comportamenti other directed (human engineering, appunto) che però devono sembrare inner directed (cioè liberi e autonomi), cancellando ogni opposizione e ogni pensiero critico. Senza dimenticare che il management (e la divisione e l’organizzazione industriale del lavoro) è incorporato negli stessi dispositivi tecnologici e oggi negli algoritmi.
E che la fabbrica tendesse da tempo a uscire dalla fabbrica, «La fabbrica si generalizza e va a pervadere e a permeare tutta la società civile» lo scriveva l’operaista Raniero Panzieri nei primi anni Sessanta; mentre il francofortese Horkheimer scriveva, già nel 1942 di «un regolamento della fabbrica ormai esteso all’intera società»; ed Harry Braverman aggiungeva poi, negli anni Settanta che «quasi tutta la popolazione è stata trasformata in dipendenti del capitale». E accanto e funzionale al management c’è il marketing, che è l’organizzazione scientifica/tayloristica della fabbrica del consumo; e ora anche i social/piattaforme – ancora la fabbrica dove deve crescere sempre di più la nostra produttività/pluslavoro di dati – con tutti noi sorvegliati più e peggio che in una vecchia fabbrica. Ovvero, stiamo realizzando in pieno il principio del positivismo ottocentesco di Saint-Simon e Comte per i quali società e industria sono sinonimi e quindi la società deve essere guidata da industriali, banchieri e tecnocrati, mentre il demos deve saggiamente rassegnarsi (Comte) senza cercare di opporsi, perché l’industria è la forma più alta di civiltà e di progresso…
Falso è quindi dire che siamo entrati nel post-fordismo/post-taylorismo, nella post-modernità e nella società post-industriale/immateriale, perché siamo semmai in una società iper-industriale e iper-positivistica e sempre tayloristica (oggi digitale). Noi tutti non vedendo (soprattutto i marxismi novecenteschi, ciechi come talpe davanti al potere della tecnica – e oggi anche del capitale ) che è la fabbrica (lo scriveva Simone Weil, nel 1934) – dominata dalla sua legge ferrea della divisione e totalizzazione del lavoro e dalla distinzione sempre e comunque tra chi organizza-comanda-sorveglia e chi deve solo e-seguire – e non la proprietà privata dei mezzi di produzione a generare oppressione sociale e perdita della libertà e sfruttamento dell’uomo e della Terra.
Quindi non siamo in una società individualista, ma in una società-fabbrica fatta di individui massimamente integrati/connessi/sussunti (è la digitalizzazione delle masse) nel sistema di potere tecno-capitalista come mai accaduto prima, neppure nei totalitarismi politici del ‘900. Cioè l’individualismo è solo una finzione, posto che quanto più si produce individualizzazione, atomizzazione, isolamento, tanto più e meglio si realizza l’integrazione/sussunzione totalitaria delle parti prima suddivise – soprattutto degli uomini. Impedendo – ancora la legge ferrea della fabbrica, ancora il divide et impera oggi tecnologico – di vedere il tecno-capitalismo nel suo insieme totalitario.
E così siamo anche incapaci di vedere che il mondo è oggi governato da imprese private che a loro discrezione decidono della nostra vita e di quella del mondo intero, così però generandosi (Gallino) un gigantesco deficit di democrazia e di libertà. Così come siamo incapaci di capire che le macchine di oggi non sono le macchine di ieri (singole), ma hanno tutte nella loro essenza la convergenza in mega-macchine (Anders) – il digitale, appunto – ma che questo coinvolge anche la nostra convergenza/sussunzione e soprattutto ibridazione in/con un sistema di macchine, negando quelli che erano invece i fondamenti dell’uomo, cioè pensare, valutare, giudicare, conoscere prima di decidere. Quindi, ci stiamo alienando ancor più da noi stessi, dalla libertà, dalla consapevolezza, dalla stessa ragione e dalla Terra. Delegando tutto alle macchine e al calcolo. E così costruendo quella società automatizzata e governata dalle macchine temuta dai francofortesi mezzo secolo fa, «dove il singolo può sì vivere senza preoccupazioni materiali, ma dove non conta più nulla e tutto si ridurrà al fatto di imparare come si usano i meccanismi automatici che assicurano il funzionamento della società» (Horkheimer).
Urgente diventa allora tornare a fare pensiero critico e a costruire una razionalità radicalmente diversa da quella oggi egemone, anti-sociale ed ecocida – ovvero: una ragione umanistica, ambientalista, responsabile.
 L’autore:
L’autore:
Lelio Demichelis insegna Sociologia economica al Dipartimento di economia dell’Università degli Studi dell’Insubria e alla Supsi di Lugano
Il festival: Dal 18 al 21 aprile si svolge la Biennale tecnologia a Torino a con quasi 150 incontri, 324 relatori da Italia e mondo su 22 sedi, oltre al Politecnico. Fra i protagonisti, oltre al professor Lelio Demichelis, ci saranno Pascal Chabot, filosofo e autore e autore per Treccani Libri del saggio di cronosofia Avere tempo. Il suo intervento si concentrerà su un’analisi di come la tecnologia ha cambiato radicalmente il nostro rapporto con il tempo. Attraverso una riflessione sull’era dell’ipertempo – il tempo degli schermi, e della frenesia delle attività quotidiane – Chabot si domanderà come sia possibile conciliare questa realtà con il bisogno naturale di riappropriarsi di un tempo più “umano”. Altra lectio da segnalare è quella di Bruce Sterling, scrittore, giornalista e docente alla European Graduate School, che parlerà delle “utopie fatte in casa“. Sterling proporrà alcune storie di artisti e collettivi impegnati a ricostruire continuamente le proprie case e i propri spazi lavorativi, come quella di Alexander Calder, artista e ingegnere creativo che investì molto del suo tempo a rinnovare il suo laboratorio e le sue due abitazioni in Europa e negli Usa. E ancora Filippo Santoni De Sio, docente in etica della tecnologia presso Delft University of Technology interviene in un panel che si concentra sulla politica dell’IA. Le intelligenze artificiali creano enormi possibilità di sorveglianza, oppressione e sfruttamento dei lavoratori e degli utilizzatori di Internet, nonché di influenzare i processi politici. La sfida, oggi, è quindi di promuovere sistemi di IA che rispondano ai principi di libertà umana, giustizia e democrazia. Inoltre Riccardo Giorgio Frega, divulgatore e attivista, con Luca Berto e Laura Nori interviene sul tema dei Bitcoin e su come matematica e tecnologia al servizio della democrazia, mentre Marco Deseriis, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi della Normale di Pisa parlerà di piattaforme digitali fra utopia e distopia: da Netflix a Instagram, da Amazon a Glovo, le piattaforme digitali costituiscono il luogo di molte delle nostre interazioni sociali, nonché della nostra formazione culturale e politica. Infine segnaliamo l’intervento di Luisa Corazza, docente di diritto del lavoro all’Università del Molise. L’incontro proporrà un focus sul lavoro nelle piattaforme digitali che ha lanciato nuove sfide all’azione sindacale. Quale è il ruolo dell’azione sindacale nel capitalismo delle piattaforme? Quali sono le possibili forme di una rappresentatività sindacale matura e consolidata? Questi sono solo alcuni degli interventi per noi più interessanti, ma il programma è sterminato, lo trovate qui: biennaletecnologia.it