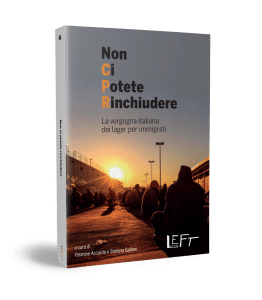Sembra quasi che il ministero dell’Interno abbia intrapreso una competizione con la procura della Repubblica di Bari, con cui la maggioranza di governo cerca di strumentalizzare e scavalcare l’efficace azione che la magistratura sta ponendo in essere con tempestività: una gara sul tempo contro chi riesce a spazzare via a suon di arresti i rischi di inquinamento del voto, affinché il voto democratico possa svolgersi.
Dinanzi a questa corsa del centrodestra, il maggior partito della coalizione di centrosinistra sta però mostrando debolezza, arroccandosi nella difesa strenua e ugualmente strumentale del pur importante operato degli ultimi vent’anni in Puglia e a Bari, ma che abbisogna di un salto in avanti e di coraggio. Perché per bonificare una terra come questa non bastano vent’anni e occorre dirselo, affrontarlo e andare molto più avanti, non difendere le manchevolezze. Il Pd ha temporeggiato per mesi nel tentativo di imporre un proprio candidato a sindaco, inizialmente sostenendo la candidatura di Marco Lacarra, attualmente parlamentare, in un gioco del 15 che avrebbe collocato alcune caselle tutte locali. I giornali locali ci hanno ricordato che l’eventuale elezione a sindaco di Lacarra avrebbe liberato in Parlamento il posto per la prima dei non eletti nelle file del Pd, Anita Maurodinoia, che nel frattempo ricopriva la carica di consigliera regionale e di assessora ai trasporti nella giunta regionale del presidente Emiliano, dopo un’ascesa dovuta anche- si ipotizza – a usi disinvolti della doppia preferenza. Non solo, se fosse scattato il seggio parlamentare per l’assessora, le sarebbe succeduto in consiglio regionale il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis.
Tutto perfetto. Solo che in questa astratta rappresentazione, tutta politicista e interna al Pd è mancato il contatto con la città e con la cittadinanza attiva, non quella delle liste civetta ma quella vera, fatta di persone che davvero pubblicamente discutono – litigano anche – su cosa è meglio per il proprio territorio.
Nell’amministrazione, invece, e nel Pd, è mancato il polso sulla stanchezza della città per pratiche note, acquisite da tradizioni politiche molto diverse da quelle familiari a sinistra, fatte invece di strada, studio, contatto con i bisogni. Soprattutto è mancato il polso sulla condizione di difficoltà nella quale la cittadinanza si trova, privata della mediazione dei corpi intermedi ed esclusa a causa di pratiche di relazione non politiche, bensì amicali, quando non clientelari, dopo gli anni della pandemia, la crisi energetica, la crescita dell’inflazione e il riaffermarsi dei settori informali dell’economia, dopo l’eliminazione del reddito di cittadinanza.
A Bari, ad esempio, come nel resto d’Italia, l’emergenza abitativa è diventata ormai vera e propria crisi. E su questa l’impatto della turistificazione, purtroppo non governata ed anzi promossa come risorsa per lo sviluppo, di cui tuttavia non si percepisce un ritorno in termini di giustizia e di redistribuzione di ricchezza, è uno degli elementi di immediata percezione insieme alla sensazione plastica che il governo del territorio stia sfuggendo alla pianificazione, nella mancanza del Pug. Ma è solo un esempio, nel quale bruciano però 3200 sfratti esecutivi.
Bari è anche in cima alle classifiche dell’Ispra per consumo di suolo. Poi, è vero, è più bella rispetto a vent’anni fa, almeno nei quartieri più centrali, ma questa bellezza è troppo poco distribuita. Siamo a Bari, in Puglia, un Sud dei Sud che voleva competere con Milano e che ha lavorato al proprio riscatto a partire dal 2004 e soprattutto dal 2005, con la prima inaspettata elezione di Nichi Vendola alla presidenza della Regione – la promessa della Primavera.
Ma qualcosa si è inceppato e, già dal secondo mandato di Nichi Vendola e poi dall’elezione di Michele Emiliano alla presidenza della Regione, la devastazione dei corpi intermedi ha sfilacciato le cinghie di trasmissione tra la società sana e la sua rappresentanza politica. Non diciamo niente di nuovo. Pagine e pagine sono state scritte su quanto è avvenuto negli ultimi trent’anni nel sistema di produzione della rappresentanza. La costruzione del consenso ha smarrito la strada della politica ed ha intrapreso quella più comoda dei gruppi di interesse, più o meno legali, ha sussunto i trasformismi.
Nel maggior partito di governo locale, il Pd, è inoltre mancata negli ultimi anni la percezione del lavoro messo in campo in città da molti gruppi ed individui, sempre più distanti da palazzi sordi alle critiche, anche quelle costruttive. E tra questi “non hanno visto arrivare” nemmeno Michele Laforgia (la citazione è sua, ed è sottilmente pungente), un possibile candidato civico ma chiaramente connotato e con una storia a sinistra, espressione di uno di questi gruppi, l’associazione La giusta causa, che era parso ai più il candidato naturale per il campo del centrosinistra. Un candidato con una posizione progressista, che non ha risparmiato le critiche e ha cercato di offrire uno slancio in avanti all’amministrazione uscente, e che è sostenuto da alcune associazioni politiche ben caratterizzate, oltre che da Sinistra italiana (ma non dai Verdi, che sono allineati con il candidato Pd) e persino dai 5 Stelle. E che avrebbe potuto essere sostenuto anche da altri soggetti, anche più a sinistra (Pci Up), che però sono stati frenati dalla rigida, e allo stato dell’arte ingiustificata, hybris dei dem con le loro molte anime.
La mancanza del polso della situazione ha, quindi, fatto sì che il Pd non rinunciasse alle sue pratiche. Ha preteso che tra Laforgia e il proprio candidato, finalmente individuato in gennaio, Vito Leccese, si svolgessero primarie, contrastando altresì ogni richiesta di porre regole certe. Primarie invise a molti perché falsamente rappresentate come festa della democrazia, specialmente nel contesto dato: consultazioni private che – a differenza dei primi esperimenti innovativi, cui naturalmente partecipavano i soli militanti – invece facilmente si prestano, come è accaduto negli anni recenti, a manipolazioni, proprio perché tutto sono meno che urne democratiche. Non ci sono regole, non è determinato il perimetro di chi può esprimersi, non fanno che minare la struttura di qualsiasi organizzazione democratica. Chi passa decide per chi invece resta.
Poi è arrivato uno tsunami, dai 130 arresti per presunta compravendita di voti dello scorso mese di febbraio, con il coinvolgimento di una società municipalizzata, agli arresti della mattina del 4 aprile 2024, tra i quali quelli quello del sindaco di un Comune limitrofo al capoluogo pugliese, Triggiano, di una coalizione opposta a quella che governa invece il capoluogo; ma anche quello del marito di Anita Maurodinoia, la quale ha rassegnato le sue dimissioni.
Ma il Pd ha reagito con un arrocco. Il tentativo di tenere insieme la coalizione del campo largo, spinto per Laforgia soprattutto da 5s e Sinistra Italiana, è quindi naufragato dinanzi alla realtà che la Procura ha dimostrato di tenere sotto controllo, senza necessità di interventi governativi. Laforgia, supportato da Conte, dal palco del comizio che lo stesso 4 aprile doveva essere la conclusione della sua campagna per le primarie, ha comunicato di fatto la sua indisponibilità a sottostare a una competizione senza regole nel contesto che il Pd non ha inteso arginare né riconoscere.
Ma la priorità è la città: si faccia un accordo, ha detto con responsabilità Laforgia, si mettano insieme su un’idea più progressiva di città le forze sane del centrosinistra tutto, intendendo con ciò l’arco dal Pd ai comunisti passando per i 5s, si mettano fuori le persone (i cosiddetti capibastone) e le pratiche che non garantiscono trasparenza e che inficiano i processi democratici – e non perché siano in grado di condizionarli, ma perché è loro concesso di farlo, per una distorta idea di pace sociale che può serenamente essere ribaltata, che va abbandonata. Auspicando che anche il centrodestra si proponga con una candidatura e un approccio costruttivi per la città, dismettendo la minaccia di scioglimento palesemente strumentale in un quadro giudiziario nel quale lo stesso centrodestra è coinvolto.
Ma Elly Schlein, a Bari quest’oggi (ndr 5 aprile), non ha inteso cogliere l’occasione che veniva offerta, di dare una scossa al suo partito su decisioni politiche per la città che avrebbero giovato al suo stesso partito e soprattutto all’idea di partito come luogo nel quale dirimere il conflitto politico per il bene collettivo. Ha invece avallato quanto già annunciato dal livello locale, di voler continuare a sostenere la candidatura espressa dal Pd, e di voler andare direttamente al voto con due candidati, in una logica da braccio di ferro calata nel clima delle tifoserie che rischia soltanto di far precipitare la città in decisioni strumentali del governo, privandola del diritto democratico di autodeterminarsi nel voto.
Si è persa un’occasione storica per mettere in piedi un nuovo laboratorio che potesse rappresentare un esperimento di innovazione politica per il Paese. A questo punto, e salvo cambiamenti dell’ultimo secondo, credo che il “centrosinistra-senza-Pd”, libero di selezionare il proprio personale politico su base ideale e programmatica, non debba avere paura di affrontare la contesa elettorale con lo slancio di una opportunità nuova, per la città e per la sinistra. Ci vediamo alle urne, dunque. Quelle vere. E vedremo le liste.
foto di Nicholas Chieco – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118285778