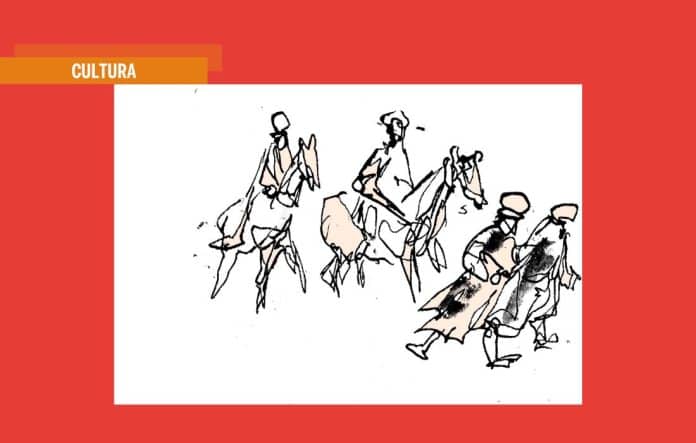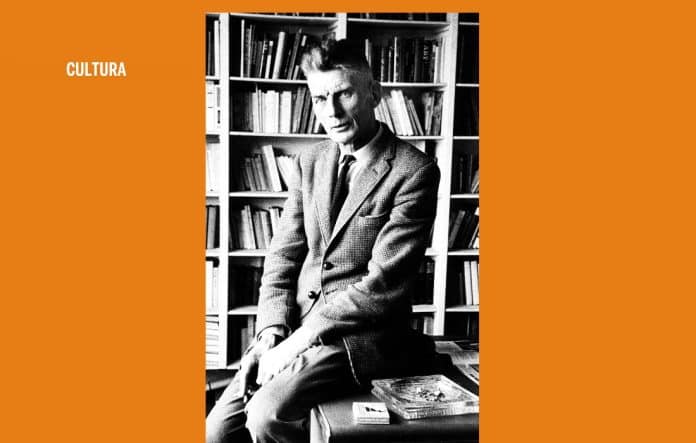Abbiamo studiato la storia e sappiamo che il fascismo è stato un movimento politico nato in Italia all’inizio del Novecento che è riuscito a diventare maggioritario e a prendere il governo del Paese per più di vent’ anni.
In quegli oltre 20 anni sono accadute tante cose tragiche, prima tra tutte l’entrata in guerra dell’Italia accanto alla Germania nazista. E siamo abituati a pensare al fascismo come quella “politica” che non si fa scrupolo di usare la violenza fisica verso l’avversario, agita in termini di pestaggi, distruzione di luoghi, intimidazioni, violenza verbale e censura, fino all’estremo dell’omicidio dell’avversario. Sappiamo che il fascismo è stata l’invenzione di Mussolini, già militante socialista e direttore dell’Avanti! Un inizio in politica in un partito che aveva nell’idea di socialità degli esseri umani il suo fondamento. Dobbiamo pensare che Mussolini avesse in qualche modo aderito a questi pensieri? Ad un’idea di solidarietà e di uguaglianza e di un’idea di politica che lavorasse per il riscatto, per la liberazione delle classi lavoratrici, di tutti coloro che pensavano di non essere liberi, di trovarsi in una condizione di impossibilità di realizzare una vita degna di essere vissuta, di impossibilità di realizzare la propria realtà umana. Il socialismo nasce e si sviluppa con un intento umanista. Con l’intento di riscattare, liberare chi libero non è, con un pensiero di uguaglianza più estesa, universale, tra gli esseri umani, non limitata ai più ricchi o ai nobili, che fa sì che la politica debba lavorare per raggiungere l’uguaglianza nella misura in cui essa non c’è.
Cosa ha portato Mussolini a pensare ad un “socialismo” violento, che non fosse più per la liberazione umana? Forse un’idea positivista e meccanicistica dell’essere umano? Forse un’idea di un essere umano che non ha un’autonomia, non può avere realmente un’identità se non è parte di una massa? Certamente c’era un’idea di identità che si realizzava nell’appartenere alla “classe”. Il proletario, il borghese, il nobile. Un’identità che era per l’appartenenza ad un gruppo, cioè una non-identità personale.
Fatto sta che il fascismo si configura come movimento politico che fa dell’umano solo corporeità, fa dell’attività politica solo l’azione violenta. In questo fatto, certo e noto, per cui il “fascista” è colui che esalta l’uso del manganello e lo scontro violento come “dialettica”, credo vada evidenziata una realtà nascosta.
Perché potremmo pensare che il fascista agisce la violenza fisica perché vuole che l’altro sia come sé stesso, un essere umano che ha rinunciato al pensiero e alla parola, alla dialettica e al rapporto con l’altro, per essere solo azione distruttiva.
Tutti coloro che vogliono avere un pensiero diverso dall’assenza di pensiero che dice che la violenza è l’unica politica possibile devono essere fermati o eliminati, messi in condizione di non nuocere.
Lo slogan è «credere, obbedire, combattere». Credere, ovvero non pensare, fare quello che viene ordinato e agire violenza sugli altri.
L’altro slogan è «me ne frego», ovvero non esiste per me, non ha alcuna importanza. La fatuità e l’anaffettività fatta sistema politico.
Io credo che questo aspetto sia troppo spesso trascurato. Dobbiamo denunciare il fascismo ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa che in qualche modo vuole spingerci a rinunciare a pensare, quando ci troviamo di fronte a quanto ci vuole confondere le idee, quando ci troviamo a confrontarci con chi ci vuole impedire di fare ricerca, di comprendere quanto ci circonda.
Potremmo dire che il fascismo è tutto ciò che ci vuole impedire, in ogni modo, di pensare. Ma a questo punto bisogna vedere bene e cercare di capire quale pensiero il fascismo vuole eliminare. Perché se si guarda alla storia e anche alle realtà politiche più recenti che si ispirano al fascismo, dobbiamo notare che non tutte le attività di pensiero vengono condannate. Il fascismo non ha alcun problema con tutto ciò che serve alla sopravvivenza. Anzi ne favorisce lo sviluppo perché è funzionale alla sopravvivenza della società. Il fascismo non ha alcun problema con il pensiero razionale che serve all’utile e all’aggressione.
Quello che il fascismo vuole eliminare è un pensiero di ribellione, di rifiuto del noto e costituito, di rifiuto dell’autorità stupida e violenta, del rifiuto della violenza come metodo politico.
Del rifiuto della proibizione di pensare, del rifiuto di farsi confondere.
Il nostro tempo è pieno di contraddizioni. Le possibilità materiali che abbiamo sono enormi rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto. Malgrado ciò è come se si fosse smarrito qualcosa, sembra che ci sia nuovamente confusione su ciò che è stato il fascismo, sembra che improvvisamente non sia più ovvio che gli esseri umani sono tutti uguali a prescindere dal luogo di nascita. Improvvisamente c’è una differenza, esseri umani che sono più umani degli altri ed altri che non sono veramente esseri umani e quindi possono e devono essere eliminati.
I fascisti moderni, per lo meno quelli che sono immersi nelle moderne democrazie, non sono più così banali e approssimativi da ricorrere alla violenza fisica per imporre agli altri il loro non-pensiero.
Forse perché hanno scoperto di essere molto più efficaci nel diffondere il loro non-pensiero spargendo confusione, mettendo il veleno nei pensieri altrui, spacciando sinistra per destra e destra per sinistra, facendoci assistere alle tragedie quotidiane delle morti in mare per non aver soccorso chi chiedeva aiuto, volendo farci pensare che siamo tutti naturalmente violenti, volendo farci pensare che dobbiamo tutti fregarcene, facendo morire la voglia di vivere dei ragazzi, deludendo la loro infinita sete di conoscenza e di vita.
I fascisti non lo sanno quello che fanno e perché lo fanno, perché non sanno pensare. Sono ciechi, non capiscono nulla di realtà umana, ed è per questo che sono violenti. Sanno solo della realtà materiale, sanno solo accumulare quello che li circonda, vedono solo il potere della realtà materiale con il suo fascino luccicante. E quindi pensano che la realizzazione massima cui un essere umano può aspirare sia diventare una marionetta, attaccato ai fili del credere ed obbedire, pronto a combattere per un ideale di umanità disumana, pronto a uccidere per eliminare ciò che non è come loro.
Il vero pericolo dei fascismi moderni è questa sottigliezza, questo essere violenti senza agire la violenza fisica. Perché la violenza fisica si vede e si sente chiaramente. La violenza psichica invece è sottile, invisibile e può fare danni profondi nella nostra realtà più intima, in ciò che più profondamente siamo.
Noi continueremo a ribellarci. Sempre. Continueremo a cercare le risposte che vogliamo tenendo bene aperti i nostri occhi.