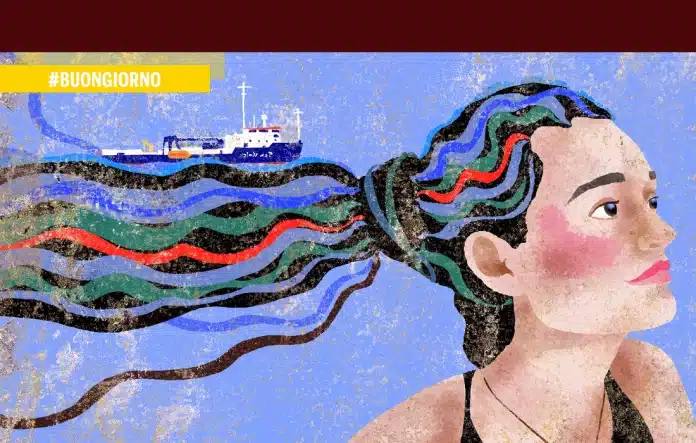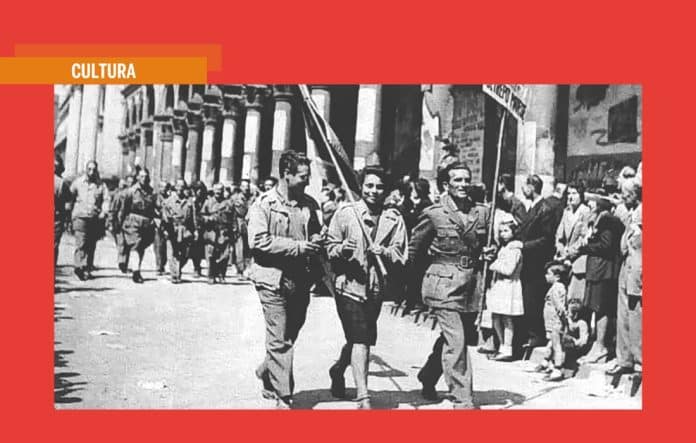La Dichiarazione universale dei diritti umani ha 75 anni e non li porta bene. Varata a Parigi dalle Nazioni unite grazie al determinante impulso di Eleanor Roosevelt nel clima di speranza che seguiva gli orrori della seconda guerra mondiale, quel nobile documento ha incontrato in fase attuativa molte difficoltà alcune delle quali sembrano ancora oggi insormontabili: quanto avviene in Ucraina, in Iran e da ultimo a Gaza non è che la sanguinosa emergenza di una negazione dei diritti della persona che ha radici profonde quanto diffuse.
Lo certifica autorevolmente anche l’ultima rilevazione di Amnesty International: il Rapporto 2022-2023 sulla situazione dei diritti umani nel mondo ci dice che in 156 Stati, sui 200 che si spartiscono il mondo, il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona è ancora un miraggio.
Cosa si può fare al di là della denuncia, della testimonianza, dell’esecrazione? Proponiamo l’inserimento della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni unite nella costituzione italiana e negli statuti dei partiti politici. Una proposta semplice, forse utopistica ma in qualche misura “eversiva” in un clima generale che anche in Italia vede progressivamente sbiadire le ragioni ideali, le radici valoriali e l’impegno civile che erano stati bandiera e cemento, nel secondo dopoguerra, della Carta costituzionale, degli statuti e dei programmi dei partiti democratici e della “buona politica”.
Potrà un’iniezione di Human Rights restituire la Politica alla politica? Ne abbiamo discusso il 14 dicembre, dalle 11, nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli, con Vittorio Pavoncello, Felice Besostri, Furio Colombo, Valentina Fabbri, Giorgio Fabretti, Angela Scalzo Giada Fazzalari, Roberto Morassut e Francesco Verducci.
Propongo qui ai lettori di Left qualche riflessione per approfondire e agire insieme a partire da quanto ho scritto sul numero della rivista tempo presente che presentiamo in questa occasione:
Ciò che parrebbe ovvio in nome della civiltà e di valori universalmente asseriti − ovvero proclamati, il che non vuol dire riconosciuti e tantomeno attuati − assume, oggi e in Italia, il sapore di una provocazione, e ciò per almeno due motivi. Il primo è costituito dalla naturale refrattarietà a una più stringente regolazione del sistema dei principi e dei valori che regolano la vita civile del Paese e che indirettamente incidono anche sul sistema della rappresentanza, che peraltro da tempo versa in una crisi ormai quasi preagonica; il secondo è che forse una simile proposta assumo un sapore idealistico se non addirittura velleitario: un “bella proposta” come tutte le iniziative che tentano di colmare il vallo che, sempre più profondo, si va scavando tra istituzioni e cittadini, tra sistema e paese reale, tra rappresentanti e rappresentati.
Sul tema dell’inserimento della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Umanità varata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 nella Costituzione della Repubblica italiana non ci si dilunga, in queste rapide riflessioni, se non per segnalare che in un passato non troppo remoto tentativi più o meno nobili di modificare la Carta costituzionale con l’introduzione di norme e principi in grado di modificare l’esistente sono state accolte con tepore, o addirittura clamorosamente bocciate alla prova referendaria prevista dall’articolo 138. Sul punto si possono tuttavia segnalare due interessanti e relativamente recenti esperienze che hanno fatto registrare un esito positivo: dapprima l’ingresso in Costituzione della tutela dell’ambiente e degli animali (con la modifica dell’art. 9); poi l’ancor più di recente riconoscimento del diritto di accesso allo sport, con la modifica dell’art. 33. È peraltro assodato che siamo un popolo di sedicenti sportivi e perciò stesso è risultato più facile contemplare l’attività sportiva tra i diritti facenti capo alla persona umana che non ragionare seriamente sul livello di attuazione dell’art. 3 della Costituzione, essendo più facile parlare del benessere psicofisico che non del riconoscimento assoluto della dignità della persona. Il concetto di fitness risulta più concreto e familiare che non quello di umanità.
E tuttavia, a 75 anni dalla sua entrata in vigore, la Costituzione repubblicana è tuttora un cantiere aperto e possiamo ancora confidare che, nel costante e irrefrenabile divenire dei principi e delle istituzioni, la lettera e i valori degli Human Rights possano un giorno trovare una degna collocazione della nostra Carta.
Ma se la Carta costituzionale resta ancora, nonostante tutto, «il maggior collante di cui il nostro Paese può disporre per il suo futuro» (Cheli) il terreno sul quale si muovono quei particolari istituti che sono i partiti politici è, notoriamente, più sfuggente, quando non impervio o limaccioso. E non è un caso che a periodi ricorrenti il dibattito intorno all’articolo 49 della Costituzione riprenda vigore: è accaduto nella seconda metà dello scorso secolo, quando ancora la Repubblica dei partiti viveva la sua stagione più florida e la forma-partito tradizionale incarnata dai grandi partiti di massa sembrava inattaccabile dall’acido della storia; accade ora, in una stagione nella quale gli istituti della rappresentanza sono da tempo in crisi e la liquidità sociale ha ampiamente corroso tutti i corpi intermedi.
Non è questa la sede per ragionare esaustivamente dei motivi che hanno indotto i Padri costituenti a una formulazione così sfuggente di un istituto, il partito politico, che pure già allora costituiva il presupposto e il cemento della giovane democrazia repubblicana. Basterà qui ricordare che sul punto si sono confrontati giuristi e politici di straordinario spessore: da Lelio Basso a Costantino Mortati, da Umberto Merlin a Pietro Mancini, da Aldo Moro a Palmiro Togliatti. Il risultato di quella complessa e faticosa mediazione è stato la formulazione, tra le più vaghe adottate dai Costituenti, che oggi ben conosciamo: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». E merita qui ricordare che non poche voci, anche autorevoli, chiesero all’epoca di non costituzionalizzare la questione.
Ma se pure è innegabile che tutta la Costituzione italiana è frutto di un compromesso − compromesso evidentemente “alto”, nato dalla convergenza delle grandi tradizioni democratiche socialista-comunista, cattolica e liberale che riannodarono i propri rapporti politici ed istituzionali nella prima stagione post-fascista (Amato) − è anche vero che questo testo è assai lontano da quello che in sottocommissione fu in un primo tempo formulato da Merlin e Mancini, che così recitava: «I partiti hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e che rispettino la dignità umana, secondo i principi di libertà ed uguaglianza. Le norme per tale organizzazione saranno dettate con legge parlamentare». Se l’Assemblea avesse approvato tale formulazione, probabilmente l’innesto dei diritti umani nell’atto costitutivo delle formazioni politiche sarebbe già avvenuto. Ma la storia non è esercizio ipotetico.
Ci troviamo così, da 75 anni, a confrontarci con un partito politico che ha le connotazioni tipiche delle associazioni di persone con comunanze di idee e ideologie: un conglomerato di valori e di strutture organizzative che, legato dal cemento di un simbolo e di un apparato, opera per determinare l’indirizzo politico del Paese come strumento di collegamento tra i cittadini e lo Stato ovvero, al pari dei sindacati, come una di quelle strutture che l’articolo 2 della Costituzione identifica come «formazione sociali». Il presupposto che ha mosso i Costituenti − lasciare libertà di azione ai partiti politici al fine evidente di evitare che fossero assoggettati al controllo da parte dello Stato o di chi potesse in qualche misura minarne la libertà di azione – ha comportato che la loro disciplina, come nel caso dei sindacati, fosse quella degli “enti di fatto”, per cui il partito è disciplinato dal codice civile, laddove fa riferimento alle “associazioni ricreative e culturali”. E sul carattere “ricreativo” dei (o di alcuni) partiti si potrebbero fare considerazioni che qui omettiamo.
Né ci addentriamo nella considerazione di quanto tali “libere associazioni” trovino, a livello costituzionale, un limite nel riferimento al «metodo democratico»; non è questo, in verità, l’unico limite, giacché la disposizione dell’articolo 49 si combina con quelle degli articoli 18 e 98: il primo è quello che proibisce le associazioni segrete; il secondo, al comma 3, prevede limitazione al diritto di iscrizione ai partiti politici per alcune categorie di cittadini che svolgano attività istituzionali di particolare responsabilità. E anche su quest’ultimo punto, non c’è bisogno di sottolinearlo, la discussione rimane vivace, alimentata com’è ancora oggi da discussi eventi di cronaca e da discutibili fenomeni di sliding doors.
Al netto di tutto ciò, il partito politico moderno è − o almeno sino a poco tempo fa era − assolutamente coessenziale agli ordinamenti democratici di massa come con diversi accenti è stato teorizzato, da fine Ottocento ad oggi e solo per citare pochi nomi, da Mill, Schmitt, Ostrogorski, Michels, Duverger e Sartori. Nel secondo dopoguerra tutte le grandi democrazie europee si sono ricostruite sul sistema dei partiti, e tale processo di State building è stato particolarmente significativo laddove l’esperienza pregressa era stata di natura totalitaria: in particolare in Italia, dunque, dove in modo particolarmente evidente l’ordinamento si è trasformato dallo “Stato partito” allo “Stato dei partiti”.
Eppure, dei partiti − della loro struttura interna, delle loro modalità operative, delle loro strutture organizzative, dei meccanismi di rappresentanza e di cooptazione, della coerenza dei loro comportamenti con le ideologie di riferimento − si è parlato assai poco al di fuori dei dibattiti tra costituzionalisti e tra politologi. Il tema del partito ha conosciuto una certa popolarità e riscaldato gli animi solo in occasione dei due referendum del 1978 è del 1993 sul finanziamento pubblico. Gli anni tra il 1992 ed il ‘93, poi, hanno registrato una crisi di sistema tanto radicale e irreversibile da travolgere la forma-partito e le strutture consolidate dei grandi partiti di massa. Senza dimenticare che già nel 1989 la caduta del muro di Berlino aveva trascinato con sé, tra i calcinacci della Storia, ideologie e certezze, bandiere e apparati.
Da allora in poi movimentismi, leaderismi, populismi, sovranismi hanno contribuito alla nascita e all’affermazione di nuova realtà che gestiscono il consenso (e il potere) quasi rifuggendo dal termine partito. Archviato il «fattore K», dimenticati i partiti di massa, disciolti i “partitini”, tutto ormai scorre assai veloce: veloci i successi, rapidi ormai pure i declini e in generale fuggente anche il consumo di politica. Nascono così nuove formazioni politiche che germinano e aggregano sulla base di slogan di immediata presa, di un linguaggio diretto e semplificato: i nuovi protagonisti della politica hanno sostituito le ideologie con le parole d’ordine, il consenso con i like, le speranze con le paure.
Quando il partito sopravvive − e non è sostituito da influencer, da staff, da consultant, dai “cerchi magici” − stenta a darsi uno statuto ideale, oltre che formale. Quel tanto di «metodo democratico» che residua dal richiamato dall’articolo 49 ha abbandonato da tempo le bandiere, i valori le “visioni” e si avvita ormai inesorabilmente sulle procedure interne, sugli aspetti tecnico-decisionali attinenti alla elettività degli organi dirigenti, sui metodi deliberativi che definiscono l’interazione tra iscritti e quadri, sui meccanismi di delega che afferiscono alla gestione, sull’organizzazione degli organi di garanzia e di giustizia interni, sull’equilibrio generale degli organi collegiali, sulle anagrafi degli iscritti, sulle garanzie delle minoranze e anche, non da ultimo, sui processi di formazione delle candidature.
La democrazia dei partiti stenta a diventare democrazia dentro i partiti. I loro statuti sono sempre più autoreferenziali e prescrittivi, ordinati da una rigorosa burocrazia interna che trasforma organizzazioni che dovevano essere fucine di consenso e laboratori di strategia politica in grandi apparati burocratici che crescono in complessità e perdono in consenso. Svuotati di dibattito e di strategia, i partiti descritti dai lori statuti sono oggi prevalentemente strumenti di regolazione di un potere interno che ambisce a proiettarsi verso l’esterno, organi di bilanciamento tra correnti e gruppi di pressione, di distribuzione delle scarse risorse rivenienti dalla legge, di assegnazione di incarichi. Il malessere, peraltro, non è solamente italiano: il calo di consenso nei confronti delle formazioni tradizionali è diffuso in buona parte dell’Occidente e va di pari passo con il costante declino dell’affluenza alle urne. La stessa Unione europea non sfugge a questa logica: il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, poneva (art. 17, co. 7) il tema della rdefinizione dei “partiti europei” e del loro ruolo nella rappresentanza sovranazionale, ma è difficile sostenere che il Parlamento europeo sia da allora divenuto quella agorà sovranazionale, quella palestra di partecipazione, quel luogo di esercizio della sovranità transfrontaliera dei cittadini europei che era nell’intenzione dei fondatori dell’Europa unita.
Un esempio può risultare significativo della deriva intrapresa. Dopo un ampio e controverso dibattito interno, l’assemblea nazionale del Partito Democratico ha di recente varato − il 21 gennaio 2023 − il nuovo Statuto, modellato sulle più attuali e più politically correct linee di tendenza in materiale associazione politica. Rappresenta, quel testo, certamente un punto di riferimento importante: un’efficace guida alla gestione di un partito moderno, uno schema rigoroso e preciso dell’organizzazione interna di un partito che ha radici ideali grandi e profonde (oltre che “diverse”) e una mai rinnegata vocazione di governo. Si compone, quello statuto, di 55 articoli ciascuno dei quali è suddiviso in commi e sotto commi; il testo è a sua volta ripartito in più «Capi» il primo dei quali, quello che come si diceva un tempo «dà la linea», porta il titolo Principi e soggetti della democrazia interna.
L’articolo 1, comma 2 due così recita: «Il Partito Democratico è un partito antifascista che ispira la sua azione al pieno sviluppo dell’Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana». Segue, al comma 4, un fugace accenno alla natura federale dell’organizzazione e gli agli articoli 2, 49 e 51 [accesso alle cariche elettive] della Costituzione; al comma 6 si legge, infine, che il PD «promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli».
Punto. Quanto a politica, abbiamo finito. Tutto il resto riguarda; cariche e candidature; organi centrali e periferici; «composizione, modalità di elezione e funzione degli organismi dirigenti nazionali»; struttura organizzativa e articolazione sul territorio; «principi generali per le candidature e gli incarichi»; strumenti di partecipazione e formazione politica via web (!); conferenze e commissioni nazionali; principi della gestione finanziaria; procedure degli organi di garanzia e, infine, le ineludibili «norme transitorie e finali».
Non c’è, francamente, di che far vibrare i cuori; né, leggendo lo statuto, si avverte il calore, o anche soltanto il tepore del Sol dell’avvenire. Si opporrà − e anche a ragione − che uno statuto non è un manifesto politico e che fissare con puntualità e diligenza le regole di funzionamento di un organismo politico è comunque garanzia di un corretto esercizio della democrazia interna. Tutto vero, ma la lettura ricorda terribilmente quella di un regolamento di condominio. E, in fondo, tale è.
Resta il fatto che su 55 articoli e quasi 50 pagine di testo appena 5 righe − tre commi − riguardano la dimensione valoriale, programmatica e ideale del partito; quella, per intendersi, che un tempo si chiamava ideologia. Quella, vale ricordarlo, che un tempo generava consenso (o dissenso), che cementava la militanza, alimentava il sentimento di appartenenza e definiva il profilo identitario di una forza politica.
E tuttavia, nonostante ciò, i partiti − pur nella loro fragilità e nella persistente ambiguità del profilo istituzionale e sostanziale, sempre a metà strada tra associazione e istituzione − restano attori necessari, non aggirabili delle politiche e del balance costituzionale, anche se strutturalmente sempre soggetti a una questione di legittimazione (Bonini). Una legittimazione che non può venire soltanto dal carisma del capo, ma dev’essere (ri)costruita sul piano dei contenuti e dei valori.
Potrà un’iniezione di Human Rights restituire la Politica alla politica?
L’autore: Alberto Aghemo è presidente della Fondazione Matteotti
Foto in apertura: Di FDR Presidential Library & Museum – https://www.flickr.com/photos/fdrlibrary/27758131387/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82568079