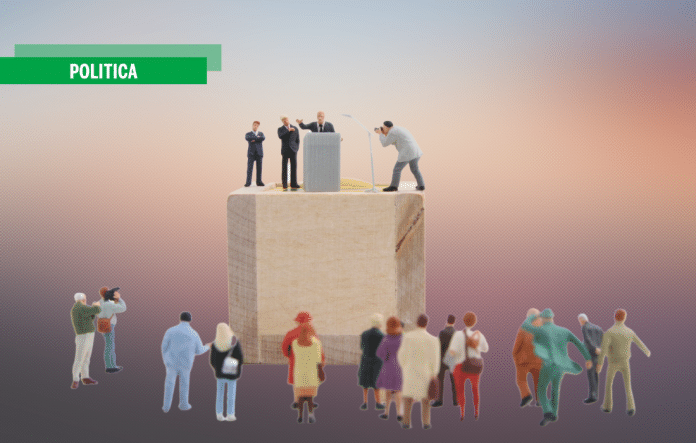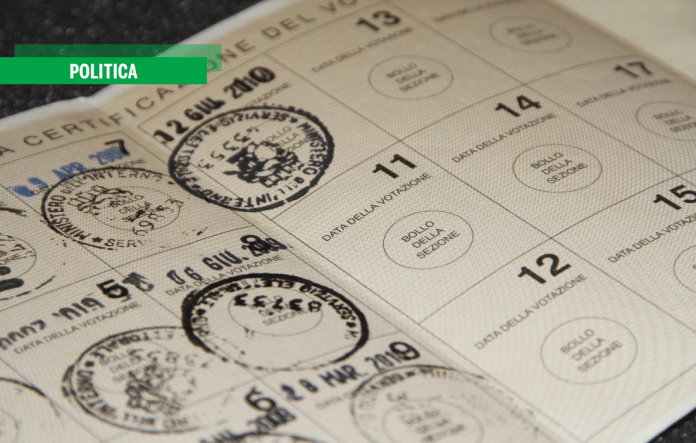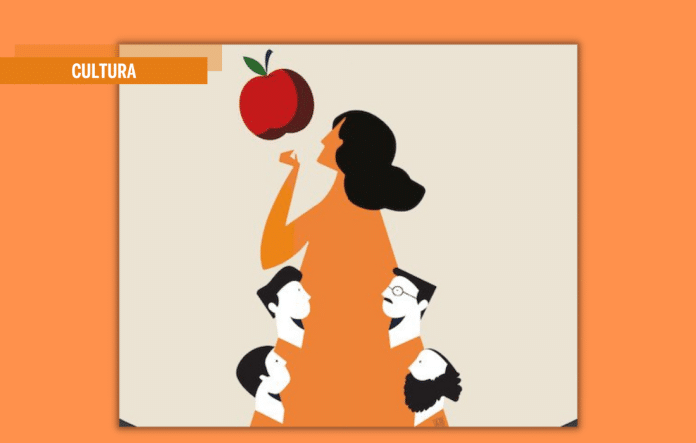Giordano Bruno chiama ognuno a costruire libertà e giustizia. Liberi di pensare! Liberi di scegliere! Nella responsabilità delle nostre individuali autodeterminazioni. È scomodo per gli imbecilli e i tiranni. È maestro di libertà e laicità per chi non vuole essere eterno minore, perché – scrive il nostro filosofo – «nel corpo han la catena che le stringe […] ne la mente il letargo che uccide».
Bruno sapeva bene che «il servilismo è corruzione contraria alla libertà e dignità umane». Sapeva bene che senza autonomia di pensiero, di ricerca non c’è futuro non c’è speranza né per gli individui, né per gli Stati. E per questo chiama ognuno a spezzare le catene della soggezione mentale etica politica economica e sociale.
Ed è in questa prospettiva che accoglie con entusiasmo la rivoluzione copernicana, che amplifica e sviluppa nel suo rivoluzionario infinito.
Di questo infinito divenire fa parte ogni essere umano, che produce infinite possibilità di autonoma ricerca intellettuale ed etica. Che può e deve agire per costruire responsabilmente libertà e giustizia.
Nell’infinito di Bruno l’umana ragione è liberata dalla grotta dei moduli ripetitivi e stantii. Bruno insegna ad alzare la testa contro potenti e tiranni che proprio col confessionalismo e nel confessionalismo tengono sottomesse le menti.
Ecco perché è scomodo. Ecco perché è stato mandato al rogo.
Ai padroni dell’anima ha tolto il supporto ideologico, perché l’anima è mente funzione corporale, fisica cerebrale. Ha svelato i meccanismi antropologici di soggezione che proprio su supposte idee di anima si creano abituando a cercare padri-padroni-padreteni a cui affidarsi.
Bruno si proclama «risvegliatore di dormienti». E la sua lezione è ancora una sveglia nel nostro tempo dove mordacchie e lavaggi del cervello continuano per imporre un mondo di schiavi. Soprattutto se donne.
Forse, vale appena ricordare che Giordano Bruno, in un contesto dove certo la misoginia non mancava e si mandavano al rogo centinaia di povere donne con l’accusa di stregoneria (e alla stregoneria credevano insospettabili intellettuali) scriveva nel De la causa principio et uno: «Mirate chi sono i maschi, chi sono le femine. Qua scorgete per suggetto il corpo, ch’è vostro amico, maschio, là l’anima che è vostra nemica, femina. Qua il maschio caos, là la femina disposizione (rigore); qua il sonno, là la vigilia; qua il letargo, là la memoria; qua l’odio, là l’amicizia; qua il timore, là la sicurtà; qua il rigore, là la gentilezza; qua il scandalo, là la pace; qua il furore, là la quiete; qua l’errore, là la verità; qua il difetto, là la perfezione; qua l’inferno, là la felicità […] E finalmente tutti vizii, mancamenti e delitti son maschi; e tutte le virtudi, eccellenze e bontadi son femine».
Libertà e giustizia
Ecco allora che Bruno è vivo – forte – potente davanti a noi perché ha denunciato l’arroganza e l’ingiustizia di un mondo dove la libertà non può essere la tracotanza di chi nega emancipazione e autodeterminazione altrui. Non c’è libertà senza pari dignità. Non c’è libertà senza parità di diritti e doveri. E Bruno ci chiama al coraggio dell’azione per la costruzione di un mondo di liberi e pari.
Ognuno ha intelletto e mani, afferma Giordano Bruno, ma è la mano, l’operosità, l’agire che ci rende intelligenti.
Christian René de Duve, premio Nobel per la medicina (1974) ha scritto: «L’Homo sapiens, quello che possiede conoscenza, deriva dall’Homo habilis, colui che sapeva usare le mani». Un bel riconoscimento per il nostro Giordano Bruno, che a proposito di evoluzionismo secoli prima di Darwin scriveva nella Cabala del cavallo Pegaseo che senza la mano «l’uomo in luogo di camminare serperebbe, in luogo d’edificarsi palaggio si caverebbe un pertuggio, e non gli converrebbe la stanza, ma la buca».
In questa buca di un mondo di schiavi, oggi non manca chi ci vorrebbe riportare…
Sono i cattolicisti di casa nostra -che comunque devono fare i conti con la laicità e la democrazia che abbiamo faticosamente conquistato-; sono i cultori della Jihād che vogliono imporre il califfato mondiale, e per questo hanno elevato l’assassinio e la schiavitù a mezzo e fine.
Contro tutto questo la filosofia di Giordano Bruno si erge potente e forte baluardo di laicità e libertà.
Venerdì 17 febbraio 2023, ore 17, Roma, Campo de’ Fiori
Nel nome di Giordano Bruno. Laicità Diritti Dignità Uguaglianza – Per una democrazia applicata, è il titolo che l’Associazione nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno” ha voluto dare all’evento di quest’anno.
Relazioni di Maria Mantello – Giordano Bruno – Per l’emancipazione individuale e sociale – Maria Chiara Acciarini Essere cittadine/i oltre i confessionalismi; Ivan Cavicchi – Scienza Salute bene comune. Recitativi bruniani a cura di Annachiara Mantovani. Esibizione del Coro del Laboratorio di musica popolare del Circolo Gianni Bosio diretto da Sara Modigliani.
Nella foto: la statua di Giordano Bruno a Campo dei fiori a Roma, opera di Ettore Ferrari, 1889