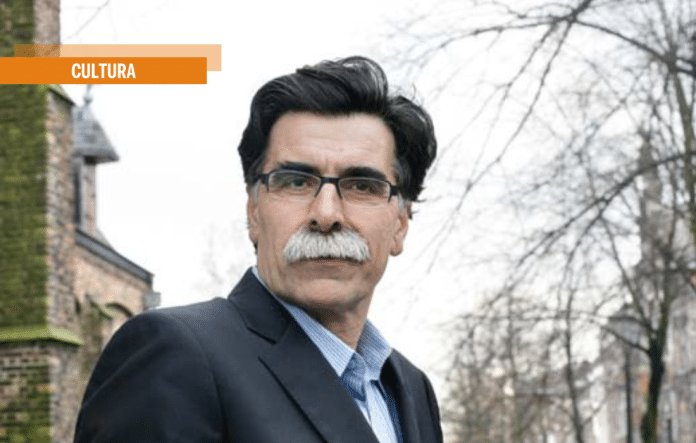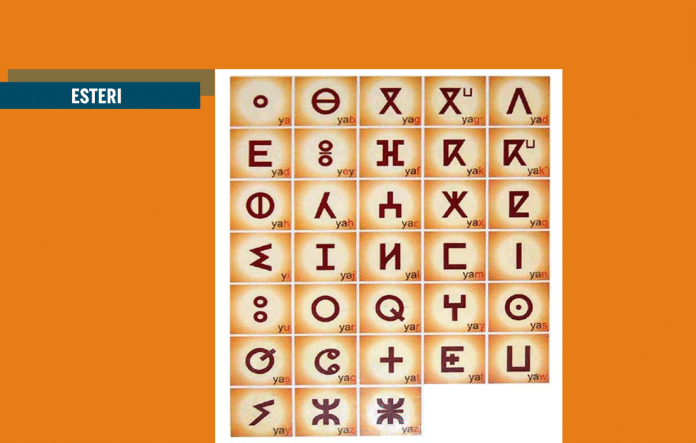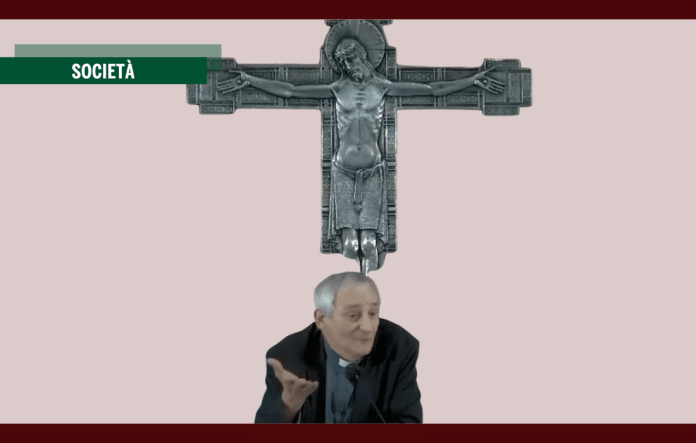Chiara Volpato perché questa nuova edizione di Psicosociologia del maschilismo (Laterza), dopo la prima pubblicazione nel 2013?
Avevo finito di scrivere il libro nel 2012, esattamente dieci anni fa; nel frattempo è uscita nuova letteratura scientifica sull’argomento. In più, mi sembrava importante che il libro avesse una nuova vita perché in questo momento c’è una riflessione vivace su questi temi, che sta cambiando le cose. Ho aggiunto un capitolo intero sulle forme estreme del dominio. Nell’edizione precedente si parlava di oggettivazione e di violenza, ma la letteratura è cresciuta, la riflessione ugualmente, quindi ho pensato di dedicare più spazio a questi temi.
Lei apre il libro con un capitolo sulla “questione maschile” ricordando che gli studi sugli uomini inizialmente erano pochi rispetto alle ricerche sulle donne. La cito: «Essendo considerato prototipo dell’umano il genere maschile, allora le ricerche sono state più sui gruppi discriminati ma non sui maschi».
C’è stato un cambiamento a partire dagli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso, che ha portato a riflessioni di cui si sono occupati studiosi uomini e donne.
Questo pensiero del maschile come “prototipo dell’umano” con cui tutte le altre categorie si devono confrontare, è una specificità della cultura occidentale?
Non sono un’antropologa, ma so che ci sono state delle culture nelle quali non c’era questa caratterizzazione. Però sono veramente minoritarie. Penso che, nella grandissima maggioranza delle culture umane, la definizione del maschile come prototipo dell’umano esista e sia potente.
Ci sono delle ipotesi sul perché?
Dagli studi emerge l’ipotesi che nella Preistoria, nelle culture di cacciatori e raccoglitori, non ci fosse subalternità femminile. Pare che i ruoli fossero distribuiti non tanto per genere quanto per età. Si ipotizza che i giovani partecipassero in maniera più o meno paritaria a procacciare il cibo, mentre le generazioni più anziane si dedicavano al lavoro di cura. La differenziazione che penalizza il femminile inizia probabilmente con lo sviluppo dell’agricoltura, quindi con il Neolitico. Lì viene introdotta la proprietà privata, vengono create le classi sociali, appaiono i ricchi e i poveri. E si crea anche la differenziazione tra maschile e femminile. La forza fisica maschile probabilmente ha fatto sì che gli uomini si occupassero della gestione militare e politica e le donne venissero relegate al lavoro di cura.
Lei descrive magnificamente l’iter del concetto di “vero uomo” nella cultura occidentale.
Ritengo che i ruoli sociali e quindi anche i ruoli di genere siano delle costruzioni storiche, cambino quindi a seconda delle epoche. Dall’Ottocento in poi, assistiamo a vari mutamenti, a momenti di ripensamento, di “crisi del maschile”, ma secondo un andamento non lineare. Nel corso del Novecento – soprattutto in concomitanza con le Guerre mondiali – si sono verificati anche dei momenti di recupero della visione maschile tradizionale. Poi, i movimenti degli anni Sessanta, soprattutto quello femminista, hanno cominciato a creare delle incrinature. Penso che ci troviamo tuttora all’interno di questa prospettiva, anche se, negli ultimi anni, assistiamo a preoccupanti recuperi del modello maschile tradizionale. Ci sono movimenti di contrattacco e ritorsione nei confronti della nuova autonomia femminile e figure politiche che li hanno incarnati, come Donald Trump negli Stati Uniti e Bolsonaro in Brasile.
Prima di Donald Trump c’era Barak Obama, che per certi versi proponeva un’altra immagine di uomo, sempre legato al potere ma con un atteggiamento più empatico, almeno a livello personale. Personaggi come Trump sono la reazione a quest’altro tipo di mascolinità?
Penso che Trump incarni una reazione sia ai nuovi modelli del maschile, sia a tutta una serie di cambiamenti sociali in atto. Interpreta una parte della società che, a mio avviso, guarda indietro invece che avanti.
Apprendiamo dal suo libro che in psicologia sociale si adopera costantemente il concetto dei Big Two, due caratteristiche che notiamo subito negli altri, distinguendo cioè tra il fattore della communality, attribuito alle donne, e la agency che sarebbe un po’ il compito e il nucleo dell’identità maschile.
Questa però non rispecchia la realtà oggettiva delle cose. È l’interpretazione stereotipica: il nucleo di credenze stereotipiche fa sì che alla donna vengano attribuiti i tratti collegati con la capacità di entrare in empatia con gli altri, di relazione, di calore. E all’uomo, invece, i tratti legati all’agency, al muoversi nel mondo, alla forza, alla conquista, al potere. Le cose oggi stanno cambiando, perché l’immagine femminile non è più quella tradizionale. È un’immagine più variegata, più complessa, caratterizzata anche da una serie di ambivalenze. Questa nuova immagine femminile suscita i contrattacchi e le ritorsioni della “mascolinità risentita”.
Nel libro ci sono pagine molto efficaci sulla difficoltà degli uomini di corrispondere allo stereotipo del “vero uomo”. La loro socializzazione in questa direzione appare quasi più difficile della socializzazione femminile e passa, così lei scrive, attraverso i legami tra uomini, il male bonding.
Questi legami profondi tra uomini sono molto importanti nella socializzazione maschile. Credo che contribuiscano anche a un certo maschilismo, perché l’uomo deve diventare tale di fronte agli altri uomini. Non può perdere la faccia, non può comportarsi “da femminuccia”. Pensiamo, per esempio, a tutto il discorso militare, come è stato e come è tuttora, perché le guerre esistono ancora ed esiste tuttora una certa mentalità militare da macho. Il “vero uomo” non deve avere tratti femminili e deve reprimere tutto ciò che può far interpretare il suo comportamento come incline all’omosessualità. La costruzione dello stereotipo tiene sempre presente l’allontanamento da questi due aspetti: dal femminile e da tutto ciò che non è eterosessuale.
Allora, una donna è tale perché viene considerata “femminile”, desiderabile e valida dagli uomini. Mentre gli uomini non devono essere confermati nella loro identità dalle donne, ma dagli altri uomini?
Certo, nella visione tradizionale sono gli uomini a decidere cosa è valido sia per se stessi sia per le donne. Si tratta di una costruzione per opposizione, per divaricazione tra i tratti tipici femminili e i tratti tipici maschili.
Lei riporta una serie di studi secondo cui la supremazia maschile non è indolore nemmeno per i diretti interessati.
La supremazia maschile comporta un prezzo molto alto che per tanto tempo è stato sottovalutato. Se si costruisce il militare come paradigma del “vero uomo”, non si può lasciare spazio all’emotività, alla tenerezza, alla confidenza. Le amicizie maschili sono soprattutto amicizie del fare, mentre quelle femminili sono amicizie basate sulla confidenza, caratterizzate dal disvelamento. Gli uomini pagano il non potersi aprire all’altro in termini di salute psicologica e fisica. Vi sono molte malattie, o difficoltà a far fronte alla malattia, che colpiscono più gli uomini che le donne. Su questi piani gli uomini hanno meno risorse. La costruzione di un’identità forte, tutta d’un pezzo, corrazzata li rende più deboli di fronte ad alcune difficoltà esistenziali.
Descrivendo invece gli stereotipi di genere relativi alle donne, lei annota che non esiste soltanto il noto stereotipo del disprezzo, basato su una presunta inferiorità femminile, ma anche altri stereotipi.
Esiste una specie di tassonomia degli stereotipi che ne prevede quattro tipi tra cui quelli di ammirazione e di disprezzo. Il disprezzo nei confronti delle donne era molto presente nell’antichità, ma lo troviamo anche oggi. Lo stereotipo di ammirazione nei loro confronti è invece molto raro, perché di solito il pregiudizio di ammirazione si prova nei confronti dei gruppi sociali favoriti, e le donne, per definizione, non lo sono. Però, verso le donne si trova il cosiddetto women wonderful effect, che le definisce meravigliose. Si tratta di una maniera di lodare il loro essere stupende nelle relazioni e nella cura – con l’obiettivo però di mantenerle al posto loro assegnato. Quindi, anche questo non può essere interpretato come uno stereotipo di ammirazione.
Un filo rosso che attraversa tutti i suoi libri è l’indagine sui motivi che fanno sì che le categorie oppresse siano d’accordo con la loro discriminazione. Che si considerino, in qualche modo, giustamente non considerate alla pari.
C’è spesso un’accettazione del ruolo subalterno perché può essere comodo. È difficile essere sempre allerta, in uno stato di ribellione. Allora si accetta il sessismo benevolo, quell’atteggiamento che dice “sei una persona meravigliosa, che però ha bisogno della protezione maschile”. C’è l’accettazione della complementarietà dei ruoli, sia nelle relazioni private che nel lavoro in cui spesso le donne accettano di stare un passo indietro. Anche per motivi oggettivi, perché hanno bisogno di spazio per l’affettività, il lavoro di cura, la maternità. A volte c’è lucidità nell’attuare questa collusione; a volte invece le donne la attuano in modo inconsapevole, magari prendendone coscienza solo anni dopo. L’ho visto succedere ad alcune studentesse. Gli anni dell’università sono anni importanti per le scelte che richiedono, che sono spesso scelte di vita sul piano affettivo e su quello del lavoro. Spesso però non c’è molta consapevolezza o lucidità nel fare tali scelte.
Lei menziona anche limitazioni imposte dall’esterno, invisibili ma efficaci.
Ci sono degli indici oggettivi che ci dicono, sulla base dei numeri, che in effetti esiste il “soffitto di vetro” e il fenomeno della “conduttura che perde”. Le ragazze spesso sono le più brave all’università, ma poi incontrano difficoltà specifiche e rischiano di perdersi per strada. Qualche anno dopo la laurea, i posti migliori o più remunerati vanno ai loro compagni. Il mondo del lavoro è tuttora un mondo difficile per le donne.
Mi ha colpito quando lei parla della paura del successo da parte delle donne, di questa sensazione per cui si pensa “non devo emergere troppo, non sta bene”.
Ho trovato interessante uno studio secondo cui che le donne che hanno più successo del partner tendono a nasconderlo o a farsi perdonare cercando di essere iperfemminili nella gestione della casa e delle relazioni.
Tuttavia, ci sono stati cambiamenti enormi, come forse mai prima nella storia. Essi riguardano sia le donne che gli uomini?
Le ricerche hanno constatato che lo stereotipo femminile si è molto diversificato negli ultimi trent’anni. Non ha perso i tratti tipici femminili, ma ha acquisito anche tratti maschili, diventando più complesso. Questo è successo molto meno con lo stereotipo maschile. Teniamo però presente che stiamo parlando di stereotipi! Nella realtà, anche il maschile sta cambiando. Un’esperienza personale: ad agosto ho fatto un viaggio nella parte orientale della Turchia. Anche lì ho visto uomini che portano in giro i bambini in carrozzina. Ho notato cioè una certa vicinanza al figlio o alla figlia, che non penso tradizionalmente fosse così esibita e accettata socialmente. E anche lì si vedono molte donne che lavorano, che hanno cambiato il loro ruolo nella società.
Lei sottolinea più volte nel libro che arrivare a un superamento degli stereotipi di genere non favorisce solo le donne, ma è anche nell’interesse maschile.
Sì, perché va a beneficio di entrambi. Se queste visioni e questi ruoli cambiassero, non ne beneficerebbero solo uomini e donne, ma la società tutta, come provato da molte ricerche anche di tipo economico: le società in cui le donne hanno una partecipazione attiva alla vita economica e politica del Paese sono società che stanno meglio delle altre, decisamente meglio delle società in cui la partecipazione femminile è ridotta.
Un anno fa è finita l’era Merkel, in Italia abbiamo la prima presidente del Consiglio: sto parlando delle donne al potere. Anche lei pensa, come molti, che una volta al potere una donna si comporta esattamente come gli uomini?
Penso che sia difficile generalizzare. Alcune donne – l’emblema è Margaret Thatcher – sono andate al potere con delle strategie tipicamente maschili e con una visione tradizionale della società. In altri Paesi invece le donne arrivate al potere hanno cercato di portare una visione un po’ diversa basata sulla loro esperienza storica, che implica una maggior attenzione alla cura, alle relazioni, all’ambiente. Se ci pensiamo, anche l’attenzione all’ambiente ha a che fare con le relazioni di cura. È una cura per ciò che ci sta intorno… Però le donne al potere con questa visione sono poche, le troviamo soprattutto in alcune situazioni particolarmente favorevoli come nei Paesi del Nord Europa, Paesi ricchi e con una popolazione poco numerosa. Penso che le donne, per poter portare un cambiamento in politica, non devono essere sole. Possono innescare un cambiamento quando sono almeno in un piccolo gruppo, che permette di darsi forza e sostegno reciproco.
Storicamente parlando, quindi, piuttosto che la singola Thatcher o Merkel, è più significativo che nei Parlamenti – in alcuni Paesi – sono presenti sempre più donne?
Quando le donne sono un certo numero possono indirizzare la politica del Paese verso certi temi rispetto ad altri. L’attuale però non è un buon momento da questo punto di vista, perché con l’aggressione russa all’Ucraina, si è tornati a una visione più militarista della società.
Se in Russia e in Ucraina ci fossero più donne nel governo, la guerra non sarebbe scoppiata o sarebbe già finita?
Probabilmente sì. La guerra mi dà l’impressione di un ritorno al Medioevo. Ha innescato una contrapposizione militare e maschilista, che speravo non avremmo rivisto.
L’Italia come si colloca rispetto al superamento degli stereotipi di genere?
L’Italia continua a coltivarne molti. Nelle ricerche sul sessismo non si colloca bene, siamo tra gli ultimi tra i Paesi europei sia dal punto di vista degli stereotipi, sia da quello dei posti di lavoro. L’Italia non fa una politica per le donne. Non aiuta né promuove la maternità, non aiuta né promuove il lavoro delle donne. Pensiamo, ad esempio, alla carenza di asili nido.
A concludere il suo libro sono delle pagine veramente belle che non vorrei anticipare perché ognuno deve leggerle da sé. Ripeto solo la domanda che lei si pone lì: “Che cosa si può fare per migliorare la situazione”?
Oltre alla lotta politica, quello che le singole persone possono fare è avere maggiore attenzione. Resto sempre colpita dal fatto che spesso passiamo vicino alle cose senza vederle. Spesso non mettiamo in discussione i rapporti di collusione di cui parlavamo prima, un certo sessismo quotidiano, non particolarmente aggressivo, ma molto radicato, perché non lo vediamo. Secondo me, il primo lavoro da fare è imparare a vedere e a prendere in mano le cose, una volta che le abbiamo viste. Non vuol dire combattere 24 ore al giorno, ma tenere presente che un certo modo di vivere non è scontato e impossibile da affrontare. Lo diventa se lasciamo che sia così. Questo è il primo lavoro: vedere ed essere critici. E poi bisogna fare un lavoro di rivalutazione. A me pare che la cura – il Covid dovrebbe avercelo insegnato – che noi esseri umani possiamo prenderci l’uno dell’altro sia una delle cose più importanti e preziose della vita. Però è sempre stata sottovalutata, proprio perché attribuita al femminile. Non diamo abbastanza importanza né alla cura delle relazioni, né alla cura della persona sofferente, né alla cura dell’ambiente, aspetti molto vicini tra di loro. La cura delle relazioni e dell’ambiente nel quale viviamo è un valore fondamentale, il primo a cui una società dovrebbe porre attenzione. Il fatto che non lo sia costituisce un motivo di allarme: rischiamo di precipitare in una situazione molto pericolosa.
L’autrice: Annelore Homberg, psichiatra e psicoterapeuta, è presidente del Network Europeo per la Psichiatria Psicodinamica – Netforpp Europa