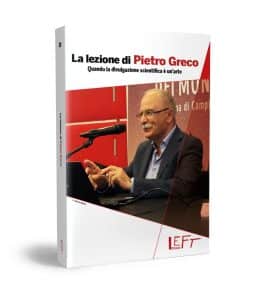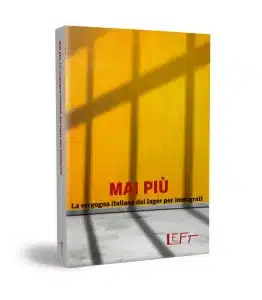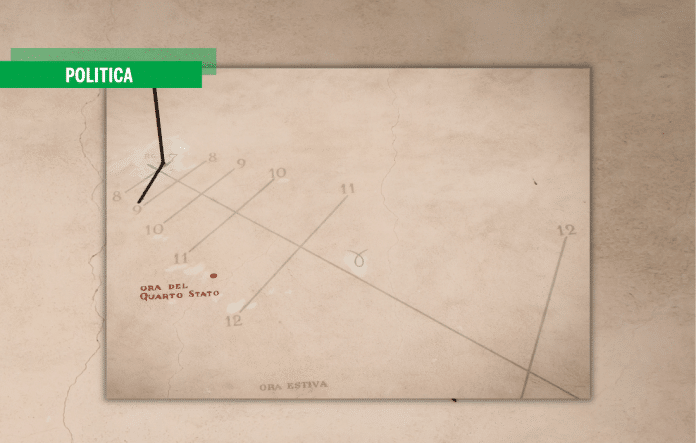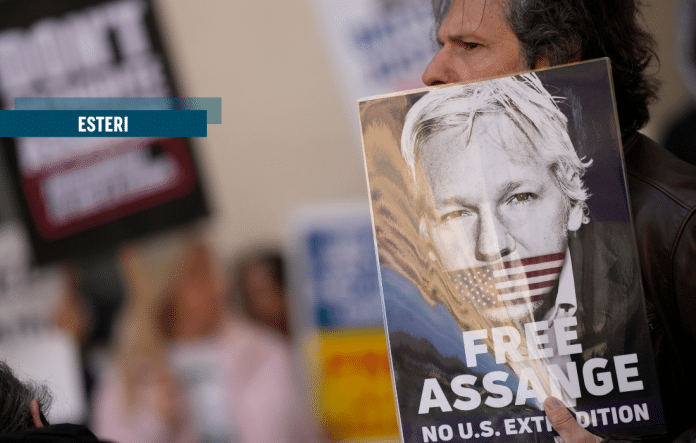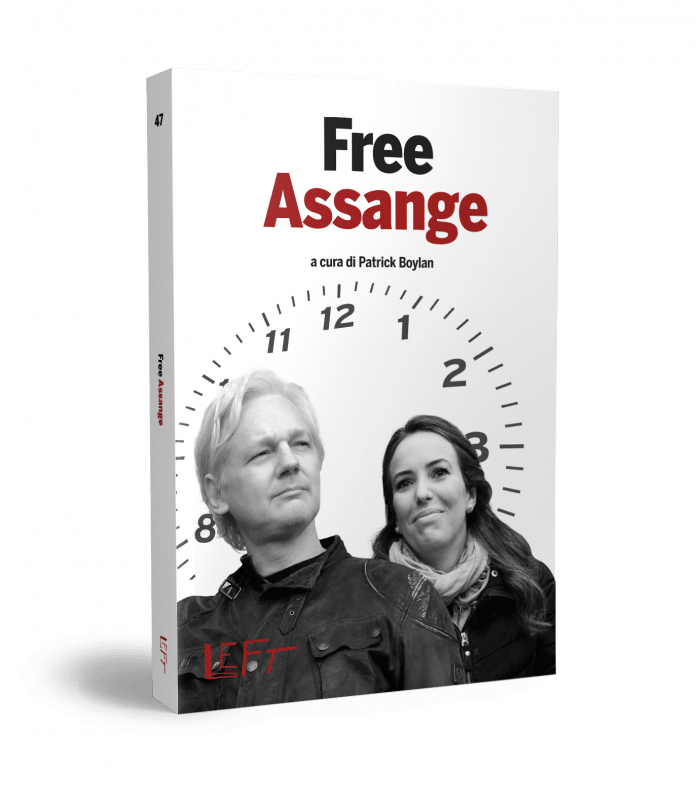In un momento in cui molto si discute della crisi del centrosinistra, della frammentazione della sinistra e della necessità di ripensare la forma partito pubblichiamo come contributo al dibattito questa intervista di Alexandre Gilbert alla filosofa Livia Profeti uscita sul Times of Israel. Al centro della discussione parole chiave come uguaglianza, soggettività collettività e la necessità di liberarsi di un velenoso retaggio heideggeriano
Lei ha proposto di rinominare l’esistenziale heideggeriano dell’«esser-gettato»: non più «nel-mondo», come abitualmente è inteso, ma «in-un-mondo». Ci può spiegare perché?
Quella modifica esprime sinteticamente la mia tesi sulla negazione dell’uguaglianza universale in Essere e Tempo. In quel testo del 1927, Heidegger – che cinque anni dopo, con l’avvento al potere di Hitler, sarebbe diventato il primo rettore Führer nazionalsocialista – ha proposto un’ontologia che si è opposta tanto all’Illuminismo quanto al marxismo con il sedicente scopo di superare i limiti della tradizionale definizione di uomo come «animale razionale». In realtà, non solo Heidegger non ha affatto superato quei limiti, ma in Essere e tempo nega l’uguaglianza universale proponendo una differenza ontologica tra popoli.
La chiave di questa negazione sta appunto nella parola «mondo» che, negli esistenziali heideggeriani, non indica una struttura universale ma ha il significato dell’ambiente fisico e culturale di nascita. Heidegger, modificando in maniera piuttosto mascherata ma tuttavia identificabile il senso del termine, solo apparentemente si basa sulla critica che ha portato Husserl a postulare la necessità di un «mondo-della-vita» (Lebenswelt), poiché nega l’universalità di quella concezione husserliana. Al contrario, il mondo heideggeriano dove saremmo «gettati», contribuirebbe a determinare la nostra essenza, che sarebbe quindi diversa a seconda se fossimo nati in Germania, Italia, Francia, piuttosto che in Russia, Africa, Cina, ecc. Le differenze ontiche sono così elevate ad un rango ontologico in Essere e Tempo, affermando una diversità originaria che nega il fondamento comune dell’umanità a favore delle differenze etniche tra le culture. Per questo è più corretto dire che, secondo Heidegger, si è «gettati» in un mondo, e non nel mondo. Con ciò, non è mia intenzione difendere un universalismo astratto che ignori le differenze culturali oggettive, ma riaffermare la centralità di un’idea che è stata la stella polare di tutte le lotte di emancipazione degli ultimi due secoli. L’ontologia heideggeriana, alla base della filosofia postmoderna, ha cancellato questa stella polare: l’idea di uguaglianza tra tutti gli esseri umani. È necessario recuperarla con una nuova ricerca umanistica che si fondi sull’inevitabile compresenza di eguaglianza e diversità nella condizione umana, anche se questa può apparire una contraddizione insanabile.
- Eppure, Heidegger critica il razzismo e il biologismo nei Quaderni neri.
I suoi apologeti lo sostengono, basandosi sul fatto che egli deplora le concezioni razziali dell’epoca e, più precisamente appunto nei Quaderni neri (pubblicati in Italia da Bompiani ndr) la «volgarità» del nazionalsocialismo. Tuttavia, contemporaneamente, negli stessi Quaderni e nei corsi universitari degli anni Trenta, Heidegger afferma esplicitamente che la razza è una condizione necessaria per l’«autenticità» di un popolo. Dunque non si può certo dire che rifiuti il razzismo e il biologismo. Egli si limita a negare che «sangue e suolo» siano le uniche condizioni di tale autenticità, ciò che invece costituirebbe la «volgarità» dei nazisti… In realtà, per capire il razzismo heideggeriano non ci si può fermare alla prima sezione di Essere e Tempo ma si deve tenere conto anche della seconda, che tratta della storicità. Johannes Fritsche, con il suo Historical Destiny and National Socialism in Heidegger’s Being and Time del 1999, aveva già dimostrato i legami tra la nozione nazista di comunità, la Volksgemeinschaft, e i paragrafi dal 72 al 77 di Essere e Tempo. Nel paragrafo 74, in particolare, si scopre che l’esserci «autentico» heideggeriano, che mira a sostituire la nozione moderna di soggetto, non è in verità l’individuo ma una comunità storico-destinale di popolo. Analizzando in profondità questo capoverso e mettendolo in relazione con gli altri testi heideggeriani degli anni 1928-1929 e con i Quaderni neri, ho compreso che, secondo Heidegger, il «sangue e suolo» sono appunto necessari per la trasmissione delle possibilità storico-destinali tra generazioni, ma non sufficienti, in quanto mancherebbe loro l’atto della «decisione», con cui l’esserci assume la «cura» del «proprio» mondo. In breve, la decisione heideggeriana, considerata per decenni come l’atto libero determinante per la realizzazione più profonda dell’essere umano, in realtà è la terza condizione che Essere e Tempo aggiunge alla concezione nazista di popolo. La storicità heideggeriana non rifiuta la dottrina razziale fondata sulla biologia, la ingloba. Ecco perché preferisco chiamarla «bio-storicità».
Heidegger, con tale «bio-storicità», stava cercando di prendere le distanze da un biologismo esclusivamente tedesco?
Visto il disprezzo che provava per le scienze, direi piuttosto che la sua intenzione era quella di proporre un’ontologia che fosse «superiore» alla sola biologia. In ogni caso, così facendo, il suo pensiero ha diffuso una negazione peggiore di quella di una determinata dottrina razziale, perché ha fornito la base per così dire “filosofica” su cui qualsiasi forma di razzismo può fondarsi. Per questo troviamo l’heideggerismo negli ambienti più disparati: dai neonazisti europei e americani all’estrema destra russa e al fondamentalismo islamico.
Heidegger, infatti, conformemente alla propria ontologia, riteneva che ciò che ha chiamato «Storia dell’Essere» si svolga a partire da inizi, il cui compito destinale spetta all’esserci in quanto comunità di popolo. Secondo lui, nel secolo scorso tale comunità era la Volksgemeinschaft nazista, cui l’Essere avrebbe riservato il compito di realizzare il nuovo inizio dell’Occidente anche a costo delle «camere a gas», come si può leggere nei Quaderni neri. Conseguentemente, sempre sulla base della stessa ontologia, qualsiasi Califfo che semina il terrore può affermare un concetto simile nei confronti della propria comunità islamica. Anche una “russificazione” di tale Storia dell’Essere è possibile, quale propone ad esempio Alexandre Dugin, secondo il quale «il nuovo inizio di Heidegger» non può essere rivolto ai popoli dell’Occidente bensì alla comunità del popolo russo, come Gaëtan Pegny mostra nel suo articolo Alexandre Douguine, un heideggerisme à la fois assumé et dissimulé. Il teorico ultranazionalista che si dice abbia ispirato la politica aggressiva di Vladimir Putin ha dichiarato, durante il recente funerale della figlia vittima di un attentato probabilmente indirizzato a lui, che la ragazza era morta «per la Russia, per la sua verità». Chissà cosa avrebbe pensato Tolstoj di questa alètheia heideggeriana in salsa russa …
Ciò che accomuna queste disparate posizioni è tanto la negazione dell’uguaglianza universale quanto una forte rivendicazione identitaria su base comunitaria, provenienti entrambe da Essere e tempo. E se è comprensibile che esse siano rivendicate da forze ultraconservatrici di destra, la cosa sorprendente è che esse siano affermate anche dagli intellettuali postmoderni cosiddetti progressisti, esattamente perché si sono ispirati alla stessa fonte. Così, per citare un solo esempio sorprendente anche se poco noto, si possono leggere parole simili sugli ebrei che, al contrario, hanno subito la Shoah. È il caso del saggio Israele. Terra, ritorno, anarchia di Donatella Di Cesare, in cui la «comunità» ebraica rappresentata dallo Stato di Israele è chiamata ad iniziare una «nuova epoca». Tali «tempi nuovi» inaugurati da Israele dovrebbero assolvere il «compito» di sovvertire l’ordine mondiale incentrato sulla nazione, anche se la sua permanenza in Palestina è un’«effrazione». Di Cesare inoltre, in questo saggio «teologico-politico», sottolinea costantemente l’identità «ebraica», mentre l’uguaglianza universale viene definita una «chimera». Si potrebbe parafrasare: «da ciascuno secondo la sua comunità, a ciascuno secondo la sua Storia dell’Essere». Per tornare alla sua domanda, va sottolineato che il modo in cui Heidegger ha «preso le distanze» dal biologismo nazista, per esprimermi con le sue parole, è stato il fondamento di un percorso culturale che ha prodotto il fenomeno per cui, ai giorni nostri, la radice dell’intolleranza (o dell’indifferenza) verso l’altro non è più la sola presunta nozione biologica di razza, ma un comunitarismo radicale anche su base religiosa e culturale. E sebbene le intenzioni della maggior parte degli intellettuali postmoderni come Di Cesare non siano violente, questi esponenti non si sono mai sentiti a disagio nell’affidarsi alle stesse idee che ispirano oggi la nuova destra, «favorendo così indirettamente la sua volontà di riconquistare l’egemonia intellettuale», come Emmanuel Faye ha di recente giustamente affermato.
I primi Quaderni neri pubblicati a partire dal 2015 hanno suscitato molto scalpore. Quale elemento nuovo e particolarmente intollerabile del pensiero di Heidegger hanno rivelato, a suo parere?
In realtà io ritengo che, nonostante l’insostenibile pesantezza dei Quaderni neri, essi non ci presentino concrete novità nel suo pensiero, che mantiene una sostanziale continuità dall’inizio alla fine. In questo senso condivido il parere del suo ultimo assistente recentemente scomparso, Friedrich-Wilhelm Von Herrmann, il quale ha dichiarato in un’intervista del 2015 che i Quaderni neri hanno la funzione di completare quanto descritto nei grandi trattati a partire da Essere e Tempo, e sono inseparabili da essi. Von Hermann intende così smentire l’antisemitismo di Heidegger, mentre questo a mio avviso dimostra la continuità tra l’opera del 1927 e le affermazioni apertamente filonaziste e antisemite degli anni Trenta, contenute sia nei corsi che nei seminari dello stesso periodo di quei primi Quaderni pubblicati. Essi sono senza dubbio importanti, perché consentono di analizzare in modo più profondo questa continuità e queste implicazioni, ma, almeno fino ad ora, non hanno presentato elementi di novità. Semmai offrono conferme fondamentali di ciò che Emmanuel Faye aveva portato alla luce sin dal 2005 con il suo Heidegger, l’introduzione del nazismo nella filosofia.
Lei ha curato l’edizione italiana di questo libro, con molte citazioni di brani heideggeriani inediti, mentre la traduzione dei volumi dei Quaderni neri in Italia è stata oggetto di controversie. Crede che il modo di tradurre i testi di Heidegger sia importante per comprendere il suo pensiero?
Vorrei innanzi tutto sottolineare che con i Quaderni neri si pone lo stesso problema che c’è con le altre traduzioni degli scritti di Heidegger. Inediti a parte, nel mio lavoro sul libro di Faye ho consultato le varie traduzioni italiane dei molti altri brani citati già pubblicati, e ho constatato con stupore che quasi tutte usavano strani neologismi, anche nel caso in cui Heidegger impiegava termini comuni. E ciò accade anche in altre lingue, soprattutto in francese. Per restare in Italia, il quadro complessivo di queste traduzioni era desolante, fatta eccezione per quelle di Franco Volpi che, nella maggior parte dei casi, le ha accompagnate da glossari dove viene fornita una chiara spiegazione delle scelte controverse. Di contro, ci sono altre traduzioni di fatto inutili, perché i molti neologismi coniati rendono gli scritti incomprensibili rispetto alle altre opere heideggeriane. Variamente situata tra questi due opposti si pone la maggior parte delle altre traduzioni, la quale, secondo l’impressione personale che ne ho tratto, esprime l’imbarazzo intellettuale di trovarsi di fronte a sorprendenti affermazioni razziste e filonaziste in lingua tedesca, scritte da un personaggio che, detto per inciso, è stato ampiamente considerato come uno dei più grandi pensatori del secolo scorso. Si può quindi comprendere che i traduttori abbiano, anche inconsciamente, cercato di indebolirne il significato. Tuttavia, questi tipi di traduzione hanno di fatto impedito la possibilità di una più vera comprensione del pensiero di Heidegger. Anche per questo motivo, quando siamo venuti a conoscenza dell’esistenza dei Quaderni neri mi sono rammaricata una volta di più della prematura scomparsa di Volpi nel 2009, una vera perdita per la cultura italiana.
Si deve riconoscere oggi una specificità dell’heideggerismo italiano, ad esempio in Donatella De Cesare o Diego Fusaro?
Credo che l’unico che possa definirsi tale sia stato quello di Gianni Vattimo, il principale teorico del «pensiero debole» della fine degli anni Ottanta. Più recentemente ne ha proposto una versione ancor più discutibile e contraddittoria, che unisce Heidegger, Marx e il cristianesimo, ma, quanto meno, il suo pensiero ha avuto una sua originalità e peso internazionale, rispetto ai quali gli heideggeriani «mediatici» dei nostri giorni, come appunto Diego Fusaro e Donatella De Cesare, appaiono solo gli ultimi epigoni dell’influenza di Heidegger sul pensiero di sinistra cui abbiamo già accennato, risultato di una deliberata captazione che risale a molto tempo fa. Nel 1947, con la famosa Lettera sull’umanismo in risposta polemica a Sartre, Heidegger ha offerto alla cultura di sinistra un abbraccio mortale: con una sorta di gioco di prestigio, interpretando arbitrariamente l’alienazione marxista come Heimatlosigkeit – tradotta nell’innocente «spaesamento» – egli trasforma l’alienazione marxista legata al lavoro nella perdita di appartenenza al “sangue e suolo” dove si nasce. Ed il capolavoro termina con la sentenza secondo cui «l’essenza del materialismo si cela nell’essenza della tecnica», dietro alla quale – come messo in evidenza negli studi del semiologo François Rastier – ciò che in realtà si «cela» è la sua condanna del pensiero «calcolante» e della «macchinazione» ebraica, ovvero l’antisemitismo heideggeriano messo invece in mostra nei Quaderni neri. L’influenza della Lettera sull’umanismo sulla cultura del dopoguerra è stata cruciale. Peraltro, nel suo più recente Arendt e Heidegger. La destruction dans la pensée, Emmanuel Faye ha rivelato che quel testo fu il motivo del riavvicinamento tra i due a Friburgo, nel 1950, dopo diciassette anni di assoluta distanza. Sempre descritto nei termini di un fumetto rosa, Faye rivela che quell’incontro, inizio della nuova alleanza postbellica tra Arendt e Heidegger, fu dovuto alla profonda adesione intellettuale di Arendt a quell’«attentato ai fondamenti della cultura occidentale» che lei aveva colto nella Lettera sull’umanismo letta un anno prima.
Donatella Di Cesare e Diego Fusaro possono rappresentare, a suo parere, la nuova cultura italiana di sinistra?
Di Cesare e Fusaro sono due intellettuali molto diversi, anche se entrambi derivano dall’influenza heideggeriana sulla cultura italiana cosiddetta “di sinistra”. Di Cesare è vicina al filone postmoderno mentre Fusaro attinge per lo più al pensiero successivo di Costanzo Preve, filosofo politico italiano che, proveniente dall’hegelo-marxismo, ha finito per teorizzare la cancellazione dell’opposizione destra/sinistra dando origine alla corrente italiana dei cosiddetti “rosso-bruni”. Tuttavia, nonostante la diversità, Di Cesare e Fusaro sono accomunati tanto dall’adesione alla negazione heideggeriana dell’uguaglianza universale a favore dell’idea di comunità, quanto dall’ingerenza della religione nella filosofia: cristiana per Fusaro, ebraica per Di Cesare. A mio avviso si tratta di due posizioni teoriche molto lontane dal pensiero di sinistra, perché ne negano i fondamenti. Non direi proprio, quindi, che questi due intellettuali possano rappresentarlo in Italia.
Di recente Fusaro ha mostrato maggiormente i suoi tratti di destra: difende la famiglia tradizionale come baluardo della comunità, si mobilita contro i diritti civili, mette in discussione la laicità dello Stato e si propone di “superare” l’antifascismo. Le sue proposizioni fondamentali non hanno nulla di “marxista”, perché la sua opposizione al liberalismo e alla globalizzazione si lega ben di più al logoro pensiero della destra sociale. Mentre Di Cesare si è chiaramente schierata con posizioni tipiche della sinistra, come quelle a favore dei migranti o, più recentemente, dei negoziati di pace per la guerra russo-ucraina. Ma, vista l’ambiguità delle sue posizioni teoriche rispetto ai fondamenti della cultura progressista, le contraddizioni tra teoria e prassi ostacolano, di fatto, l’efficacia stessa dei suoi proclami. Onestamente non saprei citare un filosofo che potrei dire “rappresenti” una nuova cultura di sinistra italiana, ma direi che la cultura progressista sia ovunque in crisi. Però Maurizio Ferraris è tra i pochi che, a mio parere, tentano di proporre nuove idee. Nel 2011 ha richiamato l’attenzione della società su una corrente filosofica che ha chiamato «Nuovo Realismo», un movimento internazionale che, benché differenziato, mira unitariamente a restituire profondità alle nozioni di realtà e verità, mettendo così in discussione le basi della cultura postmoderna. Il realismo proposto da Ferraris non è l’accettazione passiva e conservatrice dell’esistente, ma la prima tappa di ogni emancipazione, perché bisogna prima di tutto accettare che qualcosa sia oggettivamente «reale», per poterlo criticare e modificare. Recentemente, con il suo ultimo lavoro Documanità, la realtà che Ferraris “guarda in faccia” è quella della rivoluzione tecnologica. Senza nascondere la drammatica crisi che l’automazione di tutti i processi produttivi annuncia all’umanità, ma senza nemmeno indulgere in un vittimismo senza speranza, Ferraris rifiuta la demonizzazione heideggeriana e postmoderna della tecnologia. Ricordando che la tecnica è una parte costitutiva dell’essere umano, indica il compito di una «rivoluzione concettuale» che ci accompagni durante il lungo periodo che ci servirà per trasformare la scomparsa di ogni lavoro ripetitivo in un’opportunità di progresso. Sulla stessa linea della tensione di Marx verso l’emancipazione dell’intera umanità per mezzo della riduzione delle disuguaglianze, propone un cambiamento nelle lotte politiche di sinistra, da basarsi sull’analogo cambiamento del plusvalore, che emerge oggi anche dalle registrazioni digitali che inconsapevolmente produciamo ogni volta che utilizziamo i nostri telefoni cellulari. È in questa messa in evidenza del valore aggiunto generato dal Web “immateriale” che vedo un’espressione filosofica che può contribuire alla formazione di una nuova cultura italiana di sinistra.
Diego Fusaro, interrogato sull’antisemitismo di Heidegger un’intervista che mi ha rilasciato nel 2018, ha dichiarato che, all’epoca, «la visione antisemita era radicata in Europa soprattutto nel mondo cattolico cui Heidegger apparteneva, ma non era una sua creazione. Molte persone nel mondo cattolico lo erano e quindi non c’è niente di sorprendente in ciò. Bisogna condannare il mondo antisemita ma il mondo antisemita non era Heidegger». Cosa ne pensa di queste affermazioni?
Penso che nella risposta sia ben visibile la funzione mistificatrice dei suoi giochi di parole. In questo caso il gioco ruota ancora intorno alla parola «mondo». Analizziamo la successione delle proposizioni: in primo luogo Fusaro suggerisce che nell’antisemitismo nazista non ci fosse nulla di nuovo in quanto l’antisemitismo era già diffuso in Europa, soprattutto nel «mondo cattolico»; poi, data l’affermazione che Heidegger era cattolico, Fusaro deduce che il suo antisemitismo fosse per così dire “normale”, come per tanti altri casi del «mondo cattolico»; infine sostiene che bisogna condannare «il mondo antisemita» che però, dice «non è Heidegger». Ora, la prima affermazione è negazionista, perché riduce il genocidio nazista a una persecuzione simile alle precedenti; la seconda è falsa, perché Heidegger si era allontanato dal cattolicesimo tanto quanto gli altri nazisti; la terza è dissociata, perché non si comprende più di quale mondo «antisemita» parli Fusaro: se cattolico o nazista, che peraltro sovrappone illegittimamente. La ripetizione delle parole è ipnotica, il tono è tranchant. Chi legge velocemente non si accorge della dissociazione, e i “messaggi” che passano sono la minimizzazione dell’antisemitismo heideggeriano e la negazione della Shoah. Quest’ultima è particolarmente grave e denota anche un certo grado di superficialità filosofica da parte di Fusaro, perché la Shoah non è stata affatto un episodio di antisemitismo simile ai precedenti. I nazisti non volevano opprimere, ghettizzare, violentare o scacciare gli ebrei. Non si accontentavano di “distruggerli”. Volevano farli sparire, eliminarli dal mondo e dalla storia come se non fossero mai esistiti.
Può chiarire la differenza tra «distruggere» e «far sparire» a proposito della specificità dell’antisemitismo nazista?
Questa differenza è stata analizzata dallo psichiatra italiano Massimo Fagioli sulla base della sua scoperta della «pulsione di annullamento» quale radice psichica della negazione. Secondo Fagioli, la pulsione di annullamento è la forma estrema di violenza, che supera la distruzione materiale in quanto scomparsa mentale non cosciente dell’umanità altrui. Una dimensione interiore che ha permesso ai nazisti di concepire l’eliminazione di esseri umani come una “soluzione” per i loro deliranti obiettivi: Auschwitz per ottenere un Reich judenfrei (libero dagli ebrei), o il programma Aktion T4, che ha preceduto la Shoah e con il quale decine di tedeschi malati furono eliminati per ottenere «la purificazione della razza ariana». La fagioliana pulsione di annullamento spiega ciò che Freud, nel 1920, chiamò pulsione di morte senza comprenderla profondamente. Di per sé non mira alla violenza fisica, ma annulla il senso psichico del rapporto umano con l’altro: come se non fosse mai esistito, come se fosse possibile “produrre il nulla” al posto del vissuto, per così dire. Nella maggior parte dei casi avviene a livello delle relazioni personali, ma può diventare anche un fenomeno a livello storico-politico, come nel caso del nazismo e di tutti gli altri genocidi.
È però importante sottolineare che non si tratta del “fisiologico”, per così dire, funzionamento del pensiero umano. Al contrario, sostenendo che «il niente e l’essere sono la stessa cosa» (nota aggiunta nel 1949 a Che cos’è metafisica? del 1929), Heidegger postula il nulla come la più profonda verità umana. Egli partecipava al dibattito filosofico dell’epoca sulla funzione logica della negazione – come ben ricostruito da Stefano Poggi nel suo La logica, la mistica, il nulla. Una interpretazione del giovane Heidegger – e ha creduto di trovare l’«autenticità» in una concezione totalmente negativa dell’essere. Se l’ontologia heideggeriana fosse vera, Adolf Hitler e Rudolf Höss sarebbero stati gli uomini più “autentici” sulla terra! Fortunatamente Heidegger si è sbagliato. Ma è ancora purtroppo necessario ribadire che non è vero che abbiamo bisogno del suo pensiero per comprendere la Shoah, come affermano Donatella Di Cesare e altri. Basterebbe notare che la definizione heideggeriana dei campi di sterminio come «fabbricazione» di cadaveri (peraltro copiata da Arendt) – la quale dimostrerebbe la colpevolezza della «Tecnica» nella Shoah (ovviamente scagionando il nazismo) -, è assurda. Massimo Fagioli sottolineava infatti che Auschwitz non fu affatto una “produzione” di cadaveri ma un’eliminazione di corpi: un far scomparire persino la materia. Come se i nazisti pretendessero di poter creare il nulla. Al pari di un dio che, solo, diceva Heidegger, potrebbe «salvarci»… Ne abbiamo abbastanza di questi discorsi deliranti, che hanno fatto sin troppi danni. Le nostre società sono angosciate per molte buone ragioni, dalla crisi economica a quella climatica, dalle nuove epidemie alla guerra che bussa alle nostre porte come un fantasma risorto. Non abbiamo bisogno di questo nichilismo mistico per affrontare i nostri tempi difficili. Al contrario, è necessario cercare una nuova fiducia nell’essere umano a partire da una nuova concezione della sua intera soggettività, compresi gli aspetti senza coscienza come il primo periodo della vita o il sonno. Una concezione umana “positiva” che confuti quella heideggeriana di un Essere con la “e” maiuscola come nulla, che, se esistesse, non potrebbe che tendere al nulla.
La filosofia può aiutarci a trovarla?
Penso di sì. Sebbene la concezione moderna di soggetto, basata fondamentalmente sulla razionalità, abbia mostrato i suoi limiti nel corso della storia, all’inizio della moderna metafisica laica troviamo nozioni che potrebbero essere riprese per contribuire a concepire una condizione più completa dell’essere umano, fondata su una positività anche al di là della semplice razionalità. Attualmente sto lavorando su questo argomento intorno alla nozione di «infinito positivo» in Descartes, che, peraltro, è l’autore più osteggiato da Heidegger, il quale ne ha diffuso la visione caricaturale di fondatore del «pensiero calcolante». In realtà, il cogito cartesiano era molto articolato, vi appartenevano anche i sogni, l’amore, l’odio, il sentire, l’immaginazione, così come tutte le forme di espressione umana. Siamo quindi molto lontani dalla caricatura heideggeriana. Descartes era ancora legato all’umanesimo rinascimentale, come ha dimostrato ancora Faye nel suo Philosophie et perfection de l’homme. De la Renaissance à Descartes. Nonostante i secoli che ci separano, il pensiero cartesiano non è poi così lontano dalla migliore sensibilità contemporanea, perché parla ancora alla nostra umanità profonda. Io lo sto ascoltando, perché sono convinta che ci siano sempre cose da scoprire nel pensiero dei geni. Descartes, lo era, Heidegger no.
(ha collaborato Francesca Dal Conte).
Livia Profeti è ricercatrice in filosofia presso il laboratorio ERIAC dell’Universita di Rouen-Normandie. Autrice di L’identità umana (L’Asino d’oro) e di diversi saggi critici su Heidegger pubblicati in Italia, in Francia e in Germania, nel 2018 ha partecipato al XXIV FISP World Conference a Pechino con un intervento dal titolo Born Equal to Become Different. Tra le sue ultime pubblicazioni: L’identité humaine entre nature et histoire: repenser l’égalité à partir de la critique par Massimo Fagioli de la raison des Lumières (Lumières no. 33, 2020) e Anche le donne filosofano: una replica a Thomas Sheehan (Materialismo storico, n. 2/2021).
Alexandre Gilbert è il direttore della galleria d’arte Chappe a Parigi; scrive per il Times of Israël e LIRE Magazine Littéraire.
L’intervista in francese uscita sul Times of Israel: https://frblogs.timesofisrael.com/nul-besoin-detre-nihiliste-il-faut-repenser-egalite-et-subjectivite-pour-surmonter-la-crise/
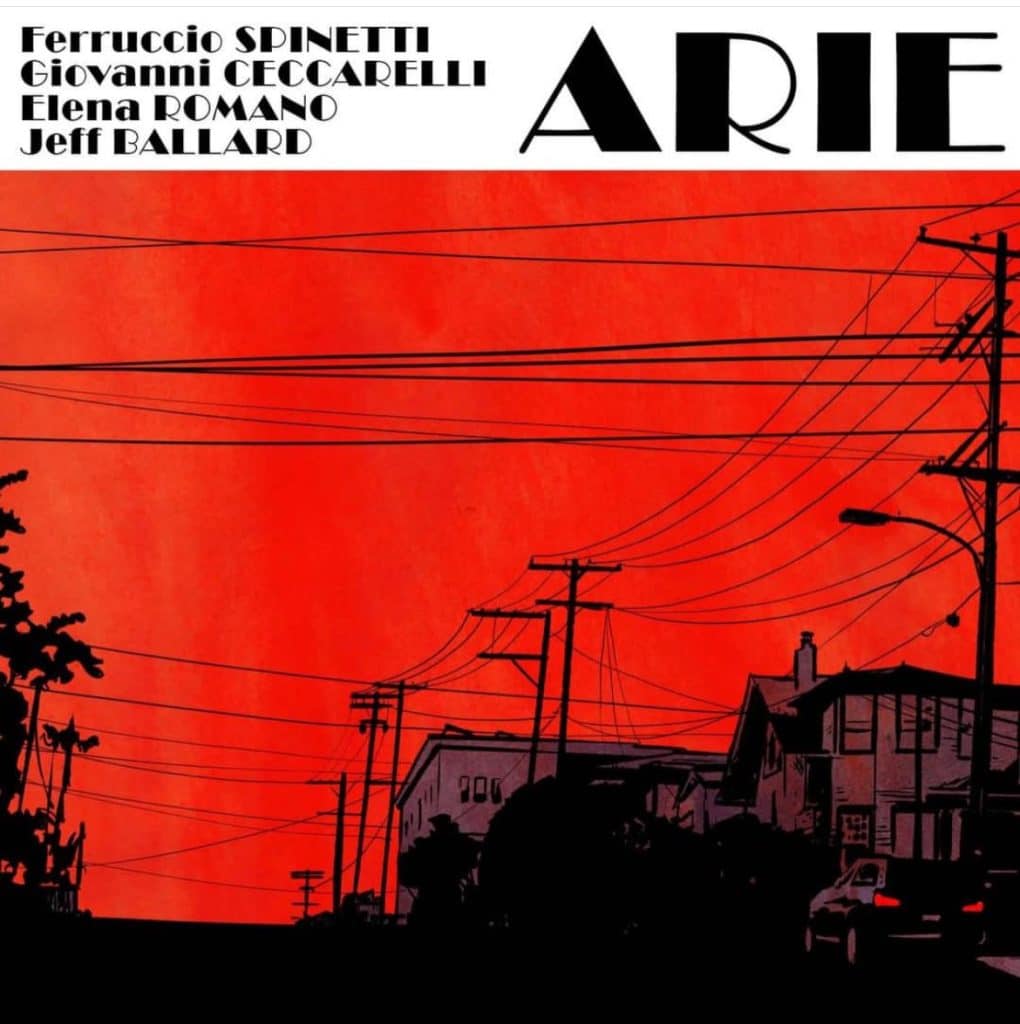 Dall’omaggio a De André con Petra Magoni all’avventura da solista. È uscito a ottobre di quest’anno per l’etichetta Jando Music l’ultimo album di Spinetti, Arie (che presenta il 30 novembre a Roma, alla Casa del jazz, l’1 dicembre a Milano, Blue Note, il 2 dicembre ad Ascoli Piceno, Cotton Club). Un disco «a completa tradizione italiana», come lui stesso lo definisce nelle note al suo sito. Porta sì, per la prima volta, la sua firma da solista, ma anche quella del singolare ensemble che attorno a lui si è formato, captando le suggestioni raccolte tra i tanti laboratori tenuti a Siena Jazz, da un lato, e suonando in giro per il mondo, dall’altro. Con lui, infatti, ci sono Jeff Ballard, da poco trasferitosi in Italia, nome supremo della batteria jazz che ha collaborato con, tra gli altri, Chick Corea e Brad Mehldau, Giovanni Ceccarelli al pianoforte, già con Spinetti in altri progetti come quello di InventaRio e del disco More Morricone, la special guest Rita Marcotulli, che dà il cambio a Ceccarelli in due brani; e, infine, la voce della appena venticinquenne Elena Romano, allieva di Spinetti nel gruppo di musica d’insieme di Siena Jazz. «Ho osservato Elena – dice – per otto mesi e alla fine ho deciso di coinvolgerla, preferendola ad altre vocalist più affermate e famose. Il rischio mi piace, una sfida nella sfida». Spinetti, che dirige il Premio Bianca d’Aponte per le cantautrici emergenti, dichiara infatti di voler dare una possibilità ai giovani, nell’ottica di schiudere il mondo della musica alle novità, oggi che «i piccoli club scoperti e attraversati ai tempi di Musica Nuda non esistono più», e di scovare talenti: «Bisogna andare a scavare sotto le cantine ancora oggi, gli under 30 hanno incredibili abilità tecniche. Quest’anno (al Premio Bianca d’Aponte, ndr) avevamo 11 finaliste: ragazze di 25, 30 anni che hanno assorbito la lezione dei grandi ma che cercano di costruire le loro canzoni».
Dall’omaggio a De André con Petra Magoni all’avventura da solista. È uscito a ottobre di quest’anno per l’etichetta Jando Music l’ultimo album di Spinetti, Arie (che presenta il 30 novembre a Roma, alla Casa del jazz, l’1 dicembre a Milano, Blue Note, il 2 dicembre ad Ascoli Piceno, Cotton Club). Un disco «a completa tradizione italiana», come lui stesso lo definisce nelle note al suo sito. Porta sì, per la prima volta, la sua firma da solista, ma anche quella del singolare ensemble che attorno a lui si è formato, captando le suggestioni raccolte tra i tanti laboratori tenuti a Siena Jazz, da un lato, e suonando in giro per il mondo, dall’altro. Con lui, infatti, ci sono Jeff Ballard, da poco trasferitosi in Italia, nome supremo della batteria jazz che ha collaborato con, tra gli altri, Chick Corea e Brad Mehldau, Giovanni Ceccarelli al pianoforte, già con Spinetti in altri progetti come quello di InventaRio e del disco More Morricone, la special guest Rita Marcotulli, che dà il cambio a Ceccarelli in due brani; e, infine, la voce della appena venticinquenne Elena Romano, allieva di Spinetti nel gruppo di musica d’insieme di Siena Jazz. «Ho osservato Elena – dice – per otto mesi e alla fine ho deciso di coinvolgerla, preferendola ad altre vocalist più affermate e famose. Il rischio mi piace, una sfida nella sfida». Spinetti, che dirige il Premio Bianca d’Aponte per le cantautrici emergenti, dichiara infatti di voler dare una possibilità ai giovani, nell’ottica di schiudere il mondo della musica alle novità, oggi che «i piccoli club scoperti e attraversati ai tempi di Musica Nuda non esistono più», e di scovare talenti: «Bisogna andare a scavare sotto le cantine ancora oggi, gli under 30 hanno incredibili abilità tecniche. Quest’anno (al Premio Bianca d’Aponte, ndr) avevamo 11 finaliste: ragazze di 25, 30 anni che hanno assorbito la lezione dei grandi ma che cercano di costruire le loro canzoni».