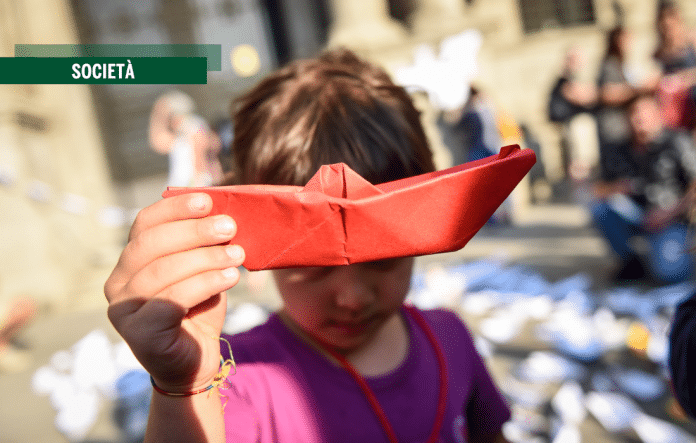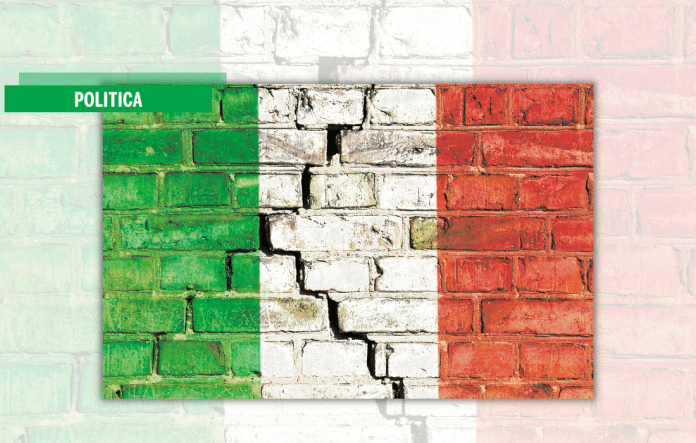La notizia, fornita in una intervista concessa al quotidiano La Repubblica il 19 novembre dal generale polacco Mieczyslaw Bienieck, ex primovice comandante strategico dell’Alleanza atlantica, secondo cui gli statunitensi armavano gli ucraini già dal 2014, è una notizia solo per i giornalisti italiani della grande stampa e per i loro lettori, sistematicamente disinformati e schiacciati ad arte sulla cronaca quotidiana. Naturalmente l’autorevolezza dell’informatore aggiunge qualcosa. Un segno che l’atlantismo furioso e persecutorio dei poteri mediatici italiani sta cedendo? Forse. Chi tuttavia non ha seguito lo logica binaria, quella del computer, “o sei con l’Occidente e sei con Putin”, ma ha attivato la mente dell’homo sapiens sapiens, sa che da millenni è consentito alla mente umana un più largo spettro di opzioni interpretative della realtà. Può fermamente condannare chi invade un altro Paese e conservare la capacità di collocare quella scelta in un complesso di fatti e di processi.
L’homo sapiens sapiens ha inventato la storia, la quale, come ha ricordato il geniale storico inglese Edward P.Thomposon, è «la scienza del contesto». La ricostruzione del tessuto delle vicende passate capace di illuminare le ragioni profonde del presente. Ed è la storia che oggi ci consente di collocare in uno scenario più vasto quel che è accaduto in Ucraina, e soprattutto in quale progetto di caos bellico rischiano di scivolare le sorti del mondo a partire da quella guerra.
In un rapporto del 2019 dell’Istituto di studi strategici Rand corporation, finanziato dal ministero della Difesa americana, si possono leggere limpidamente le ragioni geostrategiche del trascinamento della Russia nella guerra con l’Ucraina. Il titolo del rapporto è programmatico Overtexenting and unbalancing Russia (Sovraccaricare e destabilizzare la Russia) e fornisce anche informazioni di carattere storico, ad esempio sugli aiuti statunitensi a Kiev già nel 2014. Ma sono le indicazioni e le proiezioni strategiche a mostrare che gli Stati Uniti hanno continuato la Guerra fredda dopo il 1989, non solo circondando la Russia di basi militari Nato, collocate nei Paesi dell’ex Patto di Varsavia, ma anche con l’intenzione di puntare direttamente al collasso dell’ex nemico. Un collasso della Russia dopo quello dell’Urss.
«Fornire armi letali all’Ucraina, riprendere il sostegno ai ribelli siriani, promuovere un cambio di regime in Bielorussia, sfruttare le tensioni armene e azere», sono solo alcune delle raccomandazioni più urgenti del Rapporto. Ovviamente oggi non costituiscono grandi novità per il cittadino informato, ma sono rivelatrici di una strategia di ampio respiro e soprattutto di un metodo. Quello «sfruttare le tensioni armene e azere» illumina, ad esempio, l’interesse primario degli Usa e della Nato per i conflitti interetnici e le questioni di confine, che possono dar luogo a scontri armati e a guerre, occasioni preziose per lo smercio di armi e per la penetrazione in terre e Paesi ben lontani dal Nord Atlantico. Ha fatto scuola l’ex Jugoslavia, trascinata e distrutta dai conflitti intestini che hanno riportato la guerra in Europa e aperto nuove strade alla presenza degli Usa nei Balcani.
Trascinare la Russia in nuovi conflitti ha uno scopo evidente. «La Crimea, l’Ucraina orientale e la Siria sono un salasso per l’erario russo e per il bilancio della difesa», si legge ancora nel rapporto. Un passo verso un possibile collasso economico dell’ex impero apre scenari imprevedibili e di grandi opportunità per le classi dirigenti statunitensi, e gli alleati Nato. Di sicuro il supporto economico smisurato fornito da Washington a Kiev, per una devastante guerra per procura, è un investimento da cui si attendono sostanziosi ritorni. E tuttavia il nostro racconto storico, la ricostruzione minimale del “contesto” – ci sarebbe da mettere nel conto anche il nazionalismo russo – è gravemente monco se non si tiene conto dell’intero disegno geostrategico che gli Usa stanno perseguendo.
La guerra contro la Russia è solo una tappa verso il conflitto con l’avversario più temuto, la Cina. Un paese che detiene mille miliardi del debito pubblico americano. Gli Usa hanno già incominciato a creare le tensioni per mettere in difficoltà Pechino con una serie di iniziative. Come ha di recente ricordato John Ross, giornalista e scrittore americano: «Per la prima volta dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina, il presidente Biden ha invitato un rappresentante di Taipei all’insediamento di un presidente americano. Il presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, il terzo più alto funzionario degli Stati Uniti in ordine di successione presidenziale, ha visitato Taipei il 2 agosto 2022. Gli Stati Uniti hanno chiesto la partecipazione di Taipei alle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno intensificato le vendite di armamenti ed equipaggiamenti militari all’isola. Le delegazioni statunitensi in visita a Taipei sono aumentate. Gli Stati Uniti hanno aumentato il loro dispiegamento militare nel Mar Cinese Meridionale e hanno inviato regolarmente navi da guerra statunitensi attraverso lo Stretto di Taiwan. Le forze per le operazioni speciali statunitensi hanno addestrato le truppe di terra taiwanesi e i marinai della Marina taiwanese».
Dunque nei prossimi anni e decenni la Nato a guida statunitense ci prepara uno scenario di tensioni internazionali e di possibili conflitti armati di portata inimmaginabile. Chiudere gli occhi di fronte a questa evidentissima e minacciosa prospettiva e non cogliere la drammatica importanza di una pace ragionevole tra Russia e Ucraina appare oggi una responsabilità inaggirabile delle classi dirigenti europee. Gli Usa, rafforzando ed estendendo la Nato, stanno imprimendo una esasperata torsione bellicista alle relazioni fra Stati. Ricordiamo che essi hanno 800 basi militari sparse per il pianeta. Perché, a che scopo? Quale progetto di dominio globale li ispira?
I governi, il ceto politico, la stampa italiana non possono più esaltare la fedeltà atlantica come un pegno di pace e di sicurezza, perché essa si appalesa ormai come un progetto di aggressività imperiale degli Usa. Quando, a chi sostiene la necessità di superare la Nato, si obietta – nei casi più benevoli – che “non si può essere antiamericani”, occorre ribattere che la fine di quella alleanza è innanzitutto nell’interesse del popolo statunitense. Gli Usa spendono annualmente intorno agli 800 miliardi di dollari in armamenti, un cifra spaventosa, investita nella distruzione di città e territori lontani, nell’uccisione di essere umani distanti migliaia di chilometri da Washington, risorse finanziarie che sono sottratte alla sanità americana, alla scuola, all’assistenza ai milioni di poveri che affollano quella società.
Ma la Nato e l’indirizzo bellicista delle sue prospettive mostrano il loro essere un efficiente relitto sopravvissuto al secolo passato, di fronte al quadro drammatico che oggi ci presenta il pianeta. Di quel che sta succedendo alla Terra si occupano una volta l’anno esperti e uomini di Stato nelle varie e sempre inconcludenti Conferenze sul clima dell’Onu. Ma noi siamo entrati in una fase inedita nella vicenda del genere umano con la testa girata verso il ‘900. Nei prossimi anni lo scioglimento dei ghiacciai potrà lasciare senza acqua fluviale sterminate popolazioni dell’Asia, la nostra Pianura padana col suo sistema idrografico disseccato, intere regioni dell’Africa desertificate dalla siccità.
Che ne faremo dei milioni di essere umani in fuga? Non è più chiaro della luce del sole che le migliaia di miliardi di dollari ed euro, dilapidati da tutti gli Stati in armamenti, andrebbero spesi per aiutare i Paesi poveri a convertire le loro agricolture, a ripristinare le foreste (sostenendo ad es. il Brasile di Lula a proteggere ed estendere l’Amazzonia), ad abbandonare l’uso dei carburanti fossili? Gli Usa, il Paese più ricco e potente del pianeta, con risorse straordinarie di cultura, tecnologie, intelligenze, dovrebbero essere la guida di un nuovo ordine multilaterale del mondo, capace di affrontare le grandi sfide ambientali e invece intendono trascinarlo in un’avventura potenzialmente mortale per responsibilità, peraltro, di una sola parte delle sue élites dirigenti.
Dunque è ormai evidente, anche a chi non vuol vedere, che oggi solo l’Europa, può spezzare questo disegno dissennato condotto da uomini presi da delirio di onnipotenza. Così come bisognerebbe che i media italiani cominciassero ad accorgersi di essere, volenti o nolenti, in quanto filoatlantici, sostenitori di uno progetto di guerra perpetua. Se oggi l’Europa, divisa su tutto tranne che nelle scelte contro i propri interessi e nella fedeltà agli Stati Uniti, non riesce a ritrovare il proprio progetto originario di forza di pace, non si comprende più quale sia la sua funzione oltre la moneta unica.