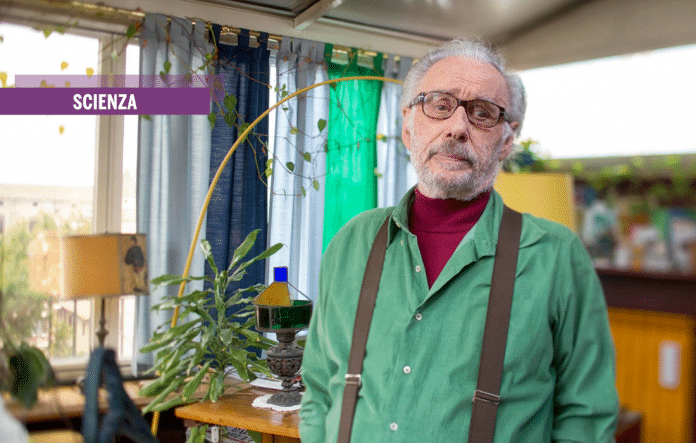Da secoli circola stranamente una futile domanda: chi fu davvero Shakespeare? Quella di non ritenere plausibile che persino lui, Shakespeare stesso, possa aver scritto i drammi di Shakespeare, è una tendenza radicata nel tempo. Sono state avanzate tante candidature, alcune eccellenti, come quella di Bacone, ad esempio. E da qualche anno si fa anche un gran parlare di un possibile candidato italiano. Viene promossa con insistenza, ma senza davvero prove soddisfacenti, l’idea che il Bardo altri non fosse se non il grande letterato e lessicografo John Florio, amico di Bruno il Nolano e personaggio di uno dei suoi più famosi dialoghi italiani, La cena de le ceneri.
I motivi per cui sono spesso sorte perplessità riguardo alla figura storica di Shakespeare appaiono paradossali; ma, come spesso capita alle fake news, questi nascono da buchi informativi. La biografia di Shakespeare, infatti, per i nostri standard moderni, è per certi versi lacunosa. Sappiamo molto, ma non abbastanza su di lui: o almeno, non quanto ci aspetteremmo di sapere circa un personaggio ritenuto tanto importante. Su alcune questioni, poi, rimangono dubbi tramandati da resoconti biografici postumi, non sempre tra loro concordanti.
A guardar bene, se di Shakespeare non si sa ancora quanto si vorrebbe, non è perché non dovette lasciare troppe tracce di sé, ma perché a noi piace immaginare che di un personaggio tanto noto si debba sapere tutto. E invece Shakespeare era, in vita, sicuramente meno famoso degli attori che calcavano le sue scene. Era l’uomo dietro le quinte, oltre a essere un impresario teatrale; non certo un front man. Per questo sappiamo tanto dei suoi affari e molto meno della sua vita mondana.
Il che basterebbe a placare la sete di chi tuttora vuole sostituirne la figura storica con quella di altri, di cui non sempre si sa tanto di più che di lui. Ma il caso Florio è interessante, perché si tratta di una persona assai in vista, protetto da personaggi dei più alti ranghi, perché era un vero e proprio mediatore culturale nell’Inghilterra del periodo (tradusse in inglese Boccaccio ma anche Montaigne), perché il suo giro di frequentazioni coincise per molti versi con quello di Shakespeare, e perché tra le sue opere e quelle del Bardo vi sono innumerevoli contatti. Questi hanno persino fatto presupporre una sua mano di ghost editor dietro la stesura del famoso in folio postumo, che raccolse quasi tutti i play di Shakespeare. E infine, Florio è interessante perché come ho detto fu amico di Bruno.
È infatti, quella del Nolano, una delle presenze oscure nella drammaturgia e nella poesia di Shakespeare. Esistono molti studi a riguardo, e possiamo oramai dare per scontato che, direttamente o indirettamente, il Bardo dovette aver presenti tanti insegnamenti del grande filosofo di Nola. In certi casi, alcuni giri di frase sembrano quasi tratti di peso da Bruno; come quando, in De gli eroici furori (libro che Shakespeare in qualche modo dovette conoscere) leggiamo l’intenzione di «prender l’armi contra la fosca ignoranza». È una frase che tanto risuona anche nelle parole di Amleto, allorché il giovane principe si chiede se valga o meno la pena di «prender l’armi contro il mare delle afflizioni».
È da poco uscito, per le edizioni della Normale, un libro del grande esperto di Bruno Michele Ciliberto, dal titolo Shakespeare: il male, il potere, la magia. È un testo che non affronta soltanto l’eredità bruniana in Shakespeare, ma si propone di rileggere il travaso di tutta una serie di idee e concetti nati nel Rinascimento italiano, e in un modo o nell’altro approdati nell’immaginario shakespeariano.
Sappiamo bene che Shakespeare, come tanti letterati inglesi del tempo, deve moltissimo alla cultura italiana. La sua sensibilità è per molti versi italiana, e probabilmente aveva una importante familiarità con la nostra lingua e la nostra cultura. È stato ad esempio dimostrato che i riferimenti biblici nei play di Shakespeare assomigliano molto a una traduzione inglese di traduzioni italiane, nonostante fosse ovviamente in circolazione una traduzione inglese a cui egli avrebbe potuto attingere.
Ciliberto individua, tra Shakespeare e l’Italia, un punto di contatto assai idiosincratico e poco sondato prima: lo chiama «“la linea drammatica” dell’età umanistica», una tendenza rappresentata ad esempio da Leon Battista Alberti, Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini e Pietro Pomponazzi. A questi si unisce ovviamente il Bruno dei dialoghi italiani che deve essere arrivato a Shakespeare sicuramente tramite Florio e Christopher Marlowe. Più che di fonti italiane, però, lo studioso si occupa di una più pervasiva eredità italiana, forte della consapevolezza che nell’Inghilterra del sedicesimo secolo l’italiano era «lingua corrente nei circoli culturali» e veniva inteso e praticato persino dalla regina Elisabetta. Esisteva poi a Londra una corposa comunità italiana e vi era persino una Chiesa degli Italiani.
Nel proporre quella che è a tutti gli effetti una «egemonia italiana» del Cinquecento, Ciliberto sposta l’asse dell’influenza dal solito nome sospetto, quello del Machiavelli – pure presentissimo già in Marlowe e poi in Shakespeare nelle riflessioni sulla politica – a un tipo di umanesimo di carattere «drammatico» evidente nelle grandi tragedie dei primi anni del Seicento, tutte incentrate sulla grande questione del potere. È un discorso che ripropone appunto una concezione drammatica «dell’uomo, della natura e della storia» ripercorrendo l’utilizzo di lemmi comuni tramite cui inquadrare in maniera assai illuminante l’italianità dell’arte di Shakespeare.
L’impostazione è tesa a vedere il peso che ha nelle opere del Bardo la «linea drammatica» del Rinascimento italiano, col suo riflettere continuo sul rapporto tra azione e destino, tra passione e memoria, tra l’indifferenza divina di un «Dio tiranno che agisce a suo capriccio e non secondo giustizia» come credevano i riformati (e per Tommaso Campanella «gli uomini sono giuoco di Dio e degli angeli») e la necessità per l’uomo di agire, per tentare di non soccombere, comprendendo la complessità antitetica della verità e della virtù. Il libro gravita però inevitabilmente anche intorno alla figura dell’eretico di Nola a cui Ciliberto ha dedicato tanti anni della sua vita e tanti studi.
Il Nolano, con la sua eterodossia indomita, permea i messaggi fondanti delle grandi tragedie shakespeariane di inizi Seicento, fornendo chiavi di lettura che i personaggi mancano di cogliere, i quali così condannano le proprie azioni all’inefficacia e segnano il proprio destino. Come nel Macbeth, in cui la coincidenza dei contrari che tutto anima è introdotta, all’inizio del dramma, dalla favola delle weird sisters, le streghe o sorelle fatali. Sapere che il bello è nel brutto e che il brutto è nel bello significa comprendere che il male è nel bene e che il bene è nel male, che nella menzogna vi è la verità ma anche nella verità la menzogna, e così via. Un insegnamento non da poco, se si pensa alle dottrine politiche desunte da interpretazioni semplificatorie in voga in Inghilterra del dettato di Machiavelli: il cosiddetto Machiavellismo.
Macbeth non coglie la coincidenza dei contrari, e così le sue azioni lo portano a peggiorare la situazione in un misto di tragedia e grottesco. Amleto non sa agire, o forse non sa se agire: sa però che le sue azioni non basteranno a raddrizzare i tempi fuor di sesto, e nel momento in cui agirà, non potrà che scardinare ancor di più la situazione esistente. Ogni speranza potrà soltanto esser riposta in qualcuno che venga da fuori, nella fattispecie Fortebraccio. Iago agisce ma seguendo le sirene della menzogna, una menzogna apparentemente ingiustificata, che non ha spiegazioni. E infatti, quando gli viene chiesto di dar conto del proprio agire, lui si rifugia nel silenzio. È lo stesso silenzio a cui si appella anche sul finire l’Amleto.
Questa tensione estrema verso la futilità del tutto, questo senso di impotenza, questa indecisione, sono parte della riflessione che fa Shakespeare a partire dalla «linea drammatica» su cui si concentra il professor Ciliberto, e danno il senso di quanto il Bardo dovette aver presente il dibattito a riguardo, nel Rinascimento italiano. Al Machiavelli, che compare nell’Ebreo di Malta (il dramma di Marlowe che ispirò certamente Il mercante di Venezia di Shakespeare), vengono dunque ad affiancarsi, quasi per spodestarlo, artisti e pensatori che ragionano sul concetto di crisi ponendolo al centro del dibattito, sul valore della poesia e del teatro quale «unico luogo possibile di verità», sulla lotta contro il passare inesorabile del tempo che pone fine alla vita, consumandone la fiamma e senza la certezza che opporvisi possa portare a qualcosa.
Si tratta di una tendenza proto-nichilista, che però si scontra con il vitalismo e il furore avanzati da Bruno, vitalismo e furore che non animano soltanto l’eroe ma tutta la natura coincidente con il divino. Ma se Bruno sembra estraniarsi da questa drammaticità inesorabile del destino dell’uomo – lui, il cui unico dramma fu una divertentissima commedia ricca di tanti personaggi e storie, Il Candelaio – vi viene ricondotto alla luce di un concetto che gli era caro: quello dell’ombra. Il libro di Ciliberto si apre con una citazione dal Come vi piace in cui si definisce la vita «un’ombra che cammina».
La metafora dell’ombra, tanto importante anche in Bruno, sorregge tutto l’impianto del libro. Se ne segue la trasmigrazione da Pindaro («sogno di un’ombra, l’uomo»), a Euripide («che ha chiamato questa vita sogno d’ombra») secondo Marsilio Ficino, fino allo Shakespeare di Amleto che capovolge il discorso parlando di sogni come ambizioni, «e la sostanza dell’ambizione è soltanto l’ombra di un sogno».
Ora, tramite un altro drammaturgo, l’irlandese Oscar Wilde, sappiamo che la parola «ombra» nel gergo elisabettiano indicava anche gli attori. Quello stesso Oscar Wilde che nel Dorian Gray aveva fatto un riferimento assai criptico proprio a Bruno. Attraverso la ricognizione della «linea drammatica», dunque, legame segreto ma indissolubile tra il Rinascimento italiano e l’arte di Shakespeare, ed essendo il teatro con la sua poesia l’unico spazio della verità, possiamo ora vedere come gli uomini non siano che attori, e dunque ombre che calcano il palcoscenico del mondo. Attori guidati da ambizioni che li porteranno forse solo al declino, perché in assenza di memoria e in assenza di passione, solo quello può il destino degli esseri umani, ovvero di esseri fatti «della stessa pasta di cui son fatti i sogni».
L’autore: Enrico Terrinoni è ordinario di Letteratura inglese all’Università per stranieri di Perugia e traduttore, tra gli altri testi, di Ulisse, Finnegans Wake e altre opere di Joyce. Nel 2021 ha curato e tradotto per Bompiani una edizione dell’Ulisse in edizione bilingue. Nel 2022 per Feltrinelli ha pubblicato Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma