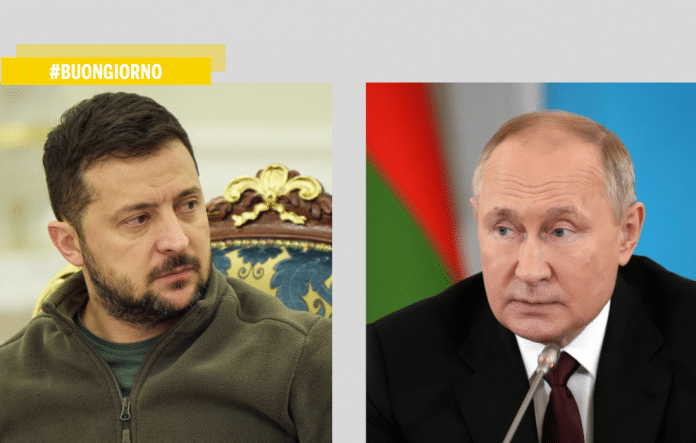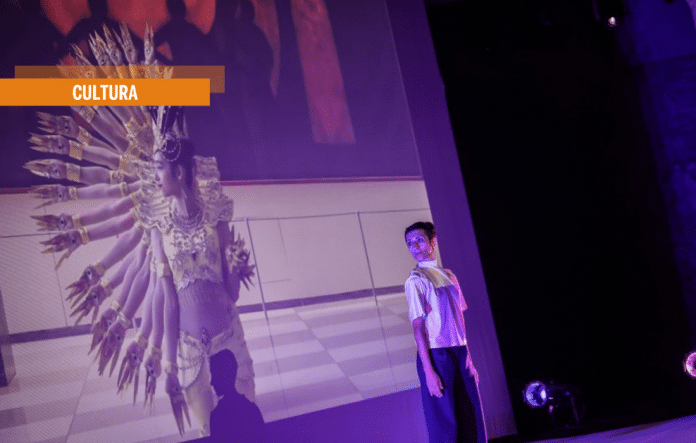«Ai nostri dirigenti nazionali mica interessa il territorio. Ciondolano tra carbonare e amatriciane»; «ma su Sud e lavoro, avete sentito qualcosa, un progetto? Niente, balbettano»; il Pd «è un partito maschilista, le donne per contare devono piegarsi alle correnti»; e ancora: il Pd è «screditato, respingente, misogino, confuso, ondivago, incoerente»; il Pd «è stato un insuccesso»; denunciamo «dossieraggi per far fuori dalle liste un ragazzo di 28 anni»; al Pd «serve ri-radicarsi nel Paese e capire se crede o meno in sé stesso»; un partito che «se non ha identità riconoscibile, allora l’identità diventa quella del Governo»; «serve una rivoluzione» (da La Repubblica del 6 e 7 ottobre 2022).
Non sono parole, giudizi che vengono dalla destra vincente delle ultime elezioni politiche. Sono incredibilmente parole che vengono da esponenti del Pd stesso, fuori e dentro la Direzione nazionale (De Luca, Provenzano, Cuppi, Morani, D’Elia, Lepore. I nomi che “‘contano” al momento tacciono, a parte brevi dichiarazioni di circostanza: Franceschini, Bonaccini, Boccia, Guerini). E tali giudizi si aggiungono alle dichiarazioni clamorose del predecessore di Letta, quel Zingaretti che si dimise da segretario in quanto «si vergognava di un partito impegnato solo a spartirsi le poltrone». Gli stessi esponenti che, con Letta, fino a soli pochi giorni fa, decantavano le grandi qualità del partito, unico argine alle destre, perno del centrosinistra.
Quale di quelle caratteristiche denunciate possono ritenersi proprie di un partito di sinistra?
Perché inutile girarci attorno: il primo e più tenace e pericoloso nemico del Pd è il Pd, e non da oggi.
Un partito che in tutti gli anni della sua esistenza non ha mai voluto affrontare, per convenienza, il nodo di fondo: chi è, chi rappresenta, quale la visione di mondo e di Paese. Un partito che non ha mai voluto discutere davvero, analizzare ciò che avveniva nel Paese, raccontare le grandi vittorie nelle amministrative (che vittorie spesso non erano, se solo si fosse analizzato).
Un partito che da anni non conosce il significato delle parole analisi, critica e autocritica (che fine hanno fatto le Agorà?), cui gli basta avere assessori, sindaci, ministri. Perché non basta darsi una “spolverata” di civismo, di solidarismo, per essere, ed essere percepito, partito di sinistra. Perché se poi sei il partito “della vocazione maggioritaria”, del Job act e della legge elettorale Rosatellum che ora, fintamente, non piace a nessuno (li fece Renzi, vero, ma da segretario del Pd e con una lunga corte di adoranti), della precarizzazione, del governo per il governo, che approva la riduzione dei parlamentari, che approva l’aumento delle spese militari e via elencando, hai voglia a definirti di sinistra.
Questa ambiguità di fondo del Pd ha costituito da un lato la garanzia di sopravvivenza (il fascino che ancora esercita su parte consistente del suo elettorato che lo vota, come un tempo, magari oggi turandosi il naso, perché “l’ha detto il partito”, non rassegnandosi che quel partito non c’è più) ma allo stesso tempo ne rappresenta il limite vero, perché non convince una altra gran parte di popolo di sinistra (che si rifugia oggi nei 5S e soprattutto nell’astensione) né all’opposto quella porzione moderata e “liberista” che preferisce orientarsi verso Calenda, né infine quella parte di elettorato popolare (che non vuol dire populista, ma delle periferie, degli strati meno protetti, e persino dei lavoratori a rischio “proletarizzazione”) che si affida alla destra vista non più come pericolo ma come ancora di salvataggio. Per essere il partito di tutti, nella narrazione, diventa il partito di nessuno.
Se il Pd in questi anni avesse definito il proprio abito, avrebbe avuto il merito di semplificare il campo politico, e, non di minore importanza, avrebbe contenuto l’avanzata delle destre e dei populismi in genere. E, paradossalmente, avrebbe rotto gli argini alla sua stessa crescita.
Se il Pd avesse scelto, persino legittimamente, di essere un nuovo moderno partito moderato, delle classi medie, liberista, certo con un’attenzione ai temi sociali, avrebbe potuto diventare un punto di riferimento sicuro per quel mondo, e probabilmente maggioritario. Stessa cosa se avesse scelto di essere un moderno soggetto dichiaratamente di sinistra, adottando programmi e facendo scelte conseguenti (esempi del Portogallo, della Spagna e in ultimo della Francia), e avrebbe invero potuto rappresentare il punto di riferimento di quel mondo, riducendo la frammentazione, e riconducendo al suo interno le varie sensibilità pure esistenti, e contribuito fortemente a limitare l’astensionismo.
Invece la sua ambiguità, il fare politiche liberiste ma al contempo dichiararsi partito di sinistra, ne fanno il vero nodo irrisolto della politica italiana. E finché questo nodo non si scioglie, non si riuscirà ad avere né un vero partito di centro moderato né “progressista”, né una sinistra compiuta. Perché poi alla fine la destra vince non perché FdI prende il 25% dei voti (un quarto dei votanti un ottavo degli elettori), perché la Lega prese anche di più, così come Fi (la loro somma è sostanzialmente stabile). La destra vince perché da anni oltre il 40% degli italiani si orienta a destra, stando ai sondaggi degli ultimi anni, non giorni, e quindi con un annoso problema di “egemonia” culturale oltre che politica.
La destra vince perché banalmente, semplicemente e prevedibilmente, si è unita, se pure furbescamente, sfruttando l’opportunità che il Rosatellum gli ha concesso e che, ripetiamo, è frutto avvelenato dello stesso Pd.
Ora si parla di “rifondare” il partito, di rivederne le basi, di ridiscutere tutto, persino, dice qualcuno, il nome ed il simbolo. Se questa operazione si traduce, come purtroppo pare, e senza cogliere l’opportunità storica, in uno scontro di apparato, tra capi e capetti, tra dirigenti, tra aspiranti segretari, al motto di “tutto cambi perché non cambi nulla”, allora è una pura operazione di facciata, da utilizzare già subito alle prossime elezioni nel Lazio e in Lombardia, dove stavolta non basterà però l’allarme patetico del “se no vince la destra” (ha vinto già nel Paese). Ma se fosse davvero sincera, cioè destinata a chiarire in modo definito natura e prospettive dell’attuale partito, non può che essere il primo passo non solo verso il chiarimento negli schieramenti politici nel Paese, ma potrebbe essere davvero l’approdo per tutto quel mondo che non poteva riconoscersi nel Pd.
Ciò vorrebbe dire passare non per la rifondazione del partito, ma attraverso il suo scioglimento, come di tutte le formazioni piccole e meno piccole alla sua sinistra, che non avrebbero più ragione sociale, per dare vita ad un nuovo, diverso partito.
Bisognerebbe cogliere questa opportunità per tirare una netta linea di demarcazione che discrimini chiaramente, e ovviamente legittimamente, chi è da una parte chi dall’altra. Ciò vorrebbe dire tagliare coraggiosamente con parte di apparato dei suoi mainstream (ex-renziani, Minniti, veltronisti, le finte narrazioni civiche, le narrazioni sui sindaci vincenti ma minoritari del secondo turno, ecc.), facendo anche scelte dolorose, persino sul piano personale e affettivo, ma riconoscendo che alcune visioni non hanno casa, non in un Pd rifondato, ma in un partito nuovo, altro: una Bolognina due.
Facendo un simile uno sforzo, politico e intellettuale, questo sì davvero generoso e di valore storico, si potrebbe aprire un processo “costituente”, non già del solo Pd ma collettivo di tutti i soggetti a sinistra a vario titolo interessati e chiamati al confronto, libero e paritario, e che potrebbe davvero essere un primo passo, forse decisivo, per la ricomposizione delle varie frammentarietà, più o meno fortunate, al termine del quale, a fronte di uno scioglimento comune, si possa dare vita finalmente ad un soggetto unitario, che guardi oltre alla propria sopravvivenza: offrire al Paese finalmente un grande partito di sinistra moderno, ricco anche di sensibilità pure diverse, ma che si riconoscono in una medesima prospettiva di fondo, e dove il confronto sia finalmente di idee e non tra correnti, dove il centro della discussione non sia la distribuzione degli incarichi, ma la definizione di una nuova idea di Paese.
Questa è la vera sfida che i risultati elettorali lanciano al Pd e alla sinistra tutta: ripensarsi, e ripensare ai motivi veri, oltre che alla necessità, di unità. Non so se sapremo cogliere l’occasione, se sapremo rinunciare ciascuno alle proprie rendite di posizione, ma il tempo è questo. Abbiamo almeno cinque anni.
L’autore: Lionello Fittante è tra i promotori degli Autoconvocati di Leu ed ex componente del Comitato nazionale èViva
Nella foto: la Direzione nazionale del Pd, Roma, 6 ottobre 2022