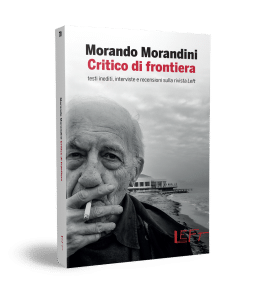Gli ultimi fatti di cronaca che ci parlano di delitti efferati senza movente richiedono, a noi psichiatri e psicoterapeuti formati con la Teoria della nascita di Massimo Fagioli, una presa di posizione necessaria per contrastare la ridda di interventi, sulla stampa e sul web, che ripropongono sempre e comunque il pensiero dominante. Tanto sono sconcertanti i fatti accaduti, quanto sono avvilenti le interviste rilasciate da specialisti del settore che, interrogati sulla natura dei gesti compiuti, hanno dichiarato la non riconducibilità del gesto ad una malattia mentale. Ci riferiamo in particolare ai delitti, susseguitisi nell’arco di pochi giorni, ai danni di una donna e di una famiglia. Il primo delitto è opera di Moussa Sangare, che ha accoltellato una giovane donna mai conosciuta prima. Una volta fermato, negava qualsiasi coinvolgimento; in un secondo momento, aveva confessato, nel colloquio con il gip, che quella sera aveva avvertito la “strana” sensazione di voler fare del male a qualcuno.
Il giovane era uscito di casa armato di 4 coltelli e, dopo aver incontrato e minacciato due adolescenti, aveva visto una donna e immediatamente aveva deciso: sarà lei la vittima. Dopo il delitto getta tre coltelli nel fiume e seppellisce il quarto per conservarlo “così”, come souvenir. Moussa aveva già mostrato segni evidenti di malattia mentale: isolamento sociale, aggressività nei confronti della madre e della sorella (che lo avevano denunciato).
Questo dato, unito a elementi come l’omicidio senza movente, l’assenza di emozioni, il rito del seppellimento del coltello con quella motivazione bizzarra e incongrua rispetto alla situazione, l’anaffettività che porta a colpire “così”, senza un motivo particolare, costituiscono un quadro sindromico che rientra a pieno titolo nel gruppo delle schizofrenie. Il secondo delitto è stato compiuto da un diciassettenne, Riccardo, che non aveva mai apparentemente manifestato segni evidenti di malattia mentale né comportamenti tali da richiamare l’attenzione di chi gli stava accanto. I giornali riportano che il ragazzo, descritto come «un bravo ragazzo, che aiutava in casa», avrebbe inflitto 68 coltellate, la maggior parte delle quali al fratello minore. Durante l’interrogatorio dice: pensavo che «una coltellata sarebbe bastata», «era da giorni che volevo risolvere il mio malessere, ma non sapevo come». Inoltre racconta una sensazione di «estraneità».
L’assenza della psichiatria
Morando Morandini, i cento anni di un Maestro
A cento anni dalla nascita eventi e libri ricordano il grande critico cinematografico Morando Morandini. Questa sera, 3 ottobre, a Milano (ore 20 cinema Arlecchino in via San Pietro all’Orto) presentazione del libro 100 pezzi facili a cura di Luisa Morandini, già nelle librerie. Durante la serata ci sarà anche l’annuncio del Premio Morando Morandini al miglior libro di cinema italiano della stagione passata e in occasione dei 60 anni dall’uscita nelle sale, la proiezione del film Prima della rivoluzione di Bernardo Bertolucci con Morando Morandini attore. Left lo ricorda con il libro del mese (dal 4 ottobre) Morando Morandini critico di frontiera, con testi inediti, interviste e una selezione delle numerose recensioni pubblicate sulla rivista negli anni 2012, 2013 e 2014. E con una serie di ritratti fotografici di Francesca Fago. Qui pubblichiamo l’introduzione di Luisa Morandini.
Morando Morandini era nato a Milano, il 21 luglio 1924.
Orfano di madre e con padre prigioniero in India, comincia a lavorare prima dei 20 anni, mentre studia Lettere all’Università, come giornalista di cronaca all’Ordine, quotidiano cattolico di Como, dove riesce poi a realizzarsi, passando alla critica, come vice della latinista Bìce Scolari.
Da ragazzo aveva due passioni: i libri (soprattutto di letteratura angloamericana) e il cinema. Prima dei 30 anni riesce a far coincidere il suo lavoro con uno dei suoi due amori di ragazzo.
Entra a La Notte, dove redige con altri colleghi in una redazione assai vivace e stimolante la prima vera pagina degli spettacoli mai esistita su un quotidiano italiano.
Inventa le stelline per la critica ai film, ma anche i pallini per il successo di pubblico. Invenzione che l’ha poi perseguitato tutta la vita. Con una certa ironia del destino da La Notte, passa a Stasera (quotidiano che ebbe una vita sfortunatamente breve) e poi al quotidiano Il Giorno.
Negli anni scrive anche libri di cinema e monografie di registi, di poesia e qualche raro racconto. Indefesso appassionato del lavoro che faceva, nottambulo che lavorava quasi sempre fino alle prime ore del mattino – si autodefiniva «un pigro che lavora tantissimo» – mette in piedi con altri appassionati come lui diversi festival, collabora e fonda riviste specializzate.
«Fare il critico mi ha evitato di fare veramente il giornalista, mestiere che col passare degli anni sempre più detesto: tranne poche eccezioni, i giornalisti passano la prima metà della loro vita a scrivere di quello che non sanno, la seconda a tacere quello che sanno» ha detto con la sua tipica sagacia in un’intervista.
Quando sul finire degli anni Settanta – invasi dalle televisioni private – con Mario Nicolao ha deciso di mettere in piedi il settimanale Tele7 – la celebre piccola guida ai programmi tv ancora in vendita in edicola con successo tutt’oggi – mi ha proposto di collaborare alla creazione di un archivio di recensioni dei film che passavano sul piccolo schermo. Ho sempre avuto il sospetto che l’abbia fatto per tenermi lontana da una carriera di attrice che non condivideva. E così è cominciata una collaborazione tra noi che è poi durata una vita.
Nel 1998 abbiamo deciso di fare insieme, ogni anno, il Dizionario dei film con la casa editrice Zanichelli, impresa avventurosa e molto impegnativa. Abbiamo pubblicato 18 edizioni e io ho poi proseguito da sola – con un minuscolo gruppo di collaboratori – fino alla 27esima edizione, continuando la sua opera e cercando di trasmettere ad altri tutto quello che mi ha insegnato. Pur avendo un mio modo di scrivere, ho imparato a scrivere come lui, perché si è deciso fin dall’inizio di mantenere una unità stilistica nel nostro dizionario. Lavorare insieme è stato sfinente da una parte (la sua severità di giudizio era valida anche nei miei confronti, molto meno con i colleghi o eventuali giovani collaboratori): riuscire ad avere un plauso era tutt’altro che facile, l’invito a rileggere, riflettere, rifare, era continuo; e spesso l’assenza di commenti era da interpretare come un segnale di approvazione. Ma dall’altra parte è stata una scuola di professione e di vita unica, senza fondo e senza fine.
Pretendeva molto da sé stesso, ma anche dagli altri. La più grande soddisfazione che ho avuto è stata quando, ormai diversi anni fa, Morando ha ammesso di non saper riconoscere (sempre più spesso) le schede dei film scritte da lui dalle mie.
Ancora oggi, lavorando, rileggo quello che ha scritto e ogni volta mi colpiscono la capacità di sintesi (dono sempre più raro con il passare degli anni, quasi introvabile con l’invasione di internet, siti, blog, piattaforme e via dicendo), la scrittura elegante e colta, la sagacia, il rispetto che trapela per il lavoro degli altri (dei registi, degli autori, dell’intera troupe) ma anche per il lettore, la pacata ferocia con cui riusciva a volte, con poche parole, a stroncare un film. E sono numerosi i suoi colleghi contemporanei e successivi, a pensarla come me.
«È stato uno dei critici che ha aperto la strada a un rinnovamento culturale della professione. Ha imposto un modo nuovo di guardare i film. Mi ha insegnato a guardare i film con rispetto, anche quelli brutti, a dedicare la stessa attenzione passione intelligenza che si usa per i grandi capolavori» (Paolo Merenghetti).
«Basta leggere una recensione di Morando per accorgersi come le doti di un grande scrittore sono stornate e convogliate ai bisogni di un grande critico per raggiungere, istigare, informare, trovare un modo per rendere ogni volta l’esperienza del cinema un gesto di civiltà nel divertimento» (Silvio Danese).
Cosa posso aggiungere?
È stato il mio maestro, il mio giudice più severo, il mio capo, il mio collega.
Era mio padre.
In apertura: Morando Morandini, foto di Francesca Fago
Il libro di Left dal 4 ottobre per gli abbonati e da acquistare sul sito
Una lotta pacifica senza armi, solo con la forza della libera parola
Nella parola Repubblica, dal latino res publica, c’è dentro tutto: la Costituzione con la sua tavola di principi fondamentali e valori irrinunciabili, la divisione dei poteri (per evitare che uno sovrasti e schiacci l’altro e per assicurare così i diritti dei cittadini), le istituzioni democratiche e la dialettica politica, il popolo, i singoli cittadini e le loro variegate formazioni sociali e tanto altro ancora.
Le fondamenta sono antiche e solide, costituzionali appunto, dove “costituzionale” sta per costitutivo e strutturale.
La nostra bella Costituzione, però, per vivere ha bisogno di effettività: non può fare a meno che effettivi siano i diritti (e i doveri) scritti nella Carta, effettivi siano il loro rispetto, la loro garanzia, la loro promozione.
Una Costituzione democratica e liberale, come la nostra, sancisce i diritti fondamentali tra i quali vi è quello di riunirsi, “pacificamente e senz’armi”, per manifestare liberamente il proprio pensiero nell’agorà che è lo spazio pubblico, di tutti.
Che forza quella formula “pacificamente e senz’armi”: come a dire che il corpo e la voce di ogni cittadino possono stare nelle piazze per difendere ogni causa giusta, ogni alto ideale, qualsiasi proposta politica, per la polis appunto, che è ontologicamente plurale.
Nata sulle ceneri di un regime che negava quelle libertà fondamentali, la nostra Costituzione le proclama e le protegge.
E quando uno dei poteri – in questo caso, l’esecutivo cioè il governo – minaccia quelle libertà, un altro potere, in questo caso la magistratura (che la Costituzione ha il giusto pudore di definire “ordine” perché “potere” è per definizione forza regolata suscettibile di straripare), sollecitato dai cittadini e dalle formazioni sociali cui quel diritto fondamentale viene negato, interviene in difesa, ripristinando l’equilibrio costituzionale violato.
Dopo avere approvato, con la sua schiacciante maggioranza parlamentare, un disegno di legge “sicurezza” fascistoide e liberticida (che criminalizza persino la resistenza passiva e disarmata), lo stesso esecutivo pretende oggi di vietare una manifestazione (quella del 5 ottobre) sacrosanta indetta per chiedere il cessate il fuoco immediato a Gaza (e negli altri fronti di guerra inopinatamente e pericolosamente aperti da Israele), la difesa dei diritti umani, il diritto del popolo palestinese (come tutti gli altri popoli e nazioni) a difendere la propria terra dall’occupazione e quindi alla autodeterminazione, pace e giustizia per il popolo palestinese oggetto di un massacro genocida.
Chi manifesta, lo fa per difendere i diritti umani fondamentali e il diritto internazionale.
Chi vieta la manifestazione è lo stesso governo che ha fornito (e forse sta continuando a fornire) in violazione di una legge della Repubblica (la Legge 185 del 1990) armi ad un Paese (Israele) in guerra che sta commettendo crimini contro l’umanità in danno della popolazione civile.
Oltre 41.000 morti, il 65 % dei quali donne e bambini.
Per quale altra più nobile causa si dovrebbe manifestare se non per difendere la vita e il futuro dei bambini?
Un governo complice di genocidio (art. III lett. e) della Convenzione internazionale sulla prevenzione e la repressione del genocidio) vieta di manifestare contro il genocidio.
Ci si rende conto della gravità del momento?
E un Tribunale amministrativo regionale, nella persona di un magistrato singolo, presidente di sezione, avalla giuridicamente la sospensione di una libertà fondamentale in nome della “sicurezza”.
La questura ben avrebbe potuto, come prevede la legge, invece di vietare lo svolgimento della manifestazione, impartire prescrizioni: vietare al corteo alcuni luoghi sensibili e diffidare organizzatori e partecipanti dall’esposizione di simboli, scritte e slogan di contenuto illecito (come si dovrebbe fare per le manifestazioni neofasciste che si lasciano invece liberamente organizzare, con tanto di “innocui” – secondo recente giurisprudenza penale – saluti romani e chiamate del presente).
E – come la digos sa fare benissimo – ben avrebbe potuto la questura di Roma limitarsi a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, raccogliendo eventuali prove di commissione di reati (come la violazione della legge Mancino, in caso di propalazioni antisemite o di incitamento all’odio razziale di singoli manifestanti) per poi farne doveroso rapporto all’autorità giudiziaria.
Invece no: si sospende, col preoccupante beneplacito giurisdizionale, una libertà costituzionale e costitutiva della Repubblica. Come si può rimanere indifferenti a tutto questo?
Quando anche gli eterni prudenti e pavidi conformisti si sveglie dal torpore, sarà troppo tardi. Qui e ora, comunque la pensiate sul genocidio di Gaza (che rappresenta la pagina più nera dal dopoguerra di crisi del diritto internazionale umanitario), se avete a cuore la Repubblica, dovete difenderla, manifestando e manifestandovi.
Quando si trattò di difendere la libertà dai nazifascisti mio nonno Libero abbracciò con coraggio la lotta partigiana, a rischio della propria vita. E fu la Costituzione, fu la democrazia, fu la Repubblica: quella Repubblica che sta scricchiolando adesso sotto lo stivale chiodato del neofascismo istituzionale, reazionario e liberticida e che sta vacillando perché tante, troppe mani non la sorreggono più e si nascondono, quatte e pavide, dietro schiene sempre più piegate. Ci si rende conto della gravità del momento?
Io me ne sto rendendo conto e per questo sarò in piazza a Roma il 5 ottobre a manifestare, pacificamente e senz’armi, se non quelle della parola libera e critica e del corpo, a riempire uno spazio pubblico che il potere vorrebbe restasse silente e vuoto.
L’autore: Andrea Maestri è avvocato e attivista per i diritti umani
Foto di Renato Ferrantini
Come è possibile?
«Quando siamo davanti all’orrore cerchiamo di rassicurarci etichettando tutto come malattia mentale, ma la violenza non è il prodotto della malattia mentale, la violenza nasce da situazioni di marginalità, è la conseguenza di non saper controllare gli impulsi. Si uccide sempre per rabbia, per un demone che si porta dentro». Così la psichiatra Emi Bondi, presidente uscente della Società di psichiatria, intervistata dal Corriere della Sera l’1 settembre dopo il femminicidio di Sharon Verzeni. Come può la comunità scientifica accettare queste affermazioni religiose senza ribellarsi? Come può non farsi sentire rispetto a queste e alle affermazioni di Paolo Crepet che dice che solo l’Onnipotente potrebbe capire l’accaduto a Paderno dove un diciassettenne ha sterminato la famiglia a partire dal fratellino di 12 anni?
Se Crepet invoca l’onnipotente, Emi Bondi ha scomodato il diavolo che avrebbe agito tramite Sangare. Sono tutte affermazioni, purtroppo letterali, facilmente riscontrabili sui maggiori giornali.
Le lancette del tempo sembrano tornate indietro di secoli. Lo denunciammo già diversi anni fa su queste pagine quando scoprimmo che un’associazione di psichiatri e psicoterapeuti cattolici si affidava alla collaborazione di esorcisti per affrontare i casi più complicati perché oltre certi livelli di malattia ci sarebbe – a loro dire – la possessione demoniaca.
E che fine ha fatto il giornalismo, specie sul servizio pubblico, che avrebbe dovuto sottolineare che per fortuna sono molto rari i casi di giovani e adolescenti che uccidono lucidamente? Il caso di Omar e Erika (vent’anni fa) e quelli di Paderno, di Traversetolo e di Viadana sono cari rari ma vanno diagnosticati correttamente.
Gli psichiatri e i giuristi che intervengono su questo numero di Left parlano di una patologia estrema, di perdita totale degli affetti, di “deserto interiore”, di psicosi. Il malessere degli adolescenti, che pure va attenzionato moltissimo, specie dopo il Covid, esige una risposta che non arriva dalla scuola e dalle istituzioni, ma è altra cosa rispetto ai casi estremi appena citati e che hanno scosso profondamente l’opinione pubblica, che pure – giustamente – esige una risposta concreta sul piano scientifico.
E qui torniamo alla questione iniziale, come è possibile che nessuno nell’ambito della rete sociale intorno a Giulia Cecchettin abbia colto un segnale di pericolo nei 300 messaggi al giorno (trecento!) che Turetta le mandava non certo per amore ma solo per controllarla e annichilirla? Come è possibile che a livello istituzionale nessuno sia intervenuto in tempo per fermare Sangare dopo le minacce di morte – più volte denunciate – alla madre e alla sorella? Sangare, poi, ha ucciso Sharon Verzeni, “scelta” proprio perché donna, dopo aver risparmiato dei ragazzini incontrati sulla sua strada. Come è possibile che nessuno avesse visto oltre l’immagine esteriore di Chiara, efficiente baby sitter, venditrice a comando, studentessa modello e catechista? Indottrinata da un pensiero religioso che non distingue l’aborto da un omicidio, ha creduto che feto e bambino fossero la stessa cosa arrivando così a uccidere due neonati invece di abortire come consente la legge 194? Dove erano i familiari e i suoi affetti che ora affermano di non aver saputo nulla? La rete sociale ha fallito? Ce lo dobbiamo chiedere collettivamente. È soprattutto dobbiamo interpellare psichiatri con una valida formazione scientifica per capire come si possa fare prevenzione.
Dal chiodo alla trave di Salvini
Ci sono diversi modi per reagire a una crisi e affrontare un problema che ha messo in ginocchio per una giornata intera i viaggiatori di un’intera nazione.
Si potrebbe, ad esempio, aprire una riflessione sincera sul sistema dei trasporti che è sempre a un centimetro dal collasso, lasciando ai viaggiatori la sensazione che l’arrivo a destinazione sia dovuto più alla sorte che alla programmazione.
Si potrebbe, ad esempio, discutere del Pnrr che avrebbe dovuto rivoluzionare la nostra qualità della vita – treni inclusi – e invece da queste parti non se ne ha nemmeno la sensazione.
Si potrebbe discutere con coraggio delle strane priorità di un Paese che non riesce a garantire un viaggio sereno da Milano a Roma e intanto progetta un mastodontico ponte per accarezzare l’ego di un ministro che vorrebbe lasciare anche lui la sua piramide ai posteri.
Oppure, pensandoci bene, un ministro potrebbe esercitarsi nella virtù ormai scomparsa dell’assunzione delle proprie responsabilità, come accade per chiunque abbia un lavoro di ogni grado, in ogni mansione, in ogni ruolo.
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini invece ieri ha sbuffato, era risentito perché ha dovuto abbandonare la sua palestrina dove sta festeggiando la festa dei nonni. Si è presentato davanti alle telecamere con quella faccia da ministro per caso e ha spiegato che il collasso ferroviario era dovuto a un chiodo.
Il chiodo di Salvini è come il diario mangiato dal cane quando eravamo ragazzini. C’è una non trascurabile differenza: il ministro non se l’è presa con il cane ma con un poveraccio sotto pagato che ha offerto alla bava della piazza.
Buon giovedì.
Servire la patria nei campi. Il piano di Lollobrigida per i giovani
Le battute sulla mussoliniana “battaglia del grano” sono scontate, inevitabili. Succede che il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, lanci la sperimentazione di quello che viene definito come il “Servizio civile agricolo”. Spiega Lollobrigida che «dal 2 ottobre partirà il Servizio civile in agricoltura con la manifestazione d’interesse aperta alle aziende. Per la prima volta, i giovani potranno servire la patria con una attività di valore agricolo. Sarà un anno a spese dello Stato che vuole valorizzare questa attività».
Un anno a spese dello Stato. Domanda: in che termini? A fare i conti è la Flai-Cgil, federazione di categoria dei lavoratori dell’agro-industria. In un comunicato del 27 settembre, il sindacato analizza così la proposta: «si vuol far lavorare nei campi ragazzi e ragazze di 18-20 anni a 500 euro al mese, fatti due conti a 3 euro l’ora. Non può essere certo questa la politica che aiuta a incentivare l’occupazione giovanile. Piuttosto sembra un tentativo di legalizzare il sottosalario e pensare di risolvere in questo modo alcuni problemi strutturali, in un settore come quello agricolo che vede le aree periferiche sempre più in difficoltà: non ci convince».
Davide Fiatti, della segreteria nazionale della Flai osserva: «non dimentichiamo che stiamo parlando di un settore dove le norme sul mercato del lavoro permettono già oggi un’estrema flessibilità. Lavorare non è servire la patria, è avere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, come sancisce l’articolo 36 della nostra Costituzione».
Ancora, «abbiamo bisogno di mettere in campo ben altre politiche per affrontare questioni annose, a partire dallo sfruttamento e dal caporalato che continuano a interessare i campi e i terreni agricoli della penisola da Nord a Sud, nonostante ci siamo leggi di contrasto come la 199 del 2016 che però vengono applicate poco e male. Il combinato disposto fra la legge Bossi-Fini e il decreto flussi, così come interpretato da questo governo, crea un’autentica fabbrica di invisibili, facili prede della malavita organizzata e di imprenditori senza scrupoli».
Non c’è bisogno di aggiungere molto. Gli enormi problemi del nostro settore agroalimentare richiedono interventi strutturali che vanno ben oltre un breve “servizio alla patria” mal pagato e da vedere come verrebbe organizzato. Nel Paese nel quale Satnam Singh è morto nei campi dell’Agro Pontino, pochi mesi fa, per l’indicibile atto di barbarie di uno sfruttatore che può essere definito un aguzzino, la civiltà non si afferma mandando dei ragazzini a “servire” in campagna.
Se vogliamo servire la Patria repubblicana, si devono affermare condizioni di lavoro chiare, legali, retribuite correttamente, sicure. Così come prescrive la Costituzione.
L’autore:Sindacalista e già ministro del lavoro Cesare Damiano è presidente di Lavoro & Welfare
La favola nera del sovranismo: Meloni corteggia il lupo di Wall Street
Ieri a Palazzo Chigi lo statunitense Larry Fink è stato ricevuto con tutti gli onori. Di fronte aveva la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una vita politica spesa a ventilare immaginifiche battaglie contro orrendi poteri forti.
Solo che Fink è presidente e amministratore delegato del colosso statunitense della finanza BlackRock, un potere forte forte davvero. In pancia ha dieci mila miliardi di dollari (il Pil di Giappone e Germania, sommati) e siede nei consigli di amministrazione delle più importanti aziende occidentali. Amano molto le armi, quelli di BlackRock, e mica per niente sono azionisti delle più importanti industrie belliche come Lockheed Martin a Raytheon Technologies e Northrop Grumman e ovviamente l’italiana Leonardo di cui detiene il 3%.
Ci si aspetterebbe che Meloni avesse voluto incontrare il “cattivo” per rivendicare il proprio sovranismo e per chiederli di tenere giù quelle manacce dai beni della patria e invece è accaduto esattamente il contrario. Come una piazzista ha aperto il campionario dei gioielli italiani e ha offerto ai poteri forti Autostrade e qualche altra occasione dell’Italia in saldo.
Fink avrà osservato con attenzione. Blackrock è azionista di Snam (poco meno del 5% cumulativo), di Terna (5%), di Saipem (0,6%), di Prysmian (5%), di Stm (0,6%), di Tenaris (1,8%), di Italgas (3,7%) ed è primo azioni sta di Unicredit con il 7%.
Scene da bancarelle dentro il palazzo del governo. Il sovranismo è così, una postura che si può comodamente smentire.
Buon mercoledì.
Ddl 1660, è solo repressione. Protestare per difendere il proprio lavoro ora diventa un reato
Francesca è una donna di 63 anni. Ha lavorato per 30 anni, guadagnando ogni mese lo stipendio che per circa 20 anni le ha permesso di pagare un affitto vicino ai mille euro al mese al Fondo Cicerone, riconducibile al grande proprietario immobiliare romano Caltagirone.
Da quando è stata licenziata, ha avuto difficoltà a sostenere le spese di affitto. Nell’ultimo anno e mezzo non ce l’ha fatta più. La proprietà ha avviato una procedura di sfratto, malgrado i vari tentativi di conciliazione che pure erano arrivati da Francesca e da Asia-Usb, il sindacato di inquilini e abitanti che ha seguito la vicenda. E malgrado la stessa società immobiliare già possieda decine e decine di appartamenti sfitti nella stessa zona.
Il 19 settembre, con un gran spiegamento di forze di polizia (costo a carico della collettività), Francesca, che si era incatenata al balcone di casa, è stata sfrattata. Buttata per strada senza alcuna soluzione alternativa. Costretta a dormire in auto.
Un passo indietro. Maggio 2019. La multinazionale statunitense Whirlpool annuncia da un giorno all’altro la chiusura dello stabilimento di Napoli, con conseguente licenziamento dei 420 operai.
I lavoratori e le lavoratrici entrano immediatamente in sciopero e tra le prime forme di protesta decidono di scendere in strada e bloccare il vicino svincolo autostradale. Lo rifaranno più volte nel corso degli anni, fino a una soluzione positiva della vertenza, con l’arrivo di un nuovo privato che ha preso l’impegno di riconvertire la produzione, mantenendo tutta la forza lavoro rimasta.
La lotta è servita a difendere i posti di lavoro contro la volontà speculativa della multinazionale.
Francesca e i 420 operai della Whirlpool non rispondono all’identikit dei criminali. Eppure, per il governo Meloni, lo sono. Così dice il Disegno di Legge (Ddl) 1660, che ha come firmatari il ministro dell’Interno Piantedosi, quello della Difesa (Guerra) Crosetto e quello della Giustizia Nordio.
Il 18 settembre il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 162 sì, 91 no e 3 astenuti. Prima di diventare legge e poter esercitare effetti concreti, dovrà passare al Senato, dove si annuncia un altro “sì” scontato.
La norma introduce ben 24 tra nuovi reati e aggravanti. Cioè, in sintesi, più carcere e pene più pesanti. Anche per chi resiste a uno sfratto – come Francesca – e per chi protesta con lo strumento del blocco stradale – come gli ex operai Whirlpool. Fino a oggi per queste fattispecie si incorre al massimo in illeciti amministrativi; d’ora in poi si passerà al penale. Si trasforma chi resiste e chi lotta in un criminale, per l’appunto.
Il Ddl 1660 viene comunemente definito “decreto sicurezza”, tanto dal potere mediatico quanto da quello politico. Così facendo lo si inserisce in un quadro che vorrebbe l’ultradestra battersi per la “sicurezza” dei cittadini e delle cittadine.
Avallare l’uso di questo nome, come sta facendo anche l’opposizione parlamentare, significa un cedimento alla cornice ideologica propria dell’ultadestra.
Meglio sarebbe definirlo sulla base della sua vera natura: “Ddl repressione”, ad esempio. O, anche, “Ddl Rete 4”, visto che la maggior parte dei nuovi reati e delle nuove pene sono il punto di caduta normativo di anni di dibattiti e talk show promossi dal canale della berlusconiana Mediaset.
Prima è venuta la battaglia delle idee, poi questo nuovo quadro normativo con cui si offrono risposte a quei temi – e alla particolare lettura che di essi è stata fatta – imposti nell’agenda del Paese dal potere mediatico dell’ultradestra.
Alla mancanza di un tetto sicuro sulla testa di troppi cittadini, l’ultradestra mediatica da anni risponde puntando il dito contro le occupazioni di abitazioni sfitte da parte dei movimenti di lotta per la casa.
Per l’ultradestra il problema non è l’assenza di case popolari (in Italia sono il 4% del totale, contro il 17% della Francia, il 18% del Regno Unito e addirittura il 35% dell’Olanda), né le più di 70mila vuote in tutto il Paese né gli affitti alle stelle, soprattutto nelle grandi città (in media +10,2% tra 2022 e 2023, ma +14,2% nelle 14 città metropolitane); se troppi cittadini non hanno una casa è a causa di chi occupa immobili sfitti, magari da decenni.
Una spiegazione contro ogni logica, anche numerica, e che pure si è diffusa in ampie fette di popolazione.
Così che oggi l’articolo 8 del Ddl 1660 può indicare il nemico in chi occupa una casa sfitta e punirlo con il carcere da 2 a 7 anni. Così facendo punisce anche chi «impedisce il rientro nell’immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente», cioè anche quegli inquilini che non ce la fanno più a pagare l’affitto, magari perché licenziati (come la sig.ra Francesca) o perché il proprietario ha deciso di raddoppiare l’importo o perché vuole destinarlo ai più lucrativi turisti. E prevedendo il carcere pure per chi in maniera solidale, partecipa ad esempio a un picchetto antisfratto.
Una norma, l’articolo 8 del Ddl 1660, che difende gli interessi dei proprietari, a partire dai grandi, mentre nulla offre a chi è in cerca di una risposta ai propri bisogni abitativi.
Il blocco stradale o ferroviario passa da illecito amministrativo a reato penale: si rischieranno da 6 mesi a 2 anni di carcere se commesso da più persone (art. 11). L’ultradestra sostiene si tratti di un reato per colpire gli attivisti ambientalisti di Ultima Generazione che negli ultimi anni hanno organizzato diversi blocchi stradali per sensibilizzare sulle politiche che ci stanno conducendo sul baratro della distruzione del pianeta. Proteste pacifiche individuate come nemico da eliminare. Bizzarro che il Ddl 1660 stia per diventare legge contro gli attivisti ambientalisti proprio mentre una nuova alluvione ha colpito la Romagna già messa in ginocchio dall’alluvione del maggio 2023.
La narrazione dell’ultradestra al governo è che la norma serve a dare “sicurezza” ai lavoratori che rimangono imbottigliati con le proprie auto dagli attivisti mentre stanno andando al lavoro.
Potenzialmente, però, a esser colpiti dalla norma potranno essere proprio quei lavoratori che difendono il proprio posto di lavoro contro le decisioni di multinazionali e grandi imprese di chiudere e magari spostarsi altrove.
O, ancora, gli studenti e le studentesse che fermeranno il traffico davanti alla scuola per protestare contro gli edifici fatiscenti o per l’ennesima morte di uno studente in alternanza-scuola lavoro, il sistema che prevede l’obbligo per gli alunni di prestare servizio gratuitamente presso aziende al fine di conseguire la maturità.
Non sono gli unici soggetti colpiti se provano ad affermare un proprio diritto con l’arma della protesta. Per i cittadini e i movimenti che cercano di impedire le grandi opere inutili alla cittadinanza, ma assai utili alle imprese, il “Ddl repressione” inserisce nell’ordinamento penale una aggravante che permette di punire i “colpevoli di protesta” col carcere fino a 20 anni.
Una norma che sembra scritta avendo in mente le manifestazioni di protesta contro il Ponte sullo Stretto, una mega-opera di cui si parla da decenni, destinando centinaia di milioni di euro a consulenti ed “esperti”, ma che le popolazioni di Sicilia e Calabria rifiutano, sottolineando ben altre priorità: misure contro la siccità, infrastrutture ferroviarie, ecc..
Anni di carcere vengono “promessi” anche a chi in carcere o nei Cpr (Centri per il rimpatrio dei migranti) si ribella alle durissime condizioni imposte da un sistema che costantemente disumanizza qualunque soggetto rimanga imbrigliato in esso (art. 18 e 19).
In Italia da anni diverse associazioni denunciano il sovraffollamento carcerario (che è costato all’Italia anche condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo) e situazioni che superano i confini della vivibilità. Non è un caso se continua ad aumentare il numero dei detenuti suicidi: 72 dall’inizio del 2024.
Come affronta il governo questo tema? Non solo con la promessa di più persone in carcere, ma soprattutto col divieto assoluto di protesta per chi è in detenzione. Il “Ddl Repressione” introduce l’articolo 415-bis che punisce la “rivolta all’interno di un istituto penitenziario” con la reclusione da 2 a 8 anni (e in alcuni casi fino a 20 anni).
Perfino la “resistenza passiva” viene trasformata in un crimine, punibile fino a 4 anni di carcere. Con questa norma sbatterebbero in galera anche le suffragette, Ghandi o Martin Luther King!
Sempre a tema carcere, il Ddl 1660 presenta il pugno duro finanche contro le detenute madri (art. 12): se fino a oggi c’era il trasferimento obbligatorio dal carcere per le madri con figli fino a un anno e per le donne incinte, d’ora in poi sarà a discrezione del giudice. Con la possibilità concreta, dunque, che il carcere si affolli anche di neonati. Se questa è la tutela della vita di madri e bambini che ha in mente l’ultradestra…
Per contro, il governo assegna più poteri, più protezione (art. 14 e 15), più libertà alle forze di polizia. Di fronte a movimenti che da anni rivendicano l’istituzione di codici identificativi per le forze dell’ordine, così da poter individuare eventuali responsabili di abusi in divisa, il governo risponde con la facoltà per le forze dell’ordine di detenere una seconda arma personale al di fuori di quella di ordinanza e al di fuori del servizio (art. 20), nonché l’autorizzazione a installare bodycam per i corpi di polizia, così da tutelare esclusivamente loro e non chi gli si trova di fronte.
La creatività dell’ultradestra si ferma quando i reati da inventare andrebbero a colpire imprenditori e colletti bianchi. Il ministro Nordio ha più volte ribadito la propria contrarietà all’introduzione del reato di “omicidio sul lavoro”, che riguarderebbe quegli imprenditori che con la propria condotta attiva o negligente dovessero causare “lesioni gravi e gravissime” o addirittura la morte di un proprio dipendente. A febbraio aveva affermato che «il reato di omicidio sul lavoro non è un deterrente sufficiente, sono contrario».
Allo stesso modo, il 17 settembre, il giorno precedente l’approvazione alla Camera del Ddl 1660, l’Ispettorato nazionale del lavoro, d’accordo con il Ministero del Lavoro, diramava una circolare con cui ben 39 violazioni degli imprenditori divenivano non più sanzionabili con multe monetarie, bensì con mere diffide e la semplice ingiunzione a mettersi in regola.
Secondo l’Osservatorio repressione, col Ddl 1660 entriamo in quello che viene definito «uno stato di polizia». Per di più, aggiunge l’associazione da anni impegnata nella battaglia a difesa delle libertà individuali e collettive e contro gli abusi in divisa, che il tutto avviene «col silenzio complice delle ‘opposizioni parlamentari’, le quali al di là di un voto contrario puramente di bandiera non hanno mosso un dito per contrastare realmente le nuove leggi ‘fascistissime’ […]. Anzi: su circa 160 parlamentari, al momento del voto alla Camera l’‘opposizione’ ne aveva in aula soltanto 91!!! Non solo: […] Pd e Movimento Cinque Stelle hanno presentato alcuni ordini del giorno (recepiti dal governo) che impegnavano quest’ultimo a incrementare la spesa per assumere nuovi agenti di polizia e guardie penitenziarie: l’ennesima riprova di come […] nella sostanza siano tutti uniti nella direzione di un inasprimento dei dispositivi repressivi, funzionale alla guerra e all’economia di guerra».
Il “Ddl Repressione” non è solo una stretta autoritaria del governo dell’ultradestra.
È un manifesto politico. Indica il nemico in specifiche categorie, così da direzionare la rabbia e la frustrazione che sempre più serpeggiano in ampie fasce della popolazione lontane dai reali responsabili.
Criminalizza la cultura della solidarietà, la partecipazione ai momenti di lotta che riguardano persone in difficoltà lavorativa o abitativa e promuovendo, al contempo, uno stile di vita fondato sul “mi faccio i fatti miei”, cioè sul totale isolamento e automizzazione.
Criminalizza il conflitto in sé e così facendo costituisce un attacco non solo alle libertà democratiche ma anche – e soprattutto – ai diritti sociali.
Perché i diritti non esistono semplicemente perché scritti su carta. Vanno esercitati. Difesi e allargati. Il governo dell’ultradestra formalmente li mantiene intatti. Tuttavia, trasforma in reato gli strumenti necessari alla concretizzazione di quegli stessi diritti, i mezzi necessari a farli scendere dai cieli dell’astrazione fin qui sulla terra della vita quotidiana delle classi popolari.
Questo articolo di Giuliano Granato (portavoce di Pap) è pubblicato in collaborazione con Canal Red, fondato e diretto da Pablo Iglesias
Nella foto: una protesta dei lavoratori della ex Whirlpool a Napoli prima della conclusione positiva della loro vertenza
Il divano della vergogna: spettatori inerti di fronte all’apocalisse
Quando ci chiederanno di questo tempo – perché ce lo chiederanno, eccome – in cui il nichilismo bellico ha inondato il sentimento pubblico non avremo grandi risposte.
Ci accuseranno – perché ci accuseranno, eccome – di avere assistito a una guerra mondiale alle porte dei nostri appartamenti e noi seduti sul divano ad osservare un criminale di guerra che si mangia i Paesi vicini appoggiato dalla prima potenza al mondo guidata da un presidente – Joe Biden – ritenuto inadatto alla ricandidatura.
Ci chiederanno come abbiamo potuto ritenere che la legittima difesa possa declinarsi nell’annientamento di un intero popolo, a Gaza. Ci chiederanno come politica e stampa possano avere definito “chirurgico” una caccia ai terroristi che ha spianato scuole, ospedali e sostentamenti vitali.
Ci chiederanno come abbiamo fatto a rimanere inerti di fronte all’invasione di un Paese, il Libano, mentre le macerie di Gaza sono ancora calde di corpi. Ci chiederanno se davvero abbiamo ritenuto credibile che si possa invadere “ma poco” un Paese foderandolo di bombe.
Quando il tempo ristabilirà le responsabilità del criminale di guerra Benjamin Netanyahu, verrà giudicato dalla storia (e non dal flebile soffio dei tribunali e degli organi internazionali), verranno a galla i suoi complici internazionali che per calcolo politico o per vigliaccheria gli hanno coperto le spalle.
Quando si poserà la furia bellicista – ci vorranno anni – ci si renderà conto che la frase «eh, ma il 7 ottobre» o la favola della «liberazione degli ostaggi» (ultimo dei pensieri del premier israeliano) suoneranno come una tragica barzelletta.
Buon martedì.
Nella foto: bombardamenti israeliani nel sud del Libano, 20 settembre 2024 (wikipedia)
Quelle parole violente del Papa contro le donne
La violenza verbale di Bergoglio ancora una volta ha superato il limite. Il Monarca assoluto dello Stato extracomunitario vaticano che, per disgrazia geografica, si trova su territorio italiano, si è permesso (di nuovo) definire assassine le donne che abortiscono e sicari i medici che danno loro assistenza sanitaria.
Il Monarca non ignora che l’aborto sia un diritto umano in tutti i contesti civilizzati, sa perfettamente che l’autodeterminazione sessuale della donna è la declinazione più alta della Libertà di coscienza, così come definita e sancita in tutte le Convenzioni internazionali sui diritti umani, a partire dalla Convenzione di Nizza, ma non ne ha minimamente rispetto e anzi, il suo disprezzo per il genere femminile si concretizza tutte le volte che parla di aborto senza riguardo per le donne che vogliono decidere del loro corpo.
Il Monarca dittatoriale vaticano sa che il suo potere si fonda sul patriarcato che ha come cardine ideologico fondamentale la criminalizzazione dell’autodeterminazione sessuale femminile.
A coloro che rivendicano il diritto di Bergoglio di esprimersi contro l’aborto, occorre puntualizzare che le accuse del Monarca teocratico contro le donne che abortiscono liberamente non sono mere indicazioni teologiche o di indirizzo spirituale, pronunciate nei luoghi dove si esercita il culto, quanto, piuttosto, sono precise posizioni politiche con le quali si dà un indirizzo pubblico per radicare il fondamentalismo nella società civile.
La posizione politica di Bergoglio in effetti non è dissimile da tutti i fondamentalisti del pianeta, prevalentemente abramitici.
Attualmente è lui il Capo di Stato maggiormente responsabile della politica antiabortista, in perfetta continuità con tutti i dittatori vaticani che lo hanno preceduto.
E dunque politicamente non si può non vedere che è lui il responsabile morale della mancata assistenza sanitaria negli ospedali italiani, è lui il responsabile morale della presenza dei fondamentalisti cattolici nelle cosiddette sale d’ascolto, luoghi dove con i soldi pubblici si fa terrorismo psicologico contro le donne che devono abortire.
L’ideologia fondamentalista cattolica insiste con l’affermare che l’embrione sia “vita”, ebbene, occorre ribadire, ove ce ne fosse bisogno, che l’ovulo non è vita, lo spermatozoo non è vita, ovulo e spermatozoo accidentalmente uniti non sono vita, sono semplicemente un grumo di cellule vitali e definirli “vita umana” è un artificio semantico necessario per dare supporto alla misoginia oscurantista.
Le donne che non vogliono abortire sono libere di non abortire, le donne che vogliono abortire devono essere libere di abortire, perché l’autodeterminazione riproduttiva delle donne si concretizza nella scelta, qualunque essa sia, e spingere le donne ad abortire se non vogliono, oppure non consentire loro di abortire se vogliono farlo, in entrambi i casi è una interferenza qualificabile come un crimine contro un diritto umano.
Per la Chiesa vale più un grumo di cellule che una donna che sente l’esigenza di autodeterminarsi, e ne è conferma la trasbordante letteratura della cosiddetta patristica, da san Tommaso a sant’Agostino, da Tertulliano a san Paolo, i quali costituiscono il fulcro ideologico della misoginia cattolica, di cui Bergoglio è convinto interprete.
Se il disprezzo dei diritti umani, quale è il diritto alla salute, è un crimine contro l’umanità, puntare il dito contro i medici che offrono assistenza sanitaria alle donne che decidono di interrompere la gravidanza, è un pensiero criminale, non c’è altra definizione.
I medici antiabortisti, pur di assecondare i pruriti ginofobici del clero, dai quali molto spesso dipende la loro carriera, si rifiutano di eliminare un grumo di cellule indesiderato, sovente mettendo a rischio la vita delle donne. Le donne patriarcali che si dichiarano antifemministe e che si schierano contro l’aborto sono donne che accettano di essere considerate inferiori ed è imbarazzante vederle mentre difendono il sistema che le opprime non avendo consapevolezza dell’oppressione.
La teocrazia è la più subdola delle dittature, si nasconde dietro finti governi e finti Parlamenti, mascherando con dogmi religiosi i diktat politici, sicché le istituzioni rappresentative diventano il paravento di un potere teocratico che si muove nell’ombra mantenendo le società nella inciviltà più deprimente.
La politica antiabortista del cattolicesimo fondamentalista, di cui il Monarca Bergoglio è il massimo esponente, è una politica disastrosa e sta mettendo a rischio la salute sessuale e riproduttiva delle donne italiane.
Non è comprensibile nemmeno la posizione di quei politici italiani di sinistra che se da un lato rivendicano posizioni di difesa dei diritti sessuali e riproduttivi, nel contempo sbavano per le posizioni di Bergoglio su tematiche diverse.
Non si possono estrapolare alcune posizione e poi tacere sulle altre, i capi di Stato come Bergoglio devono essere valutati nel messaggio complessivo che esprimono, e non in riferimento ad una singola questione che in un dato momento, opportunisticamente, potrebbe tornare utile.
Recentemente la Francia ha inserito l’aborto tra i diritti fondamentali tutelati dalla costituzione francese, ma per loro è stato facile raggiungere questo traguardo, sono circa 650 anni che hanno cacciato il Papa dal suolo francese.
l’autrice: Carla Corsetti è avvocata e segretaria di Democrazia atea
in foto Papa Francesco apre la porta santa, inaugurando il Giubileo della misericordia 2015. Foto di Centro Televisivo Vaticano, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95373332