Philadelphia – Una prova di forza. Difficile definire in maniera diversa il comizio di chiusura della campagna di Hillary Clinton nella città della Pennsylvania che con i suoi suburbs potrebbe essere la chiave per aprire le porte della Casa Bianca. Migliaia e migliaia di persone hanno fatto file di ore per entrare nell’Independence mall, parco che raccoglie musei e siti storici per la rivoluzione e la nascita degli Stati Uniti per esserci e salutare l’ultimo comizio di Barack Obama da presidente. E a tributare un’ovazione incredibile a Michelle, figura cruciale di questa campagna elettorale e personaggio politico più popolare d’America. Migliaia per rispondere alle battute di Donald Trump, che ai suoi comizi spiega sempre che da Clinton vanno quattro gatti, mentre lui riempie gli stadi.

La folla era mista come i discorsi del presidente sulla diversità che arricchisce il Paese, e come la coalizione democratica che ha fatto vincere al partito di Hillary Clinton due elezioni presidenziali consecutive. Bianchi e neri, giovani e vecchi, asiatici e ispanici – soprattutto bianchi e neri, a Philadelphia. Una presenza massiccia, da sottolineare è quella degli hard hats for Hillary, i caschi da lavoro per Hillary: felpone pesanti col cappuccio e la sigla della loro cellula sindacale, camicioni a scacchi, scarpe da lavoro, pance di birra. Tutti, proprio come ve li immaginate. Una presenza probabilmente voluta dal partito, per mostrare che sì, i democratici vorrebbero proprio tornare a essere quel partito dei lavoratori bianchi che erano una delle gambe della coalizione del New Deal di Roosevelt. Con il problema che il mondo è un po’ cambiato.
Sul palco, prima di Hillary, nell’ordine: Jon Bon Jovi, che canta tre canzoni legge la lettera di un operaio repubblicano che non può proprio votare Trump e se na va dicendo: «Philadelphia, domani non mi tradire». Poi Bruce Springsteen, primo boato della serata. Il cantore dell’epopea del lavoro americano in decadenza canta Thunder road e una Dancing in the dark in versione ballata straziante. E poi, quasi in versi spiega perché la gente deve andare a votare. Sia lui che Jon Bon Jovi sono eroi per i lavoratori della costa est.

Chelsea e Bill Clinton a svolgere un ruolo minore, da presentatori della coppia presidenziale. Michelle entra tra le urla e fa, come tutti gli altri nella serata, un discorso pacato e un po’ emozionato. «Sono emozionata per due motivi, domani dobbiamo fare la storia eleggendo una donna e perché questa è l’ultima cosa importante che faccio per questo Paese» – la gente grida “Nooo” e molti ritengono che un seggio al Senato sia il prossimo passo, ma due anni sono lunghi. Anche l’attacco a Trump è delicato: «Abbiamo bisogno di un leader che veda la diversità come una ricchezza e non come una minaccia, un leader che non veda in noi ricchi e poveri, ma gente che lavora sodo». Retorica elettorale, certo, ma efficace come poche.
Poi una tirata sull’importanza di andare a votare, che è il paradosso degli ultimi giorni di campagne elettorali: tutto dipende per i democratici non da quanti voti prendono, ma da quanti potenziali loro elettori portano ai seggi. E infine l’introduzione, anche qui «per l’ultima volta da presidente, un presidente che ha lottato contro una corrente contraria e che ha sempre volato alto quando gli altri volavano basso».
Anche Barack Obama viene accolto da un boato, ma quello di Michelle è più caldo.«Otto anni fa, ho chiesto a tutti voi di unirvi a me in un viaggio improbabile. Abbiamo deciso non solo di cambiare le politiche, ma di ricostruire un’economia affinché ciascuno avesse una possibilità di successo, di riformare Washington in modo da rendere le vostre voci più potenti dei lobbisti. Abbiamo deciso di mantenere l’America sicura e forte non solo con la forza delle nostre braccia e lo straordinario valore delle nostre truppe, ma con la forza dei nostri ideali, per dare forma un’America che cambia in modo che ognuno appartiene e ognuno ha una parte, ognuno ha una responsabilità». Va bene, il quadro non è così roseo ma molte cose Obama le ha fatte – e le elenca – e non vuole che vendano buttate via. Per questo, spiega, mi sono speso tanto in questa campagna. Per evitare di consegnare il Paese a Trump: «I manager della sua campagna gli hanno tolto le password dell’account di twitter e noi vogliamo consegnargli i codici nucleari?» scherza.

In una serata di messaggi positivi, Obama è il più duro con Trump: «Chi vede le donne come oggetti, le minoranze e gli immigrati come inferiori, altre fedi come antiamericane, non può guidare questo variegato, dinamico Paese. Questo dovrebbe darvi una ragione sufficiente per votare domani. Ma non c’è bisogno solo di votare contro qualcuno, avete qualcuno straordinario da votare». Non sappiamo se ci creda davvero, in parte sì. Ma è un buon passaggio di testimone.

Hillary sale sul palco, abbraccia, ringrazia e dopo aver raccontato la storia di Khazir Khan, il padre del marine musulmano morto in combattimento, chiede alla folla: «Se credete che tutti i nostri figli dovrebbero avere buone scuole e buoni insegnanti a prescindere dalla strada dove crescono allora dovete votare. Se credete in un college più accessibile, votate. Se credete che dobbiamo riformare il nostro sistema di giustizia penale in modo che ognuno di noi rispetti la legge, e ognuno sia rispettato dalla legge, votate. Se credete che dobbiamo proteggere i nostri figli e passare riforme di buon senso sulle armi, votate. Se credete che dobbiamo aumentare il salario minimo e, infine, garantire la parità di retribuzione per le donne, allora dovete votare. Ogni volta che parlo della parità di retribuzione per le donne, il mio avversario mi accusa di giocarmi la carta delle donne. Beh, sapete che vi dico: se parlare di parità di salario è giocarsi la carta delle donne, io la gioco». Hillary sembra più rilassata che in passato e parla meglio che in passato, lei che non è un granché come oratrice. E declina un programma che non è affatto male e risponde a molte richieste della sinistra. Certo, venire dopo il campione mondiale è un handicap.
La serata è finita, la gente torna a casa e una signora afraoamericana ci spiega: «Domattina mi alzo alle sei, alle otto voto e poi, ho un elenco di persone: se alle nove non hanno votato li vado a prendere a casa uno a uno e li trascino al seggio». Oggi l’America sceglie il suo presidente. Hillary non è il presidente dei sogni, ma avere un presidente dei sogni da votare non capita spesso. Dall’altra parte però c’è un incubo con i capelli ridicoli.
In breve:
Trump ha fatto cinque comizi ieri in molti Stati random, segno che, come dicono gli analisti, non ha chiaro quale possa essere la mappa elettorale per vincere. Ne prova molti e spera.
I latinos stanno andando a votare in massa e come mai prima. Da due cicli elettorali si parla del fattore ispanico, stavolta potrebbero rappresentare l’ago della bilancia a favore dei democratici.
C’è tensione nelle commisioni elettorali: le dichiarazioni di Trump e i trucchi usati per non fare votare le minoranze, potrebbero generare lunghe file in alcuni casi o forme di intimidazione ai seggi da parte di milizie o gruppi di destra.












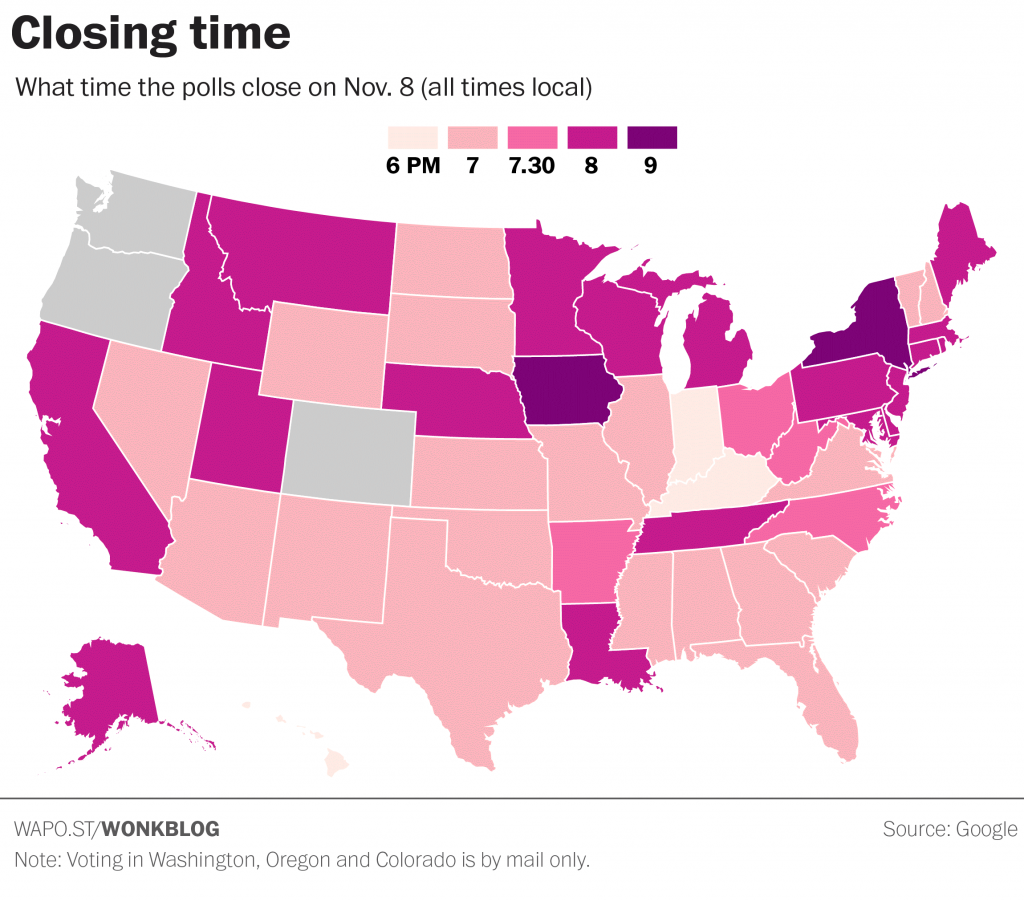











![MONTEVIDEO, Oct. 2, 2013 Uruguayan President Jose Mujica (C) speaks to a student during the handing over ceremony of computer number one million of the Ceibal Plan, a literacy project created 6 years ago inspired by the ''One Laptop per Child'' project, in Montevideo, capital of Uruguay, on Oct. 2, 2013. (Credit Image: © [E]Nicolas Celaya/Xinhua/ZUMAPRESS.com)](https://left.it/wp-content/uploads/2016/11/novanta_20161107132807927-1024x680.jpg)

