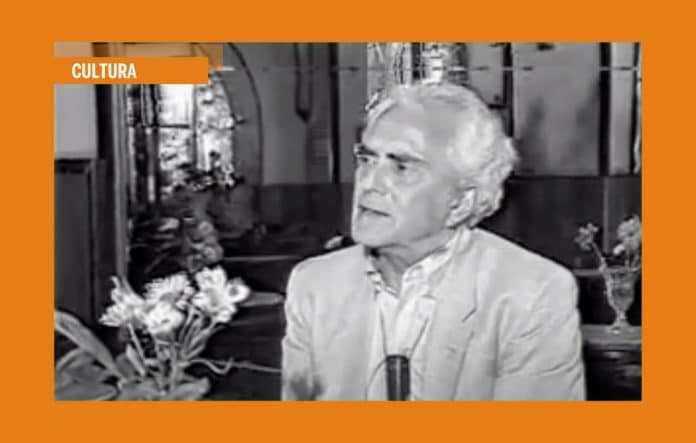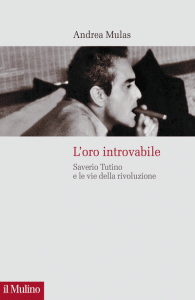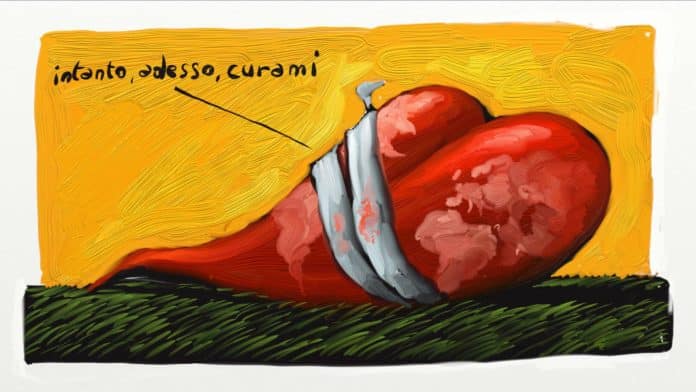La compositrice e pianista romana Rita Marcotulli è tra gli ospiti del format live ideato da Fondazione Entroterre e ispirato alla trasmissione “cult” di Radio3 Rai, condotta da Luca Damiani che approda in due location del Municipio XV di Roma fino al 22 settembre nelle frazioni di Cesano e di Riva di Polline. L’abbiamo incontrata
In che modo è sta coinvolta in questo progetto di Sei Gradi e cosa ha elaborato per questa occasione del concerto che terrà il 15 settembre?
Mi ha chiamato Luca Damiani che mi ha parlato di questo programma che io non avevo mai sentito, però l’ho trovato molto divertente e molto stimolante… quindi ci siamo parlati, ci siamo detti un po’ di cose, cosa potevamo fare e, poi, comunque non rivelo più niente perché è bello che rimanga una sorpresa.
Il progetto vuole essere un’occasione di legame tra il territorio e le genti che lo abitano, in alcuni casi anche provenienti da altri luoghi lontani. In che modo la musica si fa ulteriore spazio di possibili incontri?
Ma sicuramente la musica è veramente uno dei linguaggi più universali per riuscire a comunicare con con persone anche molto diverse, diciamo da un punto di vista geografico, etnico, però ecco la potenza che ha la musica è che essendo ovviamente un messaggio, un modo di esprimere delle emozioni non preclude nessun tipo di diversità, anzi, forse la cosa proprio bella è che la musica si arricchisce e si è sempre arricchita, parlo anche anche della mia musica tipo la musica jazz che comunque nasce da una contaminazione di ritmo africano in America ma comunque di ritmo africano con armonia per esempio europea, e quello già lascia pensare come sia importante comunque la diversità, l’incontro con delle culture diverse con modi diversi di vedere, di concepire, perché è un arricchimento e anche la musica ne è testimone in questo senso perché dà veramente tanti input e tanti stimoli; ecco dal punto di vista musicale io non mi ritengo solo una musicista di genere, mi piace la musica e non mi piace neanche etichettarla proprio perché è talmente meravigliosa; sarebbe come pensare un mondo solo ad un colore, insomma sarebbe veramente noioso e invece è proprio la bellezza dei colori che fa un mondo bello e così vale per la musica, vale anche per tutto il resto; per noi come esseri umani è fondamentale riuscire a capire altre cose e rendersi conto che non esiste un’unica realtà nella vita ma che tutto assolutamente relativo.
Perché a suo avviso, nonostante oggi si possa molto più facilmente viaggiare e avere contatti con altre culture rispetto al passato, è poi profondamente così difficile avvicinarsi e aprirsi alla diversità.
Questa è una bella domanda; è difficile avvicinarsi e aprirsi alle diversità semplicemente perché è diverso, è diverso da te, quindi tu hai paura di qualcosa che non riconosci, che non conosci. È lo stesso discorso che facevo prima; conosciamo un’unica realtà e pensiamo che quella realtà sia quella giusta e basta; come le persone che vogliono fare i moralisti, che vogliono “fare leggi per te”, e invece… Bisognerebbe riuscire ad imparare, a rispettare le cose, a rispettare gli altri anche se non ti riconosci, anche se magari non concordi certi atteggiamenti, però la cosa importante è appunto la tolleranza e soprattutto la voglia di conoscere qualcosa che tu non conosci proprio perché ti arricchisce e poi, come diceva un vecchio saggio: “pensiamo tutti di essere diversi ma anche in questo siamo uguali”.
La sua scelta di diventare pianista in quale momento è divenuta qualcosa di definito e consapevole?
Io sono nata col pianoforte perché di fatto ho cominciato a suonare quando avevo cinque anni e quindi per me è stato proprio il mio proseguimento; era come la mia mamma, il mio nido, quindi io ci giocavo proprio col pianoforte, facevo le storie, mi inventavo le cose, componevo già; quindi questa cosa sicuramente mi ha portato e mi ha avvicinato, oltre chiaramente all’aver fatto gli studi classici, mi ha avvicinato alla musica non scritta perché mi piaceva improvvisare e quindi poi è diventato un lavoro inconsapevolmente perché appunto, ripeto, siccome faceva parte di me è stata una cosa molto molto normale e ho cominciato a suonare con dei gruppi; il primo gruppo mi ricordo era brasiliano con Mandrake Som che era un percussionista che viveva in Italia che venne con Elza Suárez e Irio de Paola, io ero veramente una bambina, avevo 17 anni e quella fu la mia prima esperienza e dopodiché ho continuato a suonare, a fare ciò che mi piaceva ed è diventata la mia professione.
Quale è stato nella sua lunga storia di pianista un momento personale o artistico significativo che ha rappresentato qualcosa che ha in qualche modo aperto delle nuove strade e al tempo stesso messo in crisi?
Non ce n’è solo una, ce ne sono diverse… Tutte le collaborazioni che ho fatto, che sono state tantissime e anche con grandissimi musicisti leggendari, come con quelli con cui ho collaborato più a lungo come Billy Cobham con cui facevo una musica completamente diversa da quella che faccio adesso o Dewey Redman che era appartenente ad un mondo diverso perché lui veniva dal free, veniva da Ornette Coleman, Keith Jarrett; poi tutta la mia esperienza scandinava… tutto quello che ho vissuto ha portato qualcosa di significativo, che ha aperto delle nuove strade come ad esempio la collaborazione Pino Daniele che era musica pop e per la quale magari all’inizio i musicisti di jazz più puristi dicevano: Perché suonare musica pop che è una cosa semplice, invece io non l’ho mai trovata una cosa semplice, ho sempre pensato che tutte le musiche abbiano qualcosa in cui si deve entrare, come un altro mondo che è diverso. Ci stanno tanti mondi, ad esempio la musica pop è basata più sul groove e sulla sintesi… perché quello che io potevo dire suonando un solo anche per cinque minuti, in sole otto misure dovevo riuscire a dire quello che avrei voluto dire in cinque. Per esempio con Pino è stata una grandissima scuola. Ma anche per esempio il cinema che è sempre stata la mia seconda passione, proprio perché mio padre lavorava con compositori di musica da film e quindi ho avuto la fortuna di vedere sempre quando registravano e che mi ha sempre affascinato e quando ho fatto il primo lavoro di colonna sonora con Rocco Papaleo per Basilicata Coast to Coast che è stata una vittoria inaspettata per entrambi, quello è stato sicuramente per me un altro momento per me molto importante, vincendo il David di Donatello, il Ciak D’Oro, il Nastro D’Argento… Sai sono tanti tasselli nella vita come per tutti noi, io li chiamo “gli angeli”, che uno non sa bene di avere, che sono persone che anche inconsapevolmente ti indicano una strada a cui tu magari non hai mai pensato ma poi è così.
Invece la crisi viene sempre quando sai e quando conosci i tuoi limiti, quindi le crisi vengono nel senso che io so che più vado avanti e più conosco i miei limiti e mi piacerebbe migliorarli e certe volte mi rendo conto che alcune cose sicuramente sono più nella mia natura e altre no, anche se mi piacerebbe fare quello che non è più nella mia natura, però poi vedo che non lo è e questo a volte mi può portare in una crisi; ma io sono molto contenta di quello che faccio e della fortuna, perché ci vuole anche fortuna, che ho avuto nella vita a conoscere dei musicisti e delle persone straordinarie.
Per provare a raccontare la sua musica e specificamente il suo modo di suonare ciò che percepisco è una luminosità particolare, e parlando da fotografo, il suo suono ha una specifica risonanza con i livelli del bianco, come se non ci fossero zone di grigio o particolari ombre. Che rapporto ha con la luce e in generale con il guardare e come questo poi si traduce nella tua musica?
Ah che bella visione della luce, del bianco… mi piace molto questa cosa. Forse perché sono una persona abbastanza ottimista e quando suono soprattutto cerco di essere sempre me stessa che è la cosa che mi piace di più in un musicista, cioè riconoscere la personalità. Io oramai divido i musicisti in due categorie: Quelli che mi impressionano, i grandi tecnici, virtuosi che fanno delle cose straordinarie per cui tu dici: madonna non ci arriverò mai! Pero poi ci sono quelli che mi emozionano che sono diversi da quelli che mi impressionano.
Io sono più per raccontare qualcosa, una storia… la musica non deve essere solo autoreferenziale, a dire o dimostrare quanto sono brava, è ovvio che quando si comincia quello inevitabile, però poi c’è altro, cioè il virtuosismo dovrebbe essere un mezzo per riuscire a trasmettere qualcosa non il fine, e quindi quando suono anche con una nota o no sono abbastanza visionaria, mi piace riuscire a creare delle atmosfere, entrare dentro a certi mondi, certi colori; pensa che tu parli di colore… io da piccola vedevo tutto coi colori, ma anche i nomi, le persone. I nomi li vedo e continuo a vederli a colori, se penso un nome so già un colore. Quindi questa cosa del bianco mi piace molto.
In diversi suoi brani e progetti ci sono forti legami con il cinema, quali sono dei registi o dei film a cui si sente particolarmente legata e perché?
Registi direi tanti… mio padre lavorava come ingegnere del suono alla RCA dove aveva lavorato con musicisti di tutti i generi e da cui è uscita tutta la musica italiana da Gino Paoli, Rita Pavone, Morandi, De Gregori, però anche i compositori come Morricone, Trovajoli, Piccioni, Ortolani, ed è stato un maestro per gli ingegneri del suono specializzato in orchestra. Poi loro hanno aperto questo studio che si chiamava Ortofonica divenuto poi Forum, dove è stata registrata tutta la musica per cinema in Italia e non solo. Erano sette soci tra cui mio padre, Ennio Morricone, Trovajoli ed altri, ed io andavo a vedere ad esempio quando lavoravano a C’era una volta in America, ricordo Fellini con Prova D’Orchestra, La battaglia di Algeri ed ero sempre lì; ricordo Polanski quando lavorava a Frantic. E i grandi musicisti come Morricone e Trovajoli mi trattavano un po’ come la figlioccia. Quindi Sergio Leone è stato uno dei primi che mi ricordo quando ero piccola, poi ovviamente il cinema è la mia seconda passione e feci un omaggio per esempio al cinema francese, a Francois Truffaut che trovo un regista straordinario ma mi piacciono molto per esempio Wenders, Woody Allen, e poi tutti i film di Frank Capra, quelli che non si vedono più adesso perché adesso sono tutti molto cupi… invece lì c’era sempre una speranza; e poi ovviamente gli italiani, Fellini, Pasolini, Rossellini, tutti i grandi insomma non ce n’è uno che preferisco, io cerco di riconoscere la meraviglia e la bravura del regista. Sicuramente Fellini è uno dei più visionari… mi sono rivista ultimamente delle cose sue, tipo Otto e Mezzo che io non mi ricordavo. È veramente una cosa pazzesca che è difficile riuscire a vedere. Non riconosco qualcuno simile anche tra gli attuali bravissimi come Sorrentino, con Fellini eravamo su un altro… un’altra onda, forse perché era proprio un momento storico diverso un altro modo di rapportarsi con la creatività, perché poi di fatto tutta l’arte non è altro che un mezzo per esprimere le emozioni che uno vive e quindi la storia dei nostri tempi; noi viviamo questa storia e pertanto i registri raccontano questa storia.
Sicuramente un film che io amo è Barry Lyndon di Kubrick, per i colori, per come è fatto e ritorniamo al discorso della luce; parliamo di un film girato con le candele… quello è sempre un film che quando ripenso mi emoziona.
Ogni fotografo ha una foto mancata, che molto spesso, proprio perché rimasta dentro di sé senza poter essere realizzata e condivisa diventa una sorta di stella cui tendere, come un tesoro interno o talvolta una Fata Morgana o una Chimera. Esiste anche nei musicisti qualcosa di simile che non si è potuto trovare il modo di esprimere e pertanto rimane una tensione o una memoria interna che non ha forma ma che si fa perenne ricerca?
La perenne ricerca nell’arte secondo me è indispensabile, è come dire: Mi fermo qua e aspetto di morire… Nell’arte è necessaria proprio questa farfalla nello stomaco, che pigia, che è sempre in continua ricerca, in continua emozione. Se è già tutto uguale in realtà non ti dà più emozione, e questo è un elemento importante della ricerca. In questo una tensione interna ti porta sempre a voler arrivare da qualche parte e sai che c’è sempre ancora da imparare; e questa è un po’ la tensione che uno ha e che porta a studiare ancora e ancora, e nello stesso tempo è anche la sua bellezza.
Sei gradi dal vivo
Insieme a Marcotulli gli altri protagonisti dei concerti jazz sono Carlo Negroni ( Enrico Pieranunzi, e il cantante e attore Peppe Servillo, accompagnato dal chitarrista Cristiano Califano (22.09). (Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti).
Con la sua formula originale di spettacolo, che combina narrazione e musica dal vivo, musiche e musicisti lontani nel tempo, nello spazio e nei generi dialogano tra loro sulla rotta delle 6 tappe che congiunge tra loro – secondo la celebre teoria elaborata negli anni Trenta del Novecento scrittore ungherese Frigyes Karinthy – ogni essere vivente sul pianeta.
Il progetto nasce dalla convinzione che la musica in contesti specifici può essere un potente strumento di resilienza, capace di trasformare il dolore in bellezza. Da qui l’idea di chiamare artisti di rilievo nazionale e internazionale, noti per la loro sensibilità e capacità di sperimentazione musicale, per tradurre in un repertorio musicale, rappresentativo delle diverse esperienze culturali, migratorie, o semplicemente multiculturali le suggestioni raccolte dalla comunicatrice, attrice e regista Laura Antonini nel ciclo di incontri e laboratori rivolti ai cittadini stranieri residenti nei quartieri del Municipio XV di Roma, laboratori nati per generare stimoli musicali, esplorando i gusti personali, le esperienze di ascolto nei Paesi d’origine e le nuove connessioni sviluppate nel contesto italiano. Tra loro, cittadini provenienti dai quattro angoli della terra, muniti della ricchezza delle loro esperienze culturali, e in particolare provenienti da: Repubblica Democratica del Congo, Spagna, Ghana, Togo, Egitto, Camerun, Mali.
Durante gli eventi dal vivo, Luca Damiani esplora le connessioni musicali tra i brani eseguiti e i temi dell’identità, della migrazione e dei ricordi legati ai Paesi di origine dei partecipanti. La sua conduzione vuole arricchire l’esperienza del pubblico, tessendo un filo narrativo che unisce le diverse performance in un racconto sorprendente e coinvolgente.
Programma completo www.entroterre.org
L’autore: Filippo Trojano è fotografo e scrittore