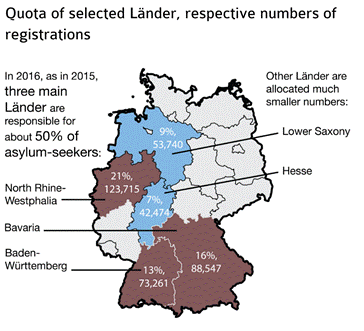Una “grande riforma” della Costituzione è nemica delle riforme che servono.
È da respingere quindi l’ennesimo tentativo di mettere a soqquadro l’intera seconda parte della Costituzione, senza raggiungere gli obiettivi che concretamente servono per un migliore funzionamento del Paese.
È importante, invece, procedere a una “manutenzione” della Costituzione e a sue modifiche significative, partendo dai concreti problemi che si sono posti. Si tratta di un lavoro che non improvvisiamo alla vigilia del referendum costituzionale, ma che abbiamo condotto con cura, pazienza e attenzione, durante tutta questa legislatura che da subito ha inteso porre al centro della discussione politica la Costituzione.
Il lavoro è stato portato avanti in sede scientifica e parlamentare, dove ha trovato ascolto soprattutto da parte di Giuseppe Civati, alla Camera, e di Vannino Chiti e Walter Tocci, con alcuni altri parlamentari, al Senato. A loro si deve anche il tentativo di avere proposto una revisione costituzionale alternativa a quella del Governo, anche nella convinzione che, per essere capace di coinvolgere la più ampia parte delle forze politiche, la proposta dovesse nascere in Parlamento, come la proposta del testo costituzionale era nata, infatti, nell’ambito della stessa Assemblea costituente, tenendo insieme la prima e la seconda parte della Costituzione, ma soprattutto tenendo insieme un popolo, senza spaccarlo, tirandolo di qua o di là proprio sulla Carta che tutti deve rappresentare.
Tutto questo è possibile partendo da alcuni interventi puntuali, su cui sembra essere matura una maggiore condivisione:
1. Riduzione del numero dei deputati e dei senatori e delle loro indennità. Se il sistema rimane bicamerale (non registrandosi la necessaria convergenza per passare al monocameralismo) non ha senso ridurre soltanto i componenti di una Camera. La riduzione deve avvenire proporzionalmente in entrambe le Camere. La nostra proposta, per mantenere un adeguato livello di rappresentanza, è di 470 deputati e 230 senatori (senza senatori a vita), per un totale di settecento parlamentari. Una diminuzione del 25% degli eletti, che supera di 30 unità quella proposta dal Governo. La richiesta di riduzione del numero dei deputati e dei senatori è motivata dalla necessità di contenere i costi degli eletti. Ma per questo non basta la modifica costituzionale, è necessaria anche una legge, che si poteva fare anche a prescindere, in base alla quale l’indennità propriamente intesa dovrebbe essere ancorata ad uno stipendio decoroso e più basso come quello dei professori universitari (non quello dei Presidenti di Cassazione); i rimborsi spese dovrebbero essere ridotti, lasciando quelli per l’alloggio a Roma a chi non vi vive già e mettendo a carico della Camera d’appartenenza le spese per il collaboratore e alcuni servizi per lo svolgimento dell’attività parlamentare.
2. Fiducia al Governo espressa solo dalla Camera dei deputati. Come praticamente in tutti gli ordinamenti che hanno una forma di governo parlamentare la fiducia dovrebbe essere espressa dalla sola Camera dei deputati. Questo servirebbe non solo a evitare le difficoltà di formazione di un Governo nel caso di risultati parzialmente diversi nelle due Camere ma anche a liberare il Senato dal vincolo politico con l’esecutivo consentendogli una migliore attività di controllo (come quella su alcune nomine pubbliche, secondo il sistema dell’advice and consent statunitense).
3. Miglioramento dell’efficienza del procedimento legislativo (con l’istituzione di una commissione paritetica bicamerale). Non è vero che oggi le leggi sono sottoposte a un continuo ping-pong tra la Camera e il Senato: delle 224 leggi approvate in questa legislatura al 30 giugno 2016, ben 180 hanno concluso il loro cammino dopo un solo passaggio alla Camera e al Senato e i tempi di approvazione nella seconda Camera, quando c’è la volontà politica, sono particolarmente rapidi. Per di più la possibilità di avviare il procedimento legislativo in entrambe le Camere comporta uno snellimento dei lavori (perché mentre da una parte si affronta una proposta, dall’altra se ne istruisce e approva un’altra).
La revisione costituzionale del Governo, oltre a complicare il sistema, che viene a essere frammentato in procedimenti e sub-procedimenti di dubbia applicazione, rischia di rallentarlo in più momenti, non eliminando il rischio per cui se si vuole insabbiare una legge lo si può sempre fare nei numerosi passaggi previsti.
C’è invece una soluzione (già collaudata in altri paesi) per eliminare anche i pochi casi in cui una proposta incontra difficoltà a essere approvata, senza bisogno di stravolgere il sistema rischiando di complicarlo: l’istituzione di una commissione paritetica bicamerale (composta cioè dallo stesso numero di deputati e di senatori), da attivare nel caso in cui le Camere assumano posizioni differenti, al fine di licenziare più facilmente un testo chiaro e condiviso.
4. Potenziamento degli istituti di democrazia diretta: referendum e iniziativa legislativa popolare. Le riforme non devono essere fatte per “lasciare governare” qualcuno, senza alcun controllo, rendendo i cittadini sovrani solo un giorno ogni cinque anni, ma devono dare a questi ultimi la possibilità di incidere anche tra un’elezione e l’altra. Non solo favorendo, anche con leggi in materia, la partecipazione nei partiti e movimenti politici, ma con gli istituti di democrazia diretta.
In particolare, è da abbassare il quorum di partecipazione al referendum per renderlo valido se ha partecipato la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati (senza che ciò richieda – come nella riforma del Governo – un aumento delle firme per la richiesta). Quanto all’iniziativa legislativa popolare la Costituzione deve prevedere espressamente un obbligo di deliberazione in materia, entro un termine trascorso il quale su questa si devono esprimere direttamente i cittadini con un referendum (deliberativo).
5. Eliminazione del Cnel. Se l’introduzione del Cnel è stata determinata dalla necessità di rappresentanza dei corpi sociali, questa esigenza sembra superata almeno in queste forme (forse servirebbero piuttosto altri interventi come, ad esempio, leggi di regolazione delle lobby). Comunque, dato che nella pratica il Cnel ha funzionato con scarsa efficacia, riteniamo che sia giusto eliminarlo.
Questi sono alcuni dei motivi che giustificano il NO al referendum costituzionale. Ma vi è una ragione in più a favore di un voto negativo. Se venisse approvata questa cattiva riforma, si creerebbero molti problemi nel nostro ordinamento e ci potrebbero volere altri vent’anni per abrogarle e fare cose migliori. Quindi conviene evitare tutto questo e riprendere il cammino molto più semplice delle revisioni costituzionali leggere e condivise.
Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica Università di Bologna,
Andrea Pertici, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università di Pisa,
Maurizio Viroli, professore emerito di Teoria politica, Princeton University,
Roberto Zaccaria, professore di diritto costituzionale all’università di Firenze