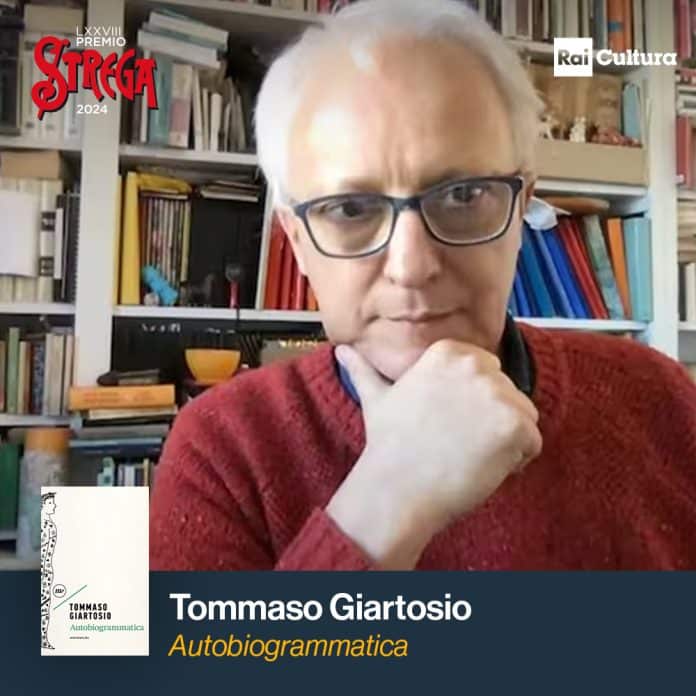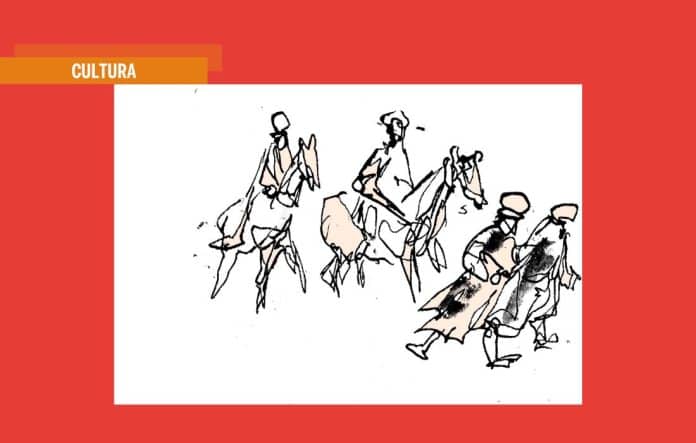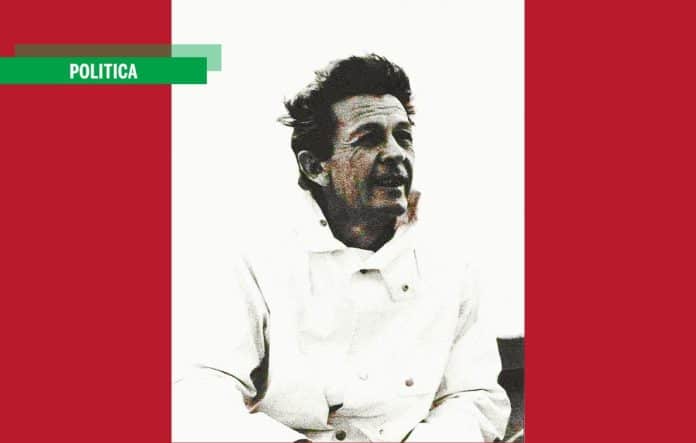Autobiogrammatica è il nuovo libro di Tommaso Giartosio ( Minimum Fax, finalista al premio Strega). Quasi incredibilmente il titolo, così criptico, corrisponde in maniera esatta a questo libro, e lo descrive. Si tratta infatti di autobiografia, ma la grammatica costituisce il vero filo conduttore, anzi l’intreccio determinante della vita narrata. Ho detto “la grammatica”, ma avrei dovuto dire i grammata, cioè i segni e gli ur-segni alfabetici o para-alfabetici, i glifi, i geroglifici, i monogrammi, gli ideogrammi, i calligrammi, i caratteri che formano le parole, sempre al confine con i disegni (che non a caso, autografi, figurano nel libro); sono cruciali, e molto belli, i tre capitoli dedicati all’alfabeto, frutto dell’intreccio fra un’erudizione vasta e una vera passione. Così il problema di “Cos’è una A?”, che cosa essa è veramente (pp. 296, 351 et passim), può ispirare e percorrere larghe parti del nostro libro.
Il gioco che Giartosio compie fra le diverse lingue moderne da lui possedute non è poi tanto diverso dal gioco di inventare lingue e parole, insomma codici che servono a escludere più che a comunicare (a comunicare un segreto?), anche se questi giochi sono sempre temperati dall’auto-ironia: “il potere di isolamento dell’inglese – la paradossale forza segregante di una forma di comunicazione! – si manifestò in pieno. Entrai in clandestinità.” (p. 26).
Prima di ogni significazione c’è solo la recherche del linguaggio perduto, un linguaggio puro e meraviglioso (e impossibile), “Come talvolta i baci, come l’òla [il saluto del padre rientrante in casa, NdR]. Anche come i pugni di quello che mena…” (p.404).
Così la quête di Giartosio non muove dall’area del significante verso la significazione, dai segni verso le cose, al contrario sembra indulgere sui segni proprio per impedirsi di accedere al mondo delle cose, cioè ai nomi e soprattutto alle persone. Anche quando finalmente le persone compaiono esse sono come respinte sullo sfondo: è la consueta dialettica fra evocazione e dimenticanza che caratterizza le scritture autobiografiche ma che qui è come drammatizzata da una sorta di trattenimento che forse è una fuga. Deriva da questo movimento l’autoimposta frigidità che percorre le pagine di questo libro, nonostante che esso contenga anche brani strazianti. Come se alla base di tutta l’opera ci fosse uno sforzo, intelligente e colto, di nascondimento, un “non dicendo, dire”.
L’entità che l’autore chiama “papaemmamma” (“i miei continuavano, implacabili, a volere il mio bene”: p.357) è forse il vero centro di questo nascondimento.
Chi ha letto la raccolta di poesie di Giartosio Come sarei felice (Einaudi 2019) sa già tutto quello che c’è da sapere del padre dell’Autore; certo si tratta dell’unico ufficiale di Marina, anche un po’ reazionario, che susciti affettuosa simpatia nel lettore, per la sua dolente e dignitosa compostezza. L’ultimo rappresentante di una classe di cui abbiamo perfino scordato il nome (forse la borghesia?), una classe che, ogni giorno di più, siamo tentati di rimpiangere a fronte della poltiglia infame che ne ha preso il posto (e che – comunque – proprio come Mussolini: “Non sa stare a tavola”). Più nascosta (dunque più presente) è naturalmente la figura materna. Tuttavia è da una linea ereditaria femminile, una nonna, che proviene a Giartosio il dono di un libro di Ezra Pound “con sguardo complice” (p.401), per i diciott’anni!, come un’iniziazione attesa e inevitabile.
La nonna è un’anglista, due lauree e tre o quattro libri pubblicati, che si inginocchia davanti al televisore per ricevere la benedizione di Pio XII. Costei aveva anche intrattenuto una confidente corrispondenza personale con Pound nel ’37-’41, proponendosi di stendere una voce sulle sue opere per il Dizionario letterario Bompiani.
Se le autobiografie hanno un intreccio, l’incontro con Pound è come uno scioglimento che prelude all’epilogo. Il linguaggio della “poesia pura” di Pound, “integralmente vero, autentico, autorevole, assoluto, senza possibilità di menzogna, vergogna, passione, finzione” è la vera, e ultima, tentazione di Giartosio che lo attira e – al tempo stesso – lo terrorizza (“avevo sempre temuto un linguaggio simile. Mi spaventava a morte. Era ciò da cui mi proteggevo con mille scherzi, schemi, schermi”). Questo incontro con Pound e i Cantos pisani sospinge l’autore verso ls lingus cinese, “uno sterminato campionario di caratteri composti, in cui l’elemento rappresentativo, la raffigurazione, si stempera fin quasi a scomparire” (p.405). Così la ricerca che il nostro libro racconta, partita dall’alfabeto di chiuderebbe, come in un cerchio, su un non-alfabeto ideogrammatico misterioso e potentissimo, “caratteri reali e non nominali”. Finalmente fuori dalla significazione storica e inter-umana.
Sull’orlo di questa conclusione (di questo abisso?) Giartosio è trattenuto, non dal fascismo di Pound (“non era un problema”) ma dal disgusto per il fascismo del suo pubblico di ammiratori, che gli si manifesta in una conferenza romana :”Ha concluso: ‘Perché, ricordiamolo, Pound fu un grande fascista!’. Un applauso. Mi sono guardato intorno, incredulo. Tutti quei signori dall’aria serena, con i loro sorrisi e gli sguardi velati da circolo parrocchiale, erano passati in un attimo dal guardare al menare (…) Come in certi romanzi o film di fantascienza il protagonista realizza con orrore di essere circondato di alieni dall’aspetto umano (…)” (p.426-7). La nausea che la beneducata ferocia di questi alieni provoca in Giartosio è sufficiente per interdirgli la – chiamiamola così – “strada Pound”, la strada dell’assoluto cercato/trovato nella poesia pura e irrelata.
Nel Bildungsroman di Giartosio si verifica allora una imprevista quanto decisiva rivincita della storia, anzi addirittura della politica. Questi elementi, che erano stati rigorosamente esclusi dalla vicenda della formazione e dalla vita dell’autore, vi rientrano proprio nel momento conclusivo, e decisivo. Come se la storia e la politica, per quanto denegate, avessero la forza di pervadere tutto, rientrando non da una finestra chiusa male ma da una semplice minima fessura imprevista. “Finiva il tempo degli alfabeti. Ma intanto iniziava il tempo dei nomi” (p.435) cioè delle umane persone e dei loro volti.
Frame video di Tommaso Giartosio, scrittore e conduttore del programma di Rai RadioTre Fahrenheit