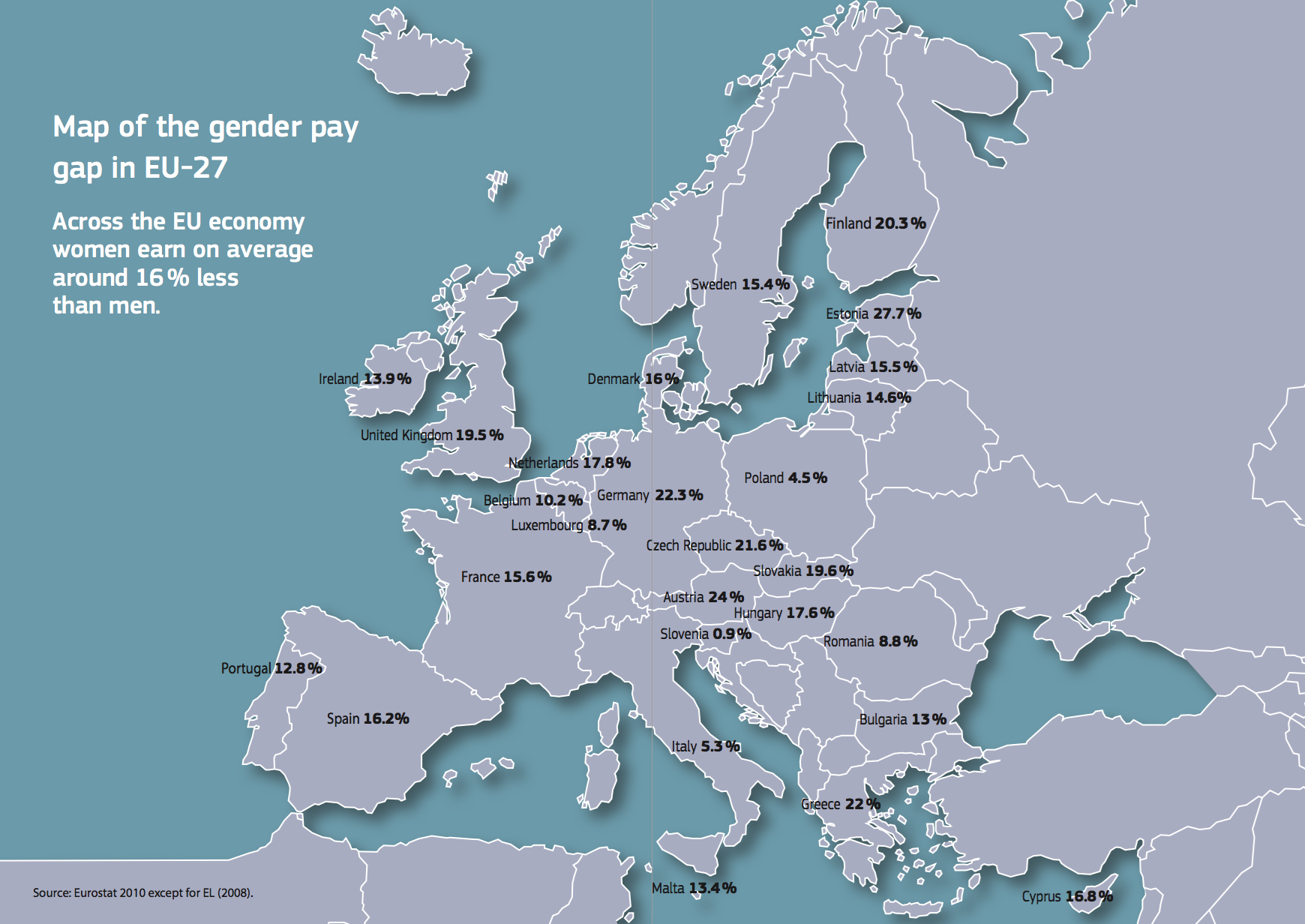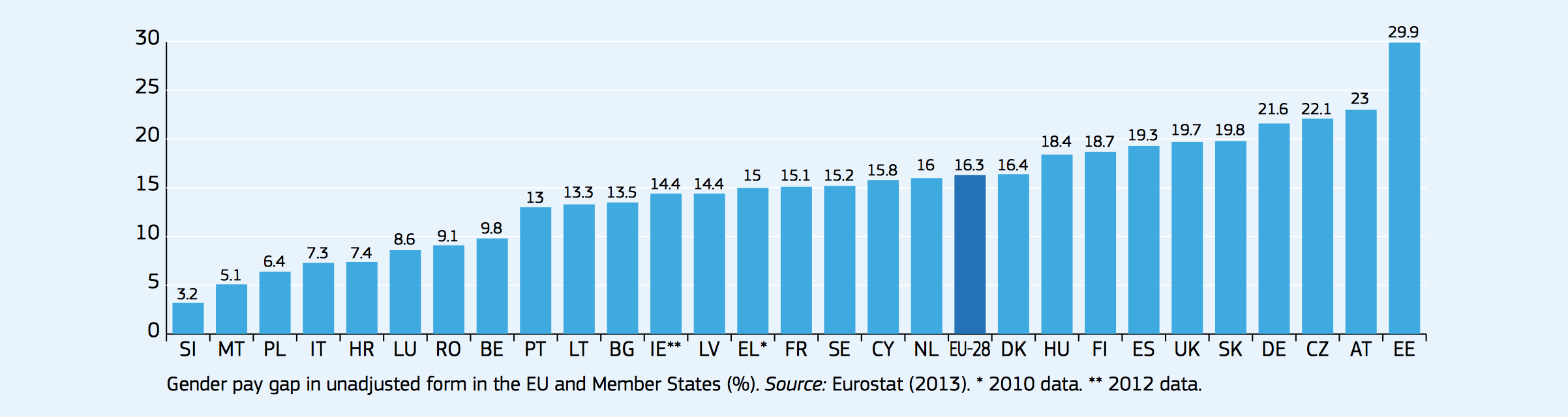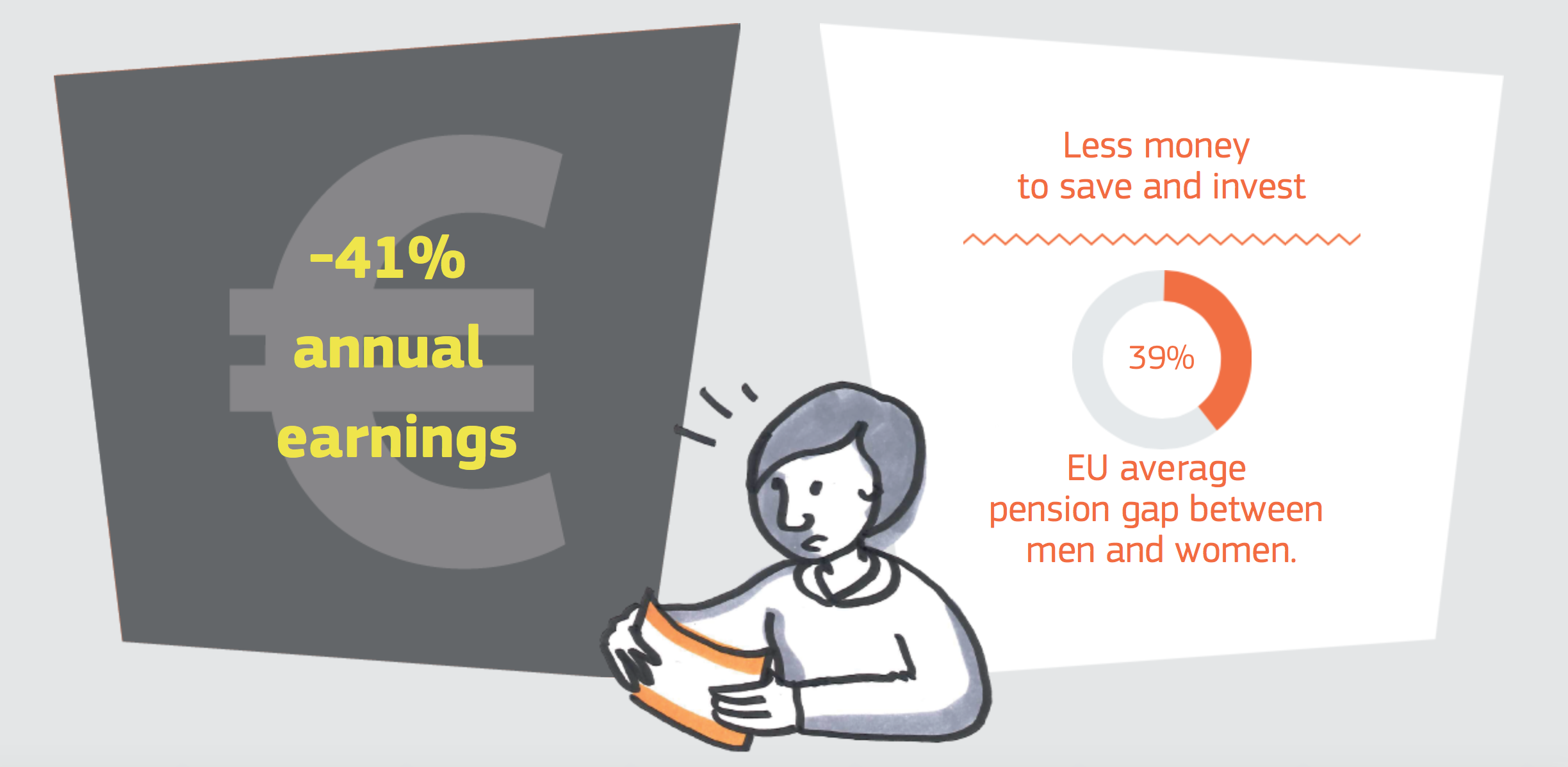Pubblichiamo l’intervento integrale pronunciato dal magistrato in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Bologna
«Sono innanzitutto felice e onorato di ricevere oggi la Cittadinanza Onoraria di Bologna. Sto vivendo in queste ore con molta emozione, ve lo garantisco, un momento molto bello, per il quale sento di ringraziare innanzitutto tutti voi, l’intera Amministrazione comunale, il Sindaco, i consiglieri e ancor prima, me lo consentirete, le associazioni dei tanti cittadini che hanno pensato, ideato e fortemente voluto questa iniziativa.
In un Paese che sempre più sta perdendo la memoria e la capacità di indignazione, per fortuna ci sono ancora tanti cittadini che da anni dimostrano, con la loro entusiasmante passione civile, di avere realmente a cuore la verità, la giustizia, la legalità, la vera antimafia.
Oggi viene conferita a me la Cittadinanza Onoraria di Bologna, credetemi, non mi sento però il destinatario esclusivo di questo riconoscimento. So che l’iniziativa rappresenta l’abbraccio ideale di una comunità a tutti coloro, magistrati, Forze dell’ordine, e mi sento di ringraziare particolarmente il Presidente della Corte di Appello, il Prefetto, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che quotidianamente spendono il loro impegno nell’azione di contrasto della criminalità organizzata.
Personalmente, per quanto mi riguarda più direttamente, la giornata di oggi assume un ulteriore valore particolare, intanto di conforto e di solidarietà vera in un momento di oggettiva difficoltà personale, ma soprattutto il valore e il significato di un ulteriore, autentico stimolo a continuare il mio lavoro con sempre maggiore impegno ed entusiasmo. Nonostante tutto, nonostante tanti, nonostante un clima di isolamento istituzionale che percepisco sempre più nettamente, per me l’abbraccio ideale della collettività che questa istituzione comunale rappresenta, costituisce soprattutto una splendida occasione per scolpire ancora più profondamente nella mia mente, nella mia coscienza di magistrato la convinzione che l’essenza più autentica e più nobile del ruolo del magistrato non è quella dell’esercizio di un potere, ma quella della resa di un servizio alla collettività e in particolare ai più deboli, agli onesti, all’esercito silenzioso dei senza potere. Una collettività che dalla magistratura e dal singolo magistrato attende e pretende reale indipendenza di azione, autonomia da ogni altro potere, coraggio e decisione nel perseguire l’obiettivo di contribuire alla effettiva attuazione dei principi costituzionali e, tra questi in primo luogo del principio fondamentale dell’eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge.
Vorrei che questo momento, per me così importante, diventasse per tutti noi occasione di una seria riflessione su che cosa oggi è diventata la mafia, sul pericolo che rappresenta per il sistema democratico. Vorrei che diventasse un momento di onesta riflessione su quale oggi sia, al di là delle parole e dei facili proclami, la risposta della politica al gravissimo problema rappresentato dalla criminalità organizzata e, permetterete, dalla diffusione del metodo mafioso nell’esercizio del potere.
Una premessa, un dato di conoscenza che ho acquisito e sedimentato in più di venti anni di indagini e processi sulla criminalità organizzata: è nel DNA della mafia, in particolare di Cosa Nostra, l’organizzazione siciliana, la ricerca del rapporto con la politica, con le istituzioni, con il mondo dell’economia, dell’impresa e della finanza.
Per loro, per i mafiosi quel tipo di rapporto è assolutamente fondamentale, per la stessa esistenza in vita delle loro organizzazioni. Senza questi rapporti, la mafia non avrebbe mai, mai potuto raggiungere la potenza e la pericolosità che purtroppo la contraddistinguono. Loro, i mafiosi, ne sono perfettamente consapevoli. È questo il motivo per cui da più di 150 anni, in particolare Cosa nostra ha progressivamente cresciuto la sua potenzialità criminale. Loro hanno la consapevolezza della decisività di questi rapporti esterni. Ancora lo Stato, le istituzioni politiche nel loro complesso non hanno invece dimostrato con i fatti di volere definitivamente puntare a recidere quei legami. È questo il principale motivo per il quale, pur avendo vinto alcune importanti battaglie contro le organizzazioni mafiose non riusciamo ancora a vincere la guerra, ad intravedere il momento nel quale il fenomeno verrà finalmente debellato.
Continua a esistere una, a mio parere, ingiustificata e dannosa divaricazione tra la efficacia e giusta severità della repressione dell’ala militare delle organizzazioni mafiose e la sostanziale inadeguatezza degli strumenti legislativi a nostra disposizione per colpire i rapporti esterni delle organizzazioni mafiose con il potere. Non si è compreso a pieno, o forse non si è voluto e non si vuole comprendere, che oggi dobbiamo confrontarci con un sistema criminale integrato, in cui mafia e corruzione, delitti tipici della criminalità organizzata e delitti contro la Pubblica amministrazione, rappresentano due facce della stessa medaglia, due aspetti diversi di un unico sistema malato che si sta espandendo come un cancro. A oggi, il quadro normativo in vigore garantisce ai corrotti, ai collusi, ai facinorosi delle classi più ricche, spazi troppo ampi di sostanziale impunità, in particolare attraverso il sistema della prescrizione che nella grande maggioranza dei casi estingue quei reati, quei delitti che costituiscono le manifestazioni più tipiche della delinquenza dei colletti bianchi prima della definitività del giudizio, vanifica così gli sforzi dei magistrati e delle forze di polizia, ma prima ancora mortifica le aspettative delle persone offese e di tutti i cittadini onesti che hanno diritto alla trasparenza e pulizia dell’Amministrazione della cosa pubblica.
Si impone ancora una amara, molto amara, riflessione su come nel nostro Paese il problema del rapporto tra la mafia e la politica sia stato per troppo tempo considerato di esclusivo interesse del giudice penale, come se il suo profondo disvalore si esaurisse nella responsabilità penale di certi comportamenti. Come se determinate condotte a prescindere dalla loro eventuale e concreta cofigurabilità come fatto di reato, non dovessero comunque far scattare altri meccanismi di responsabilità, in primo luogo politica. Non è più concepibile la delega esclusiva alla magistratura per sanzionare il rapporto tra la mafia e la politica.
Da cittadino prima ancora che da magistrato auspico che la politica si riappropri di un ruolo di prima linea nella lotta alla mafia, si riappropri di quella capacità di denuncia, di quella capacità di far valere la responsabilità politica di certi comportamenti che caratterizzò fortemente, anche in certe fasi drammatiche della nostra storia recente, l’azione di partiti politici allora all’opposizione, che caratterizzò, in certe fasi, l’attività della commissione nazionale antimafia, e ancora l’attività di singoli esponenti politici che sapevano fare i nomi dei mafiosi e dei potenti in combutta con i mafiosi, quando ancora quei nomi non erano consacrati e contenuti nemmeno nei rapporti delle forze di polizia e tantomeno nelle sentenze della magistratura.
Ritengo ancora che per affrontare il presente e pensare con ottimismo al futuro non dobbiamo incorrere nel grave errore di dimenticare il passato, un passato che è fatto anche di tanti, troppi delitti eccellenti. La lunga e drammatica teoria degli omicidi eccellenti e delle stragi che hanno contraddistinto la nostra storia recente non può essere dimenticata, questo Paese non può definitivamente archiviare come episodi di un passato ormai lontano le tante stragi, a partire da quella del 2 agosto 1980, in questa città, che costituirono il frutto di perversi legami tra organizzazioni terroristiche e settori importanti del potere e degli apparati istituzionali.
Questo Paese non può definitivamente archiviare il capitolo delle stragi e dei delitti eccellenti della mafia sopratutto perché partendo e avendo il coraggio e l’onestà concettuale di leggere le sentenze sui processi che sono stati già celebrati, le sentenze definitive, emerge in relazione a tutte queste vicende giudiziarie riguardanti i delitti eccellenti di mafia, quanto meno il gradimento, o, in certi casi il cointeresse, all’eliminazione del bersaglio, anche da parte di ambienti esterni a Cosa Nostra.
In qualche caso gli elementi indiziari e di prova che emergono dai processi già conclusi riguardano perfino la possibilità che altri soggetti, diversi dagli appartenenti alle famiglie mafiose abbiano addirittura avuto un ruolo nella organizzazione e nelle fasi esecutive dei delitti eccellenti.
Invece ahimè sembra che quell’obiettivo di ulteriore approfondimento, che ci impongono le sentenze dei giudici, sia condiviso e vissuto oggi da pochi soggetti, da pochi magistrati e pochi investigatori, nel disinteresse, nel fastidio e perfino nella ostilità generale.
Noi però sappiamo che un Paese senza memoria è un Paese senza futuro, uno Stato che si dimostrasse incapace di guardare anche dentro se stesso, nelle pieghe ancora oscure di deviazioni e collusioni di apparati criminali e mafiosi, non sarebbe uno Stato realmente credibile e autorevole agli occhi dei cittadini.
Un sistema che, per convenienza politica e malintese e perciò non dichiarate ragioni di Stato, continuasse a tollerare quando non addirittura a cercare il dialogo, il compromesso con le organizzazioni mafiose, non sarebbe rappresentativo di un sistema veramente democratico.
Sono veramente onorato e orgoglioso di ricevere la cittadinanza onoraria di una città simbolo dei valori fondanti la nostra splendida e sempre attuale Costituzione, sono orgoglioso di ricevere la cittadinanza onoraria di una città che costituisce, per la sua storia di integrazione tra cittadini provenienti da diverse parti d’Italia, d’Europa, del Mondo, intanto un autentico emblema dell’unità nazionale.
Sono emozionato perché oggi mi considerate degno di essere cittadino onorario di Bologna, città decorata con la medaglia d’oro al valore militare per il contributo dato alla Resistenza e alla liberazione dal Nazifascismo, quella Resistenza fondamento e cardine della nostra democrazia. Bologna è anche medaglia d’oro al valore civile, a seguito del criminale attentato terroristico del 2 agosto 1980 perché, si legge nella motivazione di quel conferimento “l’intera popolazione, pure emotivamente coinvolta, dava eccezionale prova di democratica fermezza e di civile coraggio, prodigandosi con esemplare slancio nelle operazioni di soccorso”, quelle decorazioni nel gonfalone della vostra, della nostra città, assumono anche un altro significato: il valore di un sogno bellissimo che parte dalla consapevolezza che oggi deve essere prioritaria una nuova forma di Resistenza per vincere una nuova e particolarmente insidiosa e pericolosa guerra di liberazione, una guerra di liberazione contro le mafie, contro la mentalità mafiosa, contro la diffusione di questa mentalità anche nell’esercizio del potere.
Una guerra di liberazione contro la corruzione, contro le lobby, le massonerie, il predominio del concetto di appartenenza rispetto al merito, l’illegalità diffusa che a tutti i livelli sta progressivamente erodendo e sfaldando come un cancro il tessuto sociale del nostro Paese, una guerra di liberazione contro la rassegnazione a convivere con quei fenomeni criminali.
Tutti, ciascuno con il suo ruolo e le sue capacità, abbiamo il dovere di promuovere e sviluppare questa nuova forma di resistenza e liberazione, per coltivare il sogno di una rivoluzione culturale, che partendo dai giovani riesca a restituire al nostro Paese il fresco profumo della libertà, della solidarietà, di una democrazia reale, frutto compiuto di un percorso di giustizia e di verità.
E’ questo il senso, per me molto, bello, dell’incontro di oggi e del riconoscimento conferitomi. Grazie».