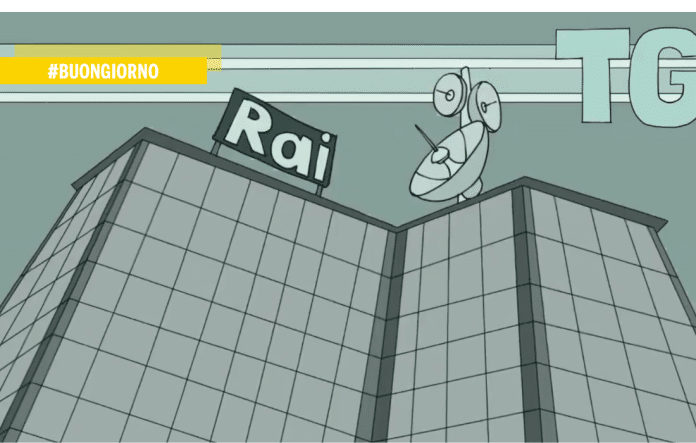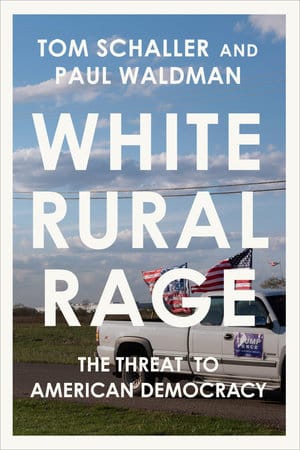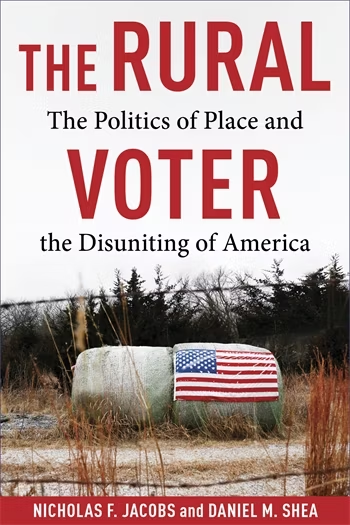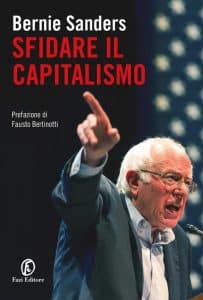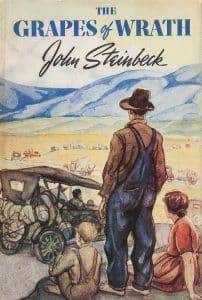La “rabbia rurale bianca” è l’argomento di un acceso dibattito che si è scatenato negli Stati Uniti in vista delle prossime elezioni di novembre, grazie a un nuovo libro, White rural rage. The threat to American democracy (Penguin, New York 2024), scritto dal politologo Tom Schaller e dal giornalista Paul Waldman. La loro tesi è che il Paese si sta dividendo tra due Americhe molto diverse: una rurale e l’altra urbana. Questo nonostante che ci sono molte altre divisioni all’interno dell’elettorato americano: tra i bianchi e le persone di colore; tra ultraricchi/ricchi e classe medie e lavoratrici in declino, tra cristiani e non cristiani, tra vecchi e giovani, tra persone con istruzione universitaria e quelle senza, tra uomini e donne, per citarne alcune.
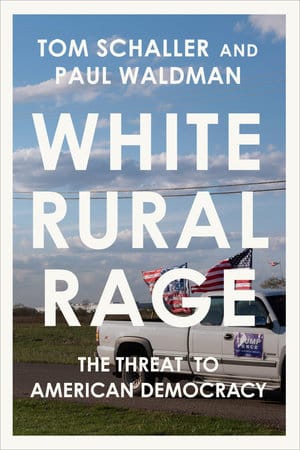 In 255 pagine, gli autori sostengono che gli americani delle zone rurali sono il gruppo “geodemografico” più razzista, xenofobo, anti-immigrazione, omofobo, cospirazionista, antidemocratico, suprematista bianco e nazionalista cristiano bianco (il 76% dell’America rurale è bianco e il 38% dell’America rurale è bianco evangelico fondamentalista), e violento del Paese. Secondo loro, queste caratteristiche rendono gli elettori bianchi rurali una «minaccia unica per la democrazia americana», perché hanno un peso sproporzionato alle urne rispetto a qualsiasi altro gruppo demografico negli Stati Uniti. Sottolineano come le strutture politico-istituzionali – la rappresentanza di 2 senatori per ciascuno Stato al Senato federale a prescindere dalla popolazione (nonostante gli Stati rurali siano decisamente meno popolati), quella alla Camera federale (pesantemente condizionata dalla pratica del gerrymandering e dal fatto che i distretti elettorali puramente rurali o con influenza rurale/suburbana rappresentano il 42% dei seggi, anche se ci sono più persone che vivono nelle città; le aree urbane più popolose hanno la metà della rappresentanza alla Camera rispetto ai distretti elettorali rurali), come quella al Collegio elettorale nazionale (che si basa sul numero di seggi alla Camera e su due senatori in ogni Stato, per cui il Wyoming ha 18 voti elettorali in meno rispetto alla California, anche se la California ha una popolazione 68 volte più numerosa) sono fortemente squilibrate in favore di Stati e aree rurali spopolate dominate dal Partito repubblicano – favoriscono la sovra rappresentazione dei bianchi rurali che costituiscono solo il 16% dell’elettorato americano (tra l’altro circa il 24% dell’America rurale è costituito da minoranze razziali ed etniche, e secondo il 2020 Cooperative Election Study di Harvard quasi il 30% degli elettori non bianchi nelle comunità rurali ha votato per Donald Trump, mentre viene spesso ignorato il fatto che la maggioranza degli indigeni americani viva in aree rurali e che la maggior parte delle terre tribali sovrane siano rurali). In termini di parte, i Democratici al Senato, che attualmente detengono 51 seggi al Senato, rappresentano circa 193 milioni di persone. I Repubblicani al Senato hanno solo due seggi in meno, ma rappresentano 140 milioni di persone.
In 255 pagine, gli autori sostengono che gli americani delle zone rurali sono il gruppo “geodemografico” più razzista, xenofobo, anti-immigrazione, omofobo, cospirazionista, antidemocratico, suprematista bianco e nazionalista cristiano bianco (il 76% dell’America rurale è bianco e il 38% dell’America rurale è bianco evangelico fondamentalista), e violento del Paese. Secondo loro, queste caratteristiche rendono gli elettori bianchi rurali una «minaccia unica per la democrazia americana», perché hanno un peso sproporzionato alle urne rispetto a qualsiasi altro gruppo demografico negli Stati Uniti. Sottolineano come le strutture politico-istituzionali – la rappresentanza di 2 senatori per ciascuno Stato al Senato federale a prescindere dalla popolazione (nonostante gli Stati rurali siano decisamente meno popolati), quella alla Camera federale (pesantemente condizionata dalla pratica del gerrymandering e dal fatto che i distretti elettorali puramente rurali o con influenza rurale/suburbana rappresentano il 42% dei seggi, anche se ci sono più persone che vivono nelle città; le aree urbane più popolose hanno la metà della rappresentanza alla Camera rispetto ai distretti elettorali rurali), come quella al Collegio elettorale nazionale (che si basa sul numero di seggi alla Camera e su due senatori in ogni Stato, per cui il Wyoming ha 18 voti elettorali in meno rispetto alla California, anche se la California ha una popolazione 68 volte più numerosa) sono fortemente squilibrate in favore di Stati e aree rurali spopolate dominate dal Partito repubblicano – favoriscono la sovra rappresentazione dei bianchi rurali che costituiscono solo il 16% dell’elettorato americano (tra l’altro circa il 24% dell’America rurale è costituito da minoranze razziali ed etniche, e secondo il 2020 Cooperative Election Study di Harvard quasi il 30% degli elettori non bianchi nelle comunità rurali ha votato per Donald Trump, mentre viene spesso ignorato il fatto che la maggioranza degli indigeni americani viva in aree rurali e che la maggior parte delle terre tribali sovrane siano rurali). In termini di parte, i Democratici al Senato, che attualmente detengono 51 seggi al Senato, rappresentano circa 193 milioni di persone. I Repubblicani al Senato hanno solo due seggi in meno, ma rappresentano 140 milioni di persone.
White rural rage è un messaggio lanciato contro un bersaglio familiare dell’ira dell’élite liberal statunitense che accusa i bianchi delle zone rurali di rendere vulnerabile la democrazia americana, perché questa sezione territoriale dell’elettorato americano ha progressivamente abbandonato il Partito Democratico in favore del Partito Repubblicano dominato da Trump e dal trumpismo. Sostiene che il problema alla radice della politica odierna statunitense ricade sulle spalle dei bianchi rurali. Nonostante ciò, o forse proprio per questo, gli autori sono apparsi al popolare talk-show Morning Joe, il libro ha ispirato un articolo di approvazione da parte di Paul Krugman sulle colonne del New York Times, e la sua tesi è stata argomento di discussione sui podcast, da Chuck Todd della MSNBC a quello del conduttore di destra Charlie Kirk. In breve tempo, il libro è diventato un best seller nella lista del New York Times, che lo descrive come «Un ritratto bruciante e un’accusa schiacciante dei cittadini più orgogliosi dell’America, che sono anche quelli meno propensi a difenderne i principi fondamentali» (il riferimento è ai principi della “più antica democrazia costituzionale del mondo”, un tema epitomato dalla frase “I love my country, but not our country”, “amo il mio paese, ma non il nostro paese”).
Il libro ha innescato una reazione negativa nei confronti degli elettori rurali da parte di alcuni a sinistra. Amanda Marcotte, scrivendo per Salon, ha detto che è stanca di trattare gli elettori rurali «con i guanti» ed è giunto il momento di far scoppiare la «bolla razzista, omofobica e sessista» in cui vivono (ma il razzismo esiste in tutte le parti del Paese ed è profondamente radicato nella società e politica americana). L’editorialista del Daily Beast Michael Cohen è d’accordo, scrivendo che «questi non sono stereotipi offensivi ed elitari degli abitanti del Corridoio Acela [l’alta velocità che collega Boston-New York-Washington] e dei liberali che vivono in bolle… sono fatti». David Corn, capo dell’ufficio DC di Mother Jones, ha ribadito, concordando sul fatto che «gli elettori rurali bianchi [sono] quella fetta di pubblico che mette in pericolo il futuro costituzionale della repubblica».
Ma il libro ha anche acceso una controversia nel mondo accademico. Nelle settimane successive alla sua pubblicazione, tre recensioni scritte da degli scienziati politici hanno accusato Schaller e Waldman di aver commesso ciò che equivale a negligenza accademica, sostenendo che gli autori hanno utilizzato metodologie scadenti, dati interpretati male e studi distorti per suffragare le loro accuse sui bianchi rurali di costituire la più grande minaccia alla democrazia americana. Schaller e Waldman hanno ammesso che «siamo rimasti sorpresi dalla ferocia delle critiche che abbiamo ricevuto da parte degli studiosi di politica rurale».
I critici sostengono che la vera minaccia è che stereotipi scarsamente supportati e dannosi creeranno un cuneo più profondo tra l’America rurale e quella urbana. Accusano gli autori di aver preconfezionato la loro tesi e poi di essere andati a cercare ciò che volevano vedere, con un uso selettivo di dati, sondaggi e ricerche, e con poca o nessuna attenzione prestata alla verità. Sostengono che gli studiosi di politica nelle aree rurali sono sempre più attenti all’idea che la “rabbia” non è la stessa cosa del risentimento, dell’ansia economica, dell’orgoglio comunitario e del senso del luogo, mentre Schaller e Waldman vogliono semplicemente che l’America rurale venga considerata la terra dell’estremismo radicale. Notano che anche quando gli autori arrivano ad una conclusione benevola sul rafforzamento della comunità rurale, hanno così travisato e diffamato le popolazioni rurali che nessuno nelle campagne può (o dovrebbe) fidarsi di loro, e nessuno nell’America urbana troverà utile preoccuparsi di una desolata terra di odio.
Le accuse contro “White rural rage”
Un primo problema che viene evidenziato è che nella stragrande maggioranza dei dati utilizzati dagli autori manca una definizione coerente di cosa si intenda con la parola “rurale”. Questo buco dà agli autori la licenza di scegliere vari risultati da qualunque sondaggio e ricerca vogliano, senza riguardo per ciò che quegli studi dicono sulle popolazioni rurali – se, in effetti, gli studi si preoccupano di definire rurale in primo luogo.
Tra i tanti esempi, viene citato un metodo della società di sondaggi Ipsos, che informa il lavoro del Public Religion Research Institute (Prri) che Schaller e Waldman utilizzano per dimostrare che le popolazioni rurali sono particolarmente attratte dalle cospirazioni di QAnon. Ipsos definisce rurale qualsiasi residente che vive in una contea che non fa parte di alcuna area statistica metropolitana (un luogo con un centro urbano denso di 50mila persone o più). Il Censimento, tuttavia, stima che il 54% di tutta la popolazione rurale viva effettivamente all’interno di quelle aree “metropolitane” – aree escluse dalla definizione Ipsos. Di conseguenza, questo risultato sull’“America rurale” è tratto da un sondaggio che esclude la maggioranza dei residenti rurali. Ci si chiede se gli autori si siano preoccupati di pensare a cosa questo significhi effettivamente per i loro risultati.
In secondo luogo, viene fatto notare che Schaller e Waldman sembrano trascurare intenzionalmente qualsiasi preoccupazione relativa alle dimensioni e alle caratteristiche demografiche (ad esempio, le classi di età o il sesso) del campione. Nella maggior parte dei casi, i sondaggi che informano il libro semplicemente non ottengono un numero sufficiente di intervistati che provengano anche da zone rurali, comunque definite. È vero, gli organi di indagine riporteranno ciò che hanno detto gli individui “rurali”, ma uno sguardo più attento mostra che quelle stime rurali spesso si basano solo su poche centinaia di persone. La piccola dimensione del campione introduce quantità crescenti di incertezza ed errore. Più piccolo è il campione, maggiore è il margine di errore. Quando questi margini diventano troppo grandi, è impossibile utilizzare le risposte con certezza statistica. Da questo punto di vista, viene citato un sondaggio dell’Institute of Politics dell’Università di Chicago, a cui fanno riferimento Waldman e Schaller per dimostrare che gli americani delle zone rurali sono i più propensi a “prendere le armi contro il governo”. Tale affermazione dipende solo da 220 residenti rurali e 290 residenti urbani. Pertanto, se il 35% dei residenti rurali è d’accordo e il 29% dei residenti urbani è d’accordo, probabilmente sono indistinguibili l’uno dall’altro.
Schaller e Waldman utilizzano un altro sondaggio della Marist University che secondo loro dimostra il fatto che i residenti rurali hanno maggiori probabilità di credere in una frode elettorale inesistente. Questa conclusione dipende da un totale complessivo di 167 individui rurali. Non solo i margini di errore sono troppo grandi per essere significativi, ma ci si chiede se è possibile ottenere un ritratto rappresentativo dell’America rurale con così poche persone. Il terzo problema è che la maggior parte dei sondaggi vengono condotti per ottenere un quadro rappresentativo della popolazione nazionale, per cui anche quando dispongono di campioni di dimensioni adeguate, raramente gli intervistati rurali nel sondaggio rappresentano effettivamente i dati demografici dell’America rurale. Due dei casi più eclatanti del libro si verificano quando gli autori si basano su un sondaggio condotto in soli due Stati per avanzare la pretesa sul birtherismo (la teoria che afferma che Barak Obama non sia nato negli Usa) nell’America rurale e quando presentano un sondaggio sui residenti in soli nove Stati, che collettivamente rappresentano solo il 31% della popolazione rurale americana.
Solo due sondaggi nell’intero libro sono considerati conformi agli standard di base della ricerca e tentano addirittura di presentare un quadro accurato dell’America rurale: uno studio del 2017 del Washington Post e della Kaiser Family Foundation (1.070 residenti rurali) e un rapporto del 2018 del Pew Research Center (2.085 residenti rurali) – uno studio, tra l’altro, che mostra che la maggioranza degli americani rurali credono che «i bianchi beneficiano di vantaggi nella società che i neri non hanno», che «ci sono ancora ostacoli significativi che rendono più difficile per le donne andare avanti rispetto agli uomini», che ci sono, effettivamente, «situazioni in cui l’aborto dovrebbe essere consentito» e che rifiutano l’idea che un Paese a maggioranza non bianca sarebbe “cattivo” per l’America. Tutti dati che non supportano la tesi degli autori relativa alla “rabbia rurale bianca”.
Ma nemmeno questi sondaggi sono esenti da critiche. Poiché si concentra sulle comunità rurali, lo studio WAPO/KFF include solo 303 intervistati urbani e 307 suburbani: dei campioni troppo piccoli. Questo comporta serie implicazioni quando si interpreta chi pensa che «gli immigrati oggi rafforzano il nostro Paese», una delle domande che Schaller e Waldman usano per mostrare quanto presumibilmente siano xenofobe le popolazioni rurali. Una volta tenuto conto del margine di errore (che Schaller e Waldman non riportano mai nel libro), i residenti rurali credono effettivamente la stessa cosa dei residenti suburbani; infatti, in una domanda precedente (ma non menzionata dagli autori), l’indagine mostra che i residenti rurali hanno la stessa probabilità dei residenti urbani di affermare che «la maggior parte degli immigrati arrivati negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni stanno facendo abbastanza per adattarsi allo stile di vita americano».
Un ultimo problema viene considerato il peggiore perché esiste anche se si tiene conto dei problemi legati alla definizione della ruralità e all’ottenimento di campioni ampi e rappresentativi. In tutto il libro, Schaller e Waldman si affidano esclusivamente a confronti di gruppo – una vera indicazione, secondo i critici, che la loro analisi è guidata più dal desiderio di confermare le proprie convinzioni che di trovare prove reali della “rabbia rurale”. In effetti, nel libro non si cerca di capire cosa spinge le popolazioni rurali, in particolare, a pensare una cosa o l’altra. Per cui, alla fine, ci si interroga se si tratta davvero di problemi rurali o se sono il prodotto di qualche altra caratteristica demografica come l’età, la razza o il genere. La “rabbia” presumibilmente sentita nelle zone rurali è davvero diversa che altrove? Non è possibile dirlo solo in base alle medie di gruppo.
Schaller e Waldman, ad esempio, sono preoccupati per l’aumento delle convinzioni sulla teoria della cospirazione di QAnon. Utilizzando l’American Values Survey 2021 del Prri (lo stesso che esclude la maggior parte degli intervistati rurali), basano le loro affermazioni sulla rabbia rurale sul fatto che il 24% dei residenti rurali crede in QAnon. La rabbia c’è, dicono, perché è sproporzionatamente più alta rispetto al 17% degli americani che vivono in zone rurali, come stimato dal Prri (è possibile che siano statisticamente gli stessi, ma i dati per calcolare il margine di errore non sono divulgati). Tuttavia, il problema è che, anche solo da questo semplice confronto, concludono che il mondo rurale è estremo; il mondo rurale è il focolaio di QAnon; il mondo rurale è una terra pericolosa. Ma la stragrande maggioranza dei residenti rurali non crede alle cospirazioni di QAnon. E ci sono più di tre volte più credenti di QAnon al di fuori dell’America rurale.
Lo stesso errore viene commesso in relazione all’assunzione di vaccini. I neri americani sono quelli che hanno meno probabilità di essersi vaccinati contro il CoVid-19. Qualunque sia la ragione di questo fenomeno, nessuno salterebbe da quella constatazione per dire che «la vera minaccia alla salute pubblica deriva dal rifiuto dei neri americani di farsi il vaccino. Sono il gruppo con meno probabilità di ottenerlo». Sappiamo che questa affermazione non ha senso perché i neri americani non vaccinati rappresentano una percentuale così piccola della popolazione non vaccinata (proprio come quella rurale). Inoltre, i bassi tassi di vaccinazione potrebbero in realtà avere poco a che fare con la razza di per sé, ma essere invece la conseguenza di altri fattori che sappiamo essere associati alla diffusione del vaccino e alla razza, come il reddito o l’istruzione.
Coloro che criticano Schaller e Waldman, sostengono che quando includiamo le caratteristiche sociodemografiche – età, sesso, livello di istruzione, appartenenza a un partito, reddito, razza, credenze religiose – in un modello che tiene conto anche del luogo in cui qualcuno vive, le differenze geografiche scompaiono. Statisticamente i residenti rurali non sono più propensi ad avere convinzioni “xenofobiche” a causa della loro ruralità. Su un tema come questo gli atteggiamenti sono quasi interamente riconducibili all’identità partigiana. Il fatto di essere rurale non aggiunge nulla alla spiegazione. È statisticamente privo di significato, perché ciò che guida queste medie di gruppo è esclusivamente una funzione dell’identità politica partigiana repubblicana. Cioè, i residenti rurali pensano a questo problema – come a razzismo, omofobia, violenza politica, nazionalismo bianco – allo stesso modo dei residenti urbani e suburbani.
Se l’obiettivo di White rural rage è affermare che la minaccia alla democrazia americana proviene dal cuore rurale del Paese, i dati semplicemente non supportano tale idea. La variabile rilevante è essere repubblicani, non essere persone che vivono in zone rurali.
Le cause del malcontento degli elettori delle zone rurali
Diversi studiosi hanno ripetutamente dimostrato che esiste una differenza tra elettori rurali e urbani, e non si tratta di “rabbia”, razzismo, xenofobia o omofobia, ma più propriamente di “risentimento” che deriva da offese reali e percepite nei confronti delle comunità rurali.
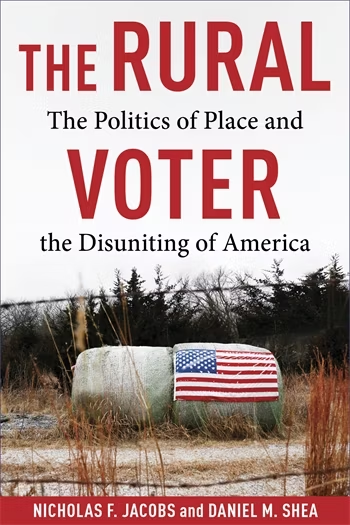 È quello che sostengono, ad esempio, Nicholas F. Jacobs e Daniel M. Shea, due professori del Colby College, nel libro The rural voter. The politics of place and the disuniting of America (Columbia University Press, New York 2023), le cui analisi sono sviluppate a partire da campioni realmente rappresentativi di 10mila abitanti delle zone rurali americane. Spinti dai dati e preoccupati della loro qualità, trovano che c’è una ragione particolare per cui così tanti residenti rurali trovano Donald J. Trump attraente e si sono spostati verso il Partito Repubblicano. Si sentono inascoltati, traditi, abbandonati, trattati ingiustamente, denigrati. Si preoccupano per il futuro delle loro comunità e per la necessità che i loro figli se ne debbano andare verso le aree urbane per vivere delle vite produttive. Sono preoccupati che i modi di vivere rurali saranno presto costretti a scomparire.
È quello che sostengono, ad esempio, Nicholas F. Jacobs e Daniel M. Shea, due professori del Colby College, nel libro The rural voter. The politics of place and the disuniting of America (Columbia University Press, New York 2023), le cui analisi sono sviluppate a partire da campioni realmente rappresentativi di 10mila abitanti delle zone rurali americane. Spinti dai dati e preoccupati della loro qualità, trovano che c’è una ragione particolare per cui così tanti residenti rurali trovano Donald J. Trump attraente e si sono spostati verso il Partito Repubblicano. Si sentono inascoltati, traditi, abbandonati, trattati ingiustamente, denigrati. Si preoccupano per il futuro delle loro comunità e per la necessità che i loro figli se ne debbano andare verso le aree urbane per vivere delle vite produttive. Sono preoccupati che i modi di vivere rurali saranno presto costretti a scomparire.
Negli ultimi decenni, nelle zone rurali si è formata una nuova identità politica che combina un senso del luogo profondamente sentito con una serie di preoccupazioni sempre più nazionalizzate (dal declino economico-politico degli Stati Uniti alla diminuzione della fiducia nelle istituzioni, alla polarizzazione partitica). Jacobs e Shea sostengono che la percezione del cambiamento economico e sociale, le ansie razziali e uno stile di vita tradizionale sotto attacco siano confluiti nella convinzione dell’unicità e della separatezza rurale. L’America rurale crede di poter crescere e cadere insieme con una visione del mondo del tipo “noi contro loro” (con “loro” identificati nelle grandi città, i politici di Washington, i burocrati pubblici, il governo federale) e che il Partito Democratico sia un ostacolo. Gli elettori rurali non danno credito ai Democratici per quello che fanno per loro. L’identità politica rurale si è trasformata in risentimento (ma non in “rabbia”), un risentimento collettivo contro esperti, burocrati, intellettuali e il partito politico che cerca di conferire loro potere, i Democratici. Finora, i Repubblicani sono il partito politico che ha capito come parlare in modo efficace a quell’identità rurale utilizzando leve emozionali – parlando della resilienza, dei valori e dell’orgoglio dei residenti rurali. Certamente, il Gop fa appello a coloro che vogliono preservare i benefici sociali ed economici che il colore bianco della pelle conferisce, o ripristinare la perdita di privilegi portata da una popolazione sempre più diversificata. I repubblicani assecondano gli elettori rurali con una “autenticità” fabbricata e anche con false manifestazioni di credibilità rurale – e vincono.
Dopo il 2016, quando gli elettori rurali di Wisconsin, Michigan e Pennsylvania hanno messo in primo piano l’ex presidente Donald Trump (il Wisconsin è il ventesimo stato più rurale; un quarto del Michigan è rurale; la Pennsylvania viene caratterizzata come Filadelfia a est, Pittsburgh a ovest e Alabama al centro), i Democratici hanno cercato di capire perché si fossero inaspriti così tanto nei confronti del Partito Democratico. L’aggravarsi della crisi nelle zone rurali è diventata una sorta di preoccupazione per i media nazionali e i principali analisti liberal. All’improvviso l’America rurale è apparsa come una spiaggia esotica lontana, una terra di strani costumi, di gente arretrata e di barzellette poco divertenti. I giornalisti nazionali hanno pranzato nei diners delle comunità rurali e hanno inviato articoli dalle manifestazioni di Trump. Gli esperti hanno scritto innumerevoli articoli sui grandi organi della stampa mainstream con titoli come “Perché l’America rurale ha votato per Trump”, “Populista dell’attico: perché i poveri delle zone rurali amano Donald Trump” e “Spiegare il divario politico tra città e campagna”.
Il paradosso è che tutta questa attenzione dei grandi media mainstream si è manifestata mentre il giornalismo locale è entrato in una crisi terminale nelle zone rurali. La gran parte di giornali ed emittenti radiofoniche locali ha chiuso o sta chiudendo. Non riescono più ad avere utili decenti. Pertanto, i residenti della Middle America non ricevono informazioni e notizie su ciò che avviene nelle loro comunità, nel consiglio comunale, nel comitato scolastico, nell’ufficio del sindaco. Intere comunità rurali di tutto il Paese sono state abbandonate a sé stesse, riflettendo la crescente polarizzazione tra aree ricche e/o in crescita e aree povere e/o in declino, perché si è creato un “grande deserto informativo”, con un accesso limitatissimo alle news locali, in cui vive più di un quinto dei cittadini del paese.
Il successo di Trump nelle aree rurali e tra i bianchi senza istruzione universitaria ha generato un mercato di libri che cercavano di spiegare le aree lontane dalle due coste. L’infatuazione per Hillbilly elegy di JD Vance è stata l’esempio più ovvio, ma opere più sofisticate – tra cui Strangers in their own land. Anger and mourning on the American right di Arlie Russell Hochschild, White trash. The 400-year untold history of class in America di Nancy Isenberg, e What you are getting wrong about Appalachia di Elizabeth Catte – divennero dei best seller.
Alcuni pensatori liberal hanno denunciato la condiscendenza riflessiva e la liquidazione da parte della sinistra liberal degli elettori rurali che si sono intensificate durante l’amministrazione di George W. Bush e hanno raggiunto il culmine con la campagna di Hillary Clinton, che guidava uno schieramento progressista neoliberista e globalizzatore, e la sua bollatura dei sostenitori rurali di Trump come un “cestino di deplorevoli”. Alcuni hanno sostenuto che il Partito Democratico – che comunque anche nelle contee rurali più rosse (repubblicane) prende dal 20 al 30% dei voti – dovrebbe aumentare l’attenzione alle questioni e alle comunità rurali. Nel 2020 Biden ha ottenuto solo il 28% del blocco elettorale bianco rurale, ma ciò equivale a più di 9 milioni di voti che se fossero andati a Trump avrebbero consentito la sua rielezione (Trump ha ottenuto l’80% dei suoi voti totali dai residenti delle città e delle aree residenziali suburbane, ma ha vinto circa il 90% delle contee rurali). Biden aveva vinto a livello nazionale con circa 7 milioni di voti e conquistato molti Stati indecisi con margini minimi. Ora, il successo di White rural rage nei circoli progressisti esprime l’ondata di frustrazione e disperazione dei Democratici nei confronti dell’America rurale che potrebbe sembrare catartica per i liberal, ma servirà solo a emarginare e demonizzare ulteriormente un segmento della popolazione americana che già si sente dimenticato e respinto dagli esperti, dai funzionari del governo federale e dalle élite.
La questione cruciale è il divario strutturale sempre più ampio tra l’America rurale e quella urbana. Le comunità rurali, proprio come i quartieri svantaggiati nelle aree urbane, soffrono di decenni di sottoinvestimenti pubblici e privati: di uno scarso accesso all’assistenza sanitaria (dovuto alla chiusura degli ospedali locali e alla carenza di operatori sanitari) e all’istruzione scientifica ed accademica (mancano finanziamenti e insegnanti nelle scuole), di infrastrutture carenti e di gravi perdite di posti di lavoro nel settore manifatturiero e agricolo. Buona parte delle zone rurali sono diventate dei «left-behind places» perché non hanno avuto accesso a capitale, investimenti pubblici, moderne infrastrutture di trasporto e rete a banda larga che avrebbero potuto creare nuove opportunità economiche in loco. Inoltre, sono molto visibili le cicatrici lasciate dalle politiche federali sul territorio – dalla politica sull’uso della terra agli accordi di libero scambio fino ai fallimentari programmi di riqualificazione della forza lavoro. L’America rurale è in un profondo decadimento economico e sociale, definito dal calo dei bassi salari, dall’aumento della disoccupazione, dalla povertà persistente e dall’aumento della dipendenza dal governo. Le popolazioni rurali stanno invecchiando mentre le generazioni più giovani fuggono da aree con poche opportunità economiche e visioni del mondo sempre più ristrette. Coloro che rimangono nelle zone rurali vivono una vita più breve, hanno un accesso limitato all’assistenza sanitaria e, su tutti i parametri sanitari – dalla mortalità materna alle morti causate da overdose da oppioidi (sulla pandemia da oppioidi, si vedano i nostri articoli qui e qui) – hanno un tasso più alto di qualsiasi altro gruppo geografico. In molte grandi aree geografiche con poca popolazione, le persone vivono con un accesso ragionevole a un solo ospedale, o addirittura a un singolo operatore sanitario. La mancanza di concorrenza nelle aree rurali è una delle ragioni cruciali per cui l’Obamacare non è riuscito a contenere i costi sanitari. E questo accadeva prima della pandemia, che ha causato la chiusura definitiva di un numero record di ospedali rurali.
Le condizioni di svantaggio hanno contribuito a determinare la nuova identità politica e lo spostamento verso il Partito Repubblicano dei residenti nelle aree rurali, creando il divario politico attualmente più grave negli Stati Uniti. Il sostegno ai Democratici è crollato in tutte le ultime campagne elettorali. C’è qualcosa di particolare nell’attrattiva di Trump nell’America rurale e che i dati demografici da soli non spiegano. Nell’America rurale, i bianchi senza istruzione universitaria e le donne hanno maggiori probabilità di votare per Trump; questo riguarda anche i giovani, i poveri come i ricchi. Ora, in vista delle prossime elezioni di novembre, l’intero sistema di governo è minacciato dal predominio di un partito unico (quello Repubblicano) che, con il sostegno dei grandi media conservatori, si appoggia su questo blocco elettorale delle zone rurali, ne sfrutta il risentimento e lo usa come arma per far avanzare un’agenda di estrema destra.
Risentimento, scomposizione e ricomposizione sociale nelle aree rurali
Certamente, come scrivono Schaller e Waldman, «I liberal di Hollywood non hanno distrutto l’azienda agricola di famiglia, i professori universitari non hanno trasferito i posti di lavoro del settore manifatturiero all’estero, gli immigrati non hanno diffuso oppioidi nelle comunità rurali e la teoria critica della razza non ha chiuso centinaia di ospedali rurali. Quando i politici repubblicani e i media conservatori dicono ai bianchi rurali di rivolgere la loro rabbia verso questi obiettivi, è per non chiedersi perché le persone che continuano a eleggere non hanno fatto nulla per migliorare la vita nelle loro comunità». Le popolazioni rurali sanno che le élite liberal sono rimaste a guardare mentre gli studenti rurali diventavano uno dei gruppi con meno probabilità di frequentare l’università e uno di quelli con maggiori probabilità di abbandonare gli studi. Inoltre, le popolazioni rurali sanno che le politiche agricole e commerciali federali promosse da Democratici e Repubblicani hanno distrutto molte delle economie rurali, dando campo libero al consolidamento di un ristretto numero di mega aziende agroindustriali oligopolistiche (da Tyson Foods a Cargill e ad altri pochi giganti dell’agribusiness e dell’agricoltura industriale con il corollario di pesticidi, mietitrebbie, fertilizzanti e tecnologie per le sementi geneticamente modificate) che si accaparrano la terra e utilizzano le zone rurali per estrarre enormi quantità di valore. Basti considerare le conseguenze dell’Accordo di libero scambio nordamericano, entrato in vigore nel 1994 (durante l’amministrazione Clinton). I sostenitori del Nafta, sia Democratici sia Repubblicani, avevano promesso che l’accordo avrebbe portato prosperità ai piccoli agricoltori, ma tra il 1998 e il 2018, 1 su 10 delle piccole aziende agricole statunitensi è scomparso. Non molto tempo dopo la rimozione delle barriere commerciali, gli allevatori di bestiame canadesi inondarono il mercato statunitense con carne di manzo, burro e formaggi e i prezzi crollarono, costringendo le piccole aziende agricole a chiudere l’attività. Nel frattempo, le grandi imprese agricole e agroindustriali hanno tratto vantaggio dall’apertura dei confini.
Un secolo fa c’erano più di 6 milioni di agricoltori; oggi ne rimangono meno di 750 mila. Eppure da allora la produzione agricola degli Stati Uniti è quadruplicata, mentre il totale degli acri coltivati è diminuito solo leggermente. Oggi, i produttori agricoli, dovendo competere su un palcoscenico globale, si trovano ormai ad affrontare forti pressioni concorrenziali per abbassare il prezzo delle loro materie prime al fine di mantenere la loro quota di mercato. Questo processo polarizza gli agricoltori tra coloro che possono competere con successo realizzando un profitto e coloro che devono fare affidamento sui sussidi federali per mantenere la propria posizione competitiva. Per questi ultimi, il risentimento cresce insieme alla dipendenza. Di fronte alla realtà di diventare essi stessi proletari, gli agricoltori aumentano la resa dei raccolti attraverso i fertilizzanti azotati, impoveriscono la vita dei lavoratori agricoli attraverso bassi salari stagnanti e continuano a coltivare i raccolti secondo i capricci del mercato piuttosto che secondo i bisogni umani. Nel frattempo, l’età media degli agricoltori si avvicina ai sessant’anni, sollevando la questione di chi prenderà il loro posto nei decenni a venire.
Occorre provare a ragionare sulla scomposizione e ricomposizione sociale ed economica che si è verificata nelle comunità rurali negli ultimi decenni. Oggi, insieme alla presenza di un potente ristretto gruppo oligopolistico di grandi aziende dell’agribusiness, c’è una classe di élite locali che possiede il prezioso terreno agricolo che circonda una tipica cittadina. I proprietari di beni fisici – franchising di fast food, complessi di appartamenti, concessionari di automobili – costituiscono il resto di questa ridotta gerarchia. Siedono nei consigli di amministrazione delle associazioni locali senza scopo di lucro, gestiscono la camera di commercio e sono membri influenti delle loro chiese. Spesso ricoprono cariche elettive e votano molto spesso per il Partito Repubblicano. Una classe di persone che è stata definita una “piccola nobiltà rurale” (gentry) americana: oligarchi locali, con la ricchezza più spesso legata a beni materiali locali che a hedge fund. A questa “piccola nobiltà rurale” mancano gli emblemi familiari di estrema ricchezza; queste non sono persone con attici di lusso, uffici a Wall Street, ricchezza accumulata nella finanza globale e conti bancari offshore. Ma a livello locale o regionale, essi detengono un notevole potere economico e sono sproporzionatamente responsabili della gestione politica delle aree rurali.
Esclusi dalla “piccola nobiltà rurale” sono la stragrande maggioranza dei cittadini rurali. Il messaggio politico di entrambi i principali partiti tende a glorificare l’America rurale come piena di piccole fattorie e piccoli agricoltori. In realtà, secondo il censimento del 2020, l’agricoltura americana dipende enormemente dai sussidi governativi e dalle agevolazioni fiscali, mentre l’istruzione, l’assistenza sanitaria, l’industria manifatturiera e la vendita al dettaglio impiegano più lavoratori delle zone rurali rispetto all’agricoltura.
Per quanto riguarda tutti quei terreni agricoli – centinaia di milioni di acri a livello nazionale – sono sempre più detenuti, oltre che dalla “piccola nobiltà rurale”, da ricchi e potenti esterni. Come riportato da Mother Jones, negli ultimi anni investitori istituzionali come Prudential, Hancock e Tiaa hanno acquistato enormi quantità di terreni agricoli. Il più grande proprietario di terreni agricoli americani, però, è Bill Gates, con circa 109mila ettari sparsi in 12 Stati, secondo l’Associated Press. I suoi piani per la terra non sono chiari, ma gli incentivi finanziari sono evidenti. Con la crisi climatica destinata a ridurre drasticamente la quantità di terra coltivabile, Gates probabilmente considera questa imminente scarsità come un investimento intelligente.
La politica agricola federale ha facilitato questi cambiamenti sotto forma di grandi sussidi ed enormi progetti di infrastrutture idriche finanziati con fondi pubblici, che hanno reso possibile l’irrigazione su larga scala nelle regioni aride. Nel 1973, mentre i prezzi globali dei cereali aumentavano vertiginosamente, il ministro dell’agricoltura di Richard Nixon, Earl Butz, disse agli agricoltori di “diventare grandi o uscire”. Negli anni 80, i prezzi delle materie prime erano diminuiti, mettendo in pericolo gli agricoltori che si erano indebitati per diventare grandi, come da istruzioni governative. La siccità ha aggravato queste difficoltà. Al culmine della crisi agricola, più di 500 proprietà agricole venivano vendute ogni mese alle aste di pignoramento. Nel 1985, il numero di banche agricole che fallirono fu superiore a qualsiasi anno successivo alla Grande Depressione, e alla fine del decennio centinaia di migliaia di agricoltori erano inadempienti sui loro prestiti. Durante le loro proteste indossavano sacchetti di carta sopra la testa per nascondere il volto ai creditori.
Nessuno dei due principali partiti ha fatto molto per fermare la crisi. Forse la voce più importante a difesa degli interessi dei piccoli agricoltori fu Jesse Jackson, che si candidò alla presidenza nel 1984 e di nuovo nel 1988, quando vinse 11 Stati alle primarie democratiche. Il suo successo ha scioccato l’establishment del partito. Prendendo come ispirazione diretta la campagna per i poveri di Martin Luther King Jr., Jackson cercò di costruire un movimento ad ampio raggio che enfatizzasse gli ostacoli specifici che devono affrontare i neri americani, coinvolgendo al tempo stesso gli agricoltori in difficoltà sotto la bandiera di un interesse economico condiviso. In una manifestazione del 1985 nelle zone rurali del Missouri, Jackson riunì agricoltori bianchi arrabbiati, sostenitori neri di Kansas City e sindacalisti locali per tentare di fermare il pignoramento e la vendita di una fattoria familiare di 120 acri. «Questa è una coalizione arcobaleno per la giustizia economica», disse Jackson alla folla. Alla fine, la fattoria fu venduta, Jackson perse le primarie e Ronald Reagan pose il veto a un pacchetto di aiuti per gli agricoltori, anche se alla fine avrebbe firmato un disegno di legge agricolo che includeva aiuti in denaro.
Nel libro del 1986 Prisoners of the American dream. Politics and economy in the history of the US working class Mike Davis collega il «consolidamento delle cittadelle locali del potere capitalista su base statale o municipale» in questo periodo all’ascesa di Reagan. Negli anni 70, la partecipazione degli elettori crollò bruscamente, un modello che per lo più si è sgretolato lungo le linee di classe. Secondo il Pew Research Center, coloro che percepivano il reddito più basso avevano sostanzialmente maggiori probabilità di non votare, il che è vero anche oggi. Nel frattempo, i ceti medi e alti sono diventati più coinvolti politicamente, lanciandosi in campagne monotematiche come la politica del bussing (utilizzata per l’integrazione razziale scolastica) e l’aborto, e finanziando l’emergere dei Business Pacs.
In altre parole, quando le forze economiche hanno distrutto le comunità rurali, coloro che sono rimasti indietro sono diventati meno propensi a partecipare a un sistema che non li ha aiutati. Coloro che ne hanno beneficiato, naturalmente, hanno continuato a ritenere utile la politica elettorale. I membri della “piccola nobiltà rurale” divennero i cosiddetti “elettori medi” e donatori frequenti, dando forma a un sistema che li arricchiva punendo i loro vicini.
Il successivo grande tentativo del Partito Democratico di consolidare la sua posizione nell’America rurale non sarebbe arrivato prima di due decenni. Durante la sua prima campagna, Barack Obama unì discorsi di speranza e cambiamento con aspre critiche ai monopoli e agli accordi commerciali come il Nafta. I Democratici non parlavano così da prima dell’amministrazione Clinton. Ha promesso di “rafforzare le leggi anti-monopolio” e di combattere il consolidamento dei mercati nei settori agricoli, e il profitto politico ottenuto è stato sostanziale. Non solo Obama ha fatto il pieno di voti nella Rust Belt, ma ha anche conquistato l’Iowa e la Carolina del Nord. Ha perso il Missouri per soli 0,13 punti percentuali, un margine impensabile per un democratico oggi (nel 2020 Trump ha vinto con il 56,8%).
È facile capire perché il messaggio anti-monopolio di Obama abbia preso piede. Per fare un esempio, nel 2010 alcune grandi aziende come Tyson Foods e Perdue controllavano oltre il 90% dell’industria del pollame. Gli agricoltori, teoricamente indipendenti, erano soggetti ai capricci dei grandi confezionatori di polli, che offrivano contratti semplici che bloccavano prezzi bassi, imponevano agli agricoltori di acquistare costantemente nuove tecnologie e negavano loro il diritto di negoziare con altri acquirenti. Spesso gli agricoltori non possedevano nemmeno i polli che allevavano. Tutto ciò rimane vero anche oggi. L’amministrazione Obama ha cercato di impedire un simile consolidamento nella produzione di carne bovina. Il settore stava andando verso la concentrazione, con alcune grandi aziende confezionatrici di carne che espandevano costantemente il loro controllo su centinaia di migliaia di piccoli produttori di bestiame indipendenti. C’era un senso di speranza che qui, finalmente, ci fosse un’amministrazione che avrebbe preso il sopravvento sul settore. Il Dipartimento dell’Agricoltura di Obama ha tenuto incontri pubblici in tutto il Paese per ascoltare allevatori e agricoltori. Ha proposto regole che avrebbero protetto gli agricoltori da contratti ingiusti, in modo che avrebbero potuto cercare di negoziare prezzi migliori per i loro prodotti, e una più forte applicazione del Packers and Stockyards Act del 1921, una legge che aveva rotto i monopoli della carne nella Gilded Age. Questo sarebbe stato l’apice della riforma agricola di Obama, dando all’Usda una vera forza nel prevenire le fusioni e ritenere le aziende responsabili di comportamenti anticoncorrenziali. Ma lo sforzo è servito a ben poco.
La National Cattlemen’s Beef Association e i grandi gruppi industriali hanno aumentato la pressione lobbistica e il Congresso ha ripetutamente bloccato l’applicazione più rigorosa dell’Usda nei confronti delle aziende. Solo nell’ultimo anno di Obama, il Congresso ha finalmente approvato una normativa che rafforzava i poteri antitrust dell’Usda. Poi, con Trump, gli alleati delle corporation dell’agribusiness sono stati messi ai vertici dell’Usda, che ha prontamente respinto una norma che rendeva più facile per i piccoli agricoltori citare in giudizio i grandi confezionatori di carne e declassò l’ufficio antitrust indipendente dell’agenzia a una suddivisione del Servizio di marketing agricolo.
Oggi, le “Big Four” – Tyson, Cargill, National Beef e JBS – controllano circa l’85% dell’industria della carne bovina e queste società sono accusate da una parte degli allevatori di cospirare illegalmente per fissare prezzi artificialmente bassi, portando i produttori indipendenti alla bancarotta anche se i prezzi della carne bovina per i consumatori sono aumentati vertiginosamente.
Questi problemi di dominio e consolidamento delle mega corporation persistono, influenzando ogni aspetto dell’America rurale, mentre entrambi i partiti sono rimasti a guardare. I loro sforzi sono stati facilitati dalla debole applicazione dell’antitrust, e le grandi catene commerciali come Walmart hanno espulso le attività commerciali indipendenti nelle piccole città. Ora, i negozi economici delle grandi catene proliferano nelle comunità rurali, a volte costringendo i grandi magazzini e i centri commerciali a chiudere. Non è una coincidenza che questa tendenza al consolidamento segua un periodo prolungato di stagnazione economica nelle zone rurali. Quarant’anni fa, poco più del 20% delle nuove imprese proveniva da aree esterne alle aree metropolitane. Negli anni 2010, quel numero era sceso al 12%. Secondo uno studio, il 97% della crescita netta dell’occupazione tra il 2001 e il 2016 è andata alle città.
È un dato di fatto che le aree rurali non si sono mai riprese dalla Grande Recessione. Dal 2010 al 2014, le contee con meno di 100 mila abitanti avevano un tasso netto di creazione di nuove imprese pari allo 0%. Mentre molte città si sono riprese, i posti di lavoro e le imprese non sono tornati nelle aree rurali, soprattutto quelle con comunità prevalentemente di colore. I livelli di disoccupazione erano ancora inferiori ai livelli pre-recessione quando le ricadute economiche del CoVid-19 sono arrivate a colpire pesantemente le aree rurali. Le città deindustrializzate continuano a perdere popolazione e posti di lavoro. L’accesso alla banda larga è ritardato, impedendo alle industrie consolidate di tenere il passo e a quelle nuove di farsi strada, mentre i divari nei risultati dell’istruzione secondaria tra le aree rurali e metropolitane si allargano.
Allo stesso tempo, la “piccola nobiltà rurale” ha solo ampliato la propria ricchezza, con possedimenti singoli che raggiungono decine di migliaia di acri. Queste famiglie ottengono i contratti federali più vantaggiosi e tendono a ruotare dentro e fuori dalle posizioni di potere nel governo locale. Uno studio del 2020 pubblicato su Population Research and Policy Review ha rilevato un’associazione tra il declino cronico della popolazione nelle aree rurali e un aumento della disuguaglianza di reddito. In altre parole, le forze economiche che hanno determinato l’impoverimento e il declino della popolazione nelle economie rurali, hanno portato benefici a una piccola classe di capitalisti. Questa relazione, scrivono gli autori dello studio, «suggerisce che il reddito e altre forme di ricchezza (per estensione) si stanno concentrando sempre più nelle mani di pochi eletti».
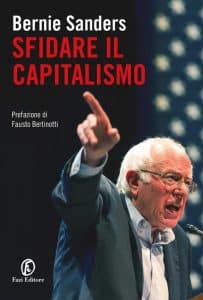 Da questo punto di vista, si segnala l’analisi di Bernie Sanders (Sfidare il capitalismo, Fazi Editore, Roma 2024), il quale non è d’accordo con coloro (come Hilary Clinton) che sostengono che tutti i sostenitori di Trump sono razzisti, sessisti, omofobi e xenofobi, che si tratta di gente “deplorevole”. «Penso che la risposta più corretta del perché Trump abbia conquistato il sostegno della classe lavoratrice risieda nelle difficoltà, nella disperazione e nell’alienazione politica che milioni di lavoratori vivono oggi sulla loro pelle e nel fatto che il Partito Democratico li ha abbandonati, preferendo coltivare l’appoggio dei ricchi finanziatori elettorali e della ‘bella gente’’» (pag. 12). Sono americani che, mentre i ricchi diventavano sempre più ricchi, durante le amministrazioni di presidenti democratici come Bill Clinton e Barack Obama, hanno visto ristagnare i salari reali e trasferire in Cina e in Messico il loro buon lavoro tutelato dai sindacati. Ogni giorno milioni di americani vivono sotto uno stress incredibile, spaventati a morte che se la macchina si guasta, se il figlio si ammala, se il padrone di casa aumenta l’affitto, se divorziano o si separano, se rimangono incinta, se per qualsiasi motivo perdono il lavoro, si ritroveranno nel bel mezzo di una catastrofe finanziaria. Vivere di stipendio in stipendio non lascia alcun senso di sicurezza, nessun cuscinetto su cui ripiegare e nessun tempo di qualità da trascorrere con la propria famiglia in un ambiente rilassato. Non possono permettersi l’assistenza sanitaria né l’asilo per i figli, non li possono mandare al college e hanno il terrore di ricevere una pensione inadeguata. A causa di quelle che i medici chiamano “malattie della disperazione” (cardiopatie, diabete, asma, cancro, depressione, alcolismo, abuso di oppioidi), le loro comunità hanno anche dovuto assistere a un calo dell’aspettativa di vita del 2% (anche se i ricchi vivono molto più a lungo del resto della popolazione). Sono i “lavoratori essenziali” con bassi salari e lavori precari che durante la pandemia da CoVid 19 hanno continuato a lavorare in presenza, ad esempio nei grandi macelli industriali, ammalandosi e rischiando la vita, mentre i loro dirigenti aziendali lavoravano in remoto da casa.
Da questo punto di vista, si segnala l’analisi di Bernie Sanders (Sfidare il capitalismo, Fazi Editore, Roma 2024), il quale non è d’accordo con coloro (come Hilary Clinton) che sostengono che tutti i sostenitori di Trump sono razzisti, sessisti, omofobi e xenofobi, che si tratta di gente “deplorevole”. «Penso che la risposta più corretta del perché Trump abbia conquistato il sostegno della classe lavoratrice risieda nelle difficoltà, nella disperazione e nell’alienazione politica che milioni di lavoratori vivono oggi sulla loro pelle e nel fatto che il Partito Democratico li ha abbandonati, preferendo coltivare l’appoggio dei ricchi finanziatori elettorali e della ‘bella gente’’» (pag. 12). Sono americani che, mentre i ricchi diventavano sempre più ricchi, durante le amministrazioni di presidenti democratici come Bill Clinton e Barack Obama, hanno visto ristagnare i salari reali e trasferire in Cina e in Messico il loro buon lavoro tutelato dai sindacati. Ogni giorno milioni di americani vivono sotto uno stress incredibile, spaventati a morte che se la macchina si guasta, se il figlio si ammala, se il padrone di casa aumenta l’affitto, se divorziano o si separano, se rimangono incinta, se per qualsiasi motivo perdono il lavoro, si ritroveranno nel bel mezzo di una catastrofe finanziaria. Vivere di stipendio in stipendio non lascia alcun senso di sicurezza, nessun cuscinetto su cui ripiegare e nessun tempo di qualità da trascorrere con la propria famiglia in un ambiente rilassato. Non possono permettersi l’assistenza sanitaria né l’asilo per i figli, non li possono mandare al college e hanno il terrore di ricevere una pensione inadeguata. A causa di quelle che i medici chiamano “malattie della disperazione” (cardiopatie, diabete, asma, cancro, depressione, alcolismo, abuso di oppioidi), le loro comunità hanno anche dovuto assistere a un calo dell’aspettativa di vita del 2% (anche se i ricchi vivono molto più a lungo del resto della popolazione). Sono i “lavoratori essenziali” con bassi salari e lavori precari che durante la pandemia da CoVid 19 hanno continuato a lavorare in presenza, ad esempio nei grandi macelli industriali, ammalandosi e rischiando la vita, mentre i loro dirigenti aziendali lavoravano in remoto da casa.
Date le caratteristiche oligarchiche del capitalismo e del sistema politico americano, decine di milioni di americani nutrono un profondo malcontento verso l’establishment politico, economico e dei media. «Guardano Washington e i grandi media e vedono ripulsa e disprezzo nei loro confronti. Vedono un governo che ne ignora i bisogni, ma anche politici interessati solo a presenziare a eventi di raccolta fondi con i ricchi e che non hanno nessuna idea di come viva la grande maggioranza della gente. L’assurdità dell’attuale situazione è che Trump – un ciarlatano, un pilastro dell’establishment, un miliardario e un imprenditore ostile agli interessi dei lavoratori – è stato capace di riempire quel vuoto politico e sfruttare quella rabbia. Donald Trump, ‘campione della classe operaia’. Roba da far cadere le braccia!»(pagg. 13-14).
Secondo Sanders, Trump ha sfruttato e sfrutta il risentimento di milioni di americani in condizioni economiche sempre più disagiate, che non avevano e non hanno «più alcuna fiducia nel governo e si sentivano [e si sentono] ignorati dall’establishment politico, ricorrendo ad appelli al razzismo, al sessismo, all’omofobia e alla xenofobia» (pag. 65). È Trump che alimenta il vittimismo e il rancore, dando alla gente un abbondanza di nemici e capri espiatori: gli immigrati, i neri, le persone LGBTQI+, i musulmani, gli insegnanti, le discriminazioni contro gli uomini bianchi. Secondo Sanders, se i Democratici si affidassero a un audace populismo economico, gli elettori rurali trascurerebbero le questioni culturali in base alle quali si allineano con i Repubblicani e voterebbero in conformità con i loro interessi economici.
I Democratici e la politica nelle zone rurali
Il fatto è che la gran parte della popolazione rurale è ampiamente convinta che nessuno dei due partiti possa risolvere i loro problemi materiali (a proposito si veda qui il nostro articolo su “Lo strano caso della canzone country-folk Men North of Richmond”). E nel complesso, gli elettori rurali non stanno semplicemente reagendo al cambiamento, sia esso demografico o economico. Stanno cercando attivamente di preservare almeno un senso di autonomia rispetto al loro futuro e la continuità dei valori culturali e delle strutture sociali delle loro comunità rurali (che enfatizzano famiglia, fede religiosa e comunità tradizionali). Sono queste aspirazioni che alimentano il conservatorismo culturale e politico delle zone rurali (con anche una certa dose di nostalgia per un passato che potrebbe non essere poi stato così eccezionale come viene ricordato) ed è su questo terreno che si è cementata l’alleanza con il Partito Repubblicano.
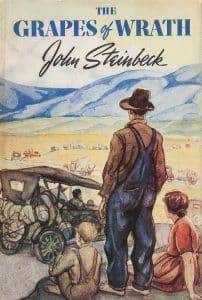 I residenti delle zone rurali fanno così tanto con così poco e si risentono quando qualcuno esterno alla loro comunità interviene e finge di sapere cosa pensano. Lontano dagli stereotipi che si trovano in White rural rage (per cui gli americani delle zone rurali sono caratterizzati come bigotti, culturalmente arretrati, pigri, spaventati dal futuro e politicamente radicali a destra), si scopre che l’identità degli americani rurali riguarda molto più le emozioni positive che provano verso le aree rurali e molto meno le emozioni negative verso gli altri. Le persone residenti nelle zone rurali e nelle piccole città sono straordinariamente orgogliose delle loro comunità e sono in realtà più soddisfatte del luogo in cui vivono rispetto alle persone che vivono in altri luoghi. Si considerano le più patriottiche (i residenti degli Stati gestiti dai Repubblicani hanno oltre il 20% di probabilità in più di arruolarsi nell’esercito), le più oneste, le più “vere” e “autentiche”, ma sentono che le élite le disprezzano, non hanno rispetto per loro, stereotipano i loro amati modi di vivere, li caratterizzano in modo semplicistico, schematico e derogatorio (con l’uso di termini come hillbilly, redneck, yokel, white trash), senza riconoscere i contributi rurali positivi alla società americana. Uno sguardo pregiudizievole verso i bianchi, soprattutto se poveri, del Midwest e della bible belt del Sud, che ha ha sempre vissuto ai margini dell’American dream, un mito reso inizialmente popolare durante la Grande Depressione dallo storico James Truslow Adams con il libro Epic of America (1931) e da John Steinbeck con il libro The grapes of wrath (Furore, 1939) che ha descritto le terribili condizioni di povertà e discriminazione in cui erano finite milioni di famiglie bianche contadine sradicate del Midwest e del Sud perché travolte dalla crisi economica e dalle requisizioni delle loro fattorie vendute all’asta per il pagamento dei debiti. Si erano messe in cammino verso la California, che loro consideravano la terra promessa, ma che invece le ha accolte come ospiti non graditi.
I residenti delle zone rurali fanno così tanto con così poco e si risentono quando qualcuno esterno alla loro comunità interviene e finge di sapere cosa pensano. Lontano dagli stereotipi che si trovano in White rural rage (per cui gli americani delle zone rurali sono caratterizzati come bigotti, culturalmente arretrati, pigri, spaventati dal futuro e politicamente radicali a destra), si scopre che l’identità degli americani rurali riguarda molto più le emozioni positive che provano verso le aree rurali e molto meno le emozioni negative verso gli altri. Le persone residenti nelle zone rurali e nelle piccole città sono straordinariamente orgogliose delle loro comunità e sono in realtà più soddisfatte del luogo in cui vivono rispetto alle persone che vivono in altri luoghi. Si considerano le più patriottiche (i residenti degli Stati gestiti dai Repubblicani hanno oltre il 20% di probabilità in più di arruolarsi nell’esercito), le più oneste, le più “vere” e “autentiche”, ma sentono che le élite le disprezzano, non hanno rispetto per loro, stereotipano i loro amati modi di vivere, li caratterizzano in modo semplicistico, schematico e derogatorio (con l’uso di termini come hillbilly, redneck, yokel, white trash), senza riconoscere i contributi rurali positivi alla società americana. Uno sguardo pregiudizievole verso i bianchi, soprattutto se poveri, del Midwest e della bible belt del Sud, che ha ha sempre vissuto ai margini dell’American dream, un mito reso inizialmente popolare durante la Grande Depressione dallo storico James Truslow Adams con il libro Epic of America (1931) e da John Steinbeck con il libro The grapes of wrath (Furore, 1939) che ha descritto le terribili condizioni di povertà e discriminazione in cui erano finite milioni di famiglie bianche contadine sradicate del Midwest e del Sud perché travolte dalla crisi economica e dalle requisizioni delle loro fattorie vendute all’asta per il pagamento dei debiti. Si erano messe in cammino verso la California, che loro consideravano la terra promessa, ma che invece le ha accolte come ospiti non graditi.
Nonostante il loro enorme peso politico, i bianchi rurali, a parte la “piccola nobiltà”, non sono riusciti a trarre dei grandi benefici. Il paradosso è che, in termini di politiche, i Democratici probabilmente fanno di più per le aree rurali e i residenti rurali rispetto ai Repubblicani. Dopo che i Democratici hanno approvato l’Obamacare, i residenti rurali avrebbero beneficiato di più negli Stati che ampliavano il programma Medicaid, ma due terzi dei residenti rurali non assicurati hanno perso l’opportunità perché vivevano in Stati che si sono rifiutati di espandere la copertura – e quegli Stati erano governati quasi esclusivamente da Repubblicani. L’agenda anti-aborto del Gop ha significato che i reparti di maternità rurali sono stati chiusi. L’opposizione repubblicana alla banda larga pubblica danneggia più direttamente l’America rurale, dove le aziende private hanno pochi incentivi a creare un servizio. Gli attacchi repubblicani all’istruzione superiore hanno un’influenza sproporzionata sulle università delle aree rurali svantaggiate. E gli atteggiamenti anti-vax hanno portato a tassi di mortalità da CoVid-19 che hanno rivaleggiato o superato quelli di aree molto più densamente popolate (nel 2021, l’esitazione nei confronti dei vaccini ha messo Oklahoma, Alabama, West Virginia, Mississippi e Wyoming – fortemente rurali e repubblicani – in cima alla lista delle vittime del CoVid-19).
Attualmente, ci sono 400 programmi federali, di cui 70 solo presso il Dipartimento per l’Agricoltura (Usda), che servono gli americani delle zone rurali. Paul Krugman è stato pronto nel sottolineare che «poiché l’America rurale è più povera dell’America urbana, paga molto meno tasse federali pro capite, quindi in pratica le principali aree metropolitane sovvenzionano enormemente le campagne». Ed è vero che l’amministrazione Biden sta attualmente supervisionando miliardi di nuove spese federali che vanno in modo sproporzionato alle comunità rurali di tutta l’America (e per le quali i Repubblicani al Congresso hanno votato contro). Come ha affermato sul Washington Post Paul Waldman nel 2022: «Una cosa che non si può assolutamente dire è che i Democratici non cercano di aiutare l’America rurale. In effetti, probabilmente lavorano più duramente dei Repubblicani». La frustrazione dei Democratici deriva dal fatto che gli elettori delle zone rurali sono refrattari a pensare alla politica in termini puramente transazionali: benefici contro voti.
Il problema che i Democratici non sono stati in grado di risolvere non riguarda la policy, ma la politica: incontrare le persone dove si trovano, trovare interessi comuni, costruire forza istituzionale e cercare di persuadere gli altri a unirsi, lasciandosi guidare dalle questioni e dalle preoccupazioni locali. Da questo punto di vista, avverte Jacobs, se i Democratici seguiranno le tesi di White rural rage commetteranno l’errore di non provare ad offrire una risposta politica che sia capace di comprendere e rappresentare le contraddizioni esistenti, suggerendo che gli americani delle zone rurali sono irrazionali e al di là di ogni sforzo per coinvolgerli, finendo così per consegnare questa parte dell’elettorato al dominio assoluto Repubblicano per il prossimo decennio. Finché l’America rurale sarà trattata con disprezzo, non ci si potrà davvero sorprendere se, ancora una volta, seppure con riluttanza si rivolgerà a Trump il prossimo novembre.
Dopo aver descritto l’America rurale bianca come un ostacolo alla democrazia (e al Partito Democratico), Schaller e Waldman auspicano la nascita di un “vero movimento rurale” per «usare il potere di cui dispongono e iniziare a chiedere qualcosa di più concreto». Nel libro presentano un piano in 10 punti per la rivitalizzazione rurale. Quello che non vedono è che un vero movimento rurale esiste già. È il movimento rurale verso il Partito Repubblicano che si è costruito a partire dagli anni 80. Esisteva prima di Trump ed esisterà dopo che Trump avrà lasciato la politica.
Invece, il primo passo che i Democratici dovrebbero fare è iniziare a pensare – e a parlare – della e all’America rurale nel modo giusto, affrontando effettivamente il risentimento rurale – quel senso d’identità e di coscienza di luogo che è in via di spaesamento, le ansie provate nei confronti della propria comunità, la sensazione di aver perso qualcosa mentre il resto del Paese va avanti, la sensazione profondamente radicata che l’America urbana cancellerebbe i modi di vivere rurali se ne avesse la possibilità.
Innanzitutto, comprendere il risentimento rurale significherebbe riconoscere le profonde disuguaglianze geografiche che esistono negli Stati Uniti e che tali disuguaglianze sono un potente motivatore del comportamento politico. Inoltre, i Democratici dovrebbero riconoscere che ciò che le comunità rurali potrebbero desiderare sono strategie di empowerment che permettano loro di modellare il proprio futuro: un sostegno che rafforzi la leadership locale, incoraggi iniziative guidate dalla comunità e fornisca loro gli strumenti e le risorse necessari per affrontare sfide specifiche in modo coerente con i loro valori. Un’impostazione che sarebbe in linea con l’impegno dei Democratici nei confronti del multiculturalismo, del pluralismo e della diversità locale. E che dovrebbe essere messa in collegamento con la ripresa del movimento sindacale e il rinnovato attivismo della classe lavoratrice negli ultimi due anni, con gli scioperi vittoriosi e le iniziative di sindacalizzazione del sindacato United Auto Workers (Uaw), molti dei quali in piccole città e città industriali di medie dimensioni nelle aree rurali di Midwest e Rust Belt, dall’Iowa a Wisconsin, Ohio, Missouri, Pennsylvania, Illinois, Michigan, Kansas, Alabama e Tennessee (sugli scioperi del settore automobilistico, si vedano i nostri articoli qui e qui).
Se gli americani bianchi delle zone rurali sono arrabbiati o scontenti, sono anche politicamente potenti. «Entro il 2040, il 70% degli americani risiederà nei 15 Stati più popolosi e sceglierà 30 dei 100 senatori statunitensi», scrivono Schaller e Waldman. «Concentrato negli Stati più piccoli e rurali, il restante 30% della popolazione eleggerà 70 senatori. Non importa quanto distorti diventino questi rapporti demografici, a ogni Stato sono garantiti i suoi due senatori – passati, presenti e per sempre». I Democratici possono continuare a dare la colpa all’oscurantismo rurale e a perdere le elezioni, oppure degnarsi di fare politica anche nelle zone rurali e non solo nelle are urbane e suburbane, scegliendo candidati per le assemblee elettive statali e federali competenti e in grado di relazionarsi e di sviluppare empatia con gli elettori rurali. Soprattutto, reclutando migliaia di organizzatori a tempo pieno che lavorino nei territori rurali e creando centri operativi di zona attivi tutto l’anno, in contatto con i gruppi di base e i sindacati locali. Il Democratic National Committe dovrebbe essere trasformato da mero apparato di raccolta fondi dominato dagli interessi aziendali a fonte di sostegno per l’attivismo di base e le battaglie della classe lavoratrice nei territori rurali, come nel resto degli Stati Uniti.
L’autore: Alessandro Scassellati Sforzolini è ricercatore sociale e attivista, collabora con Transform! Italia. Fra i suoi libri Suprematismo bianco (Derive e Approdi)