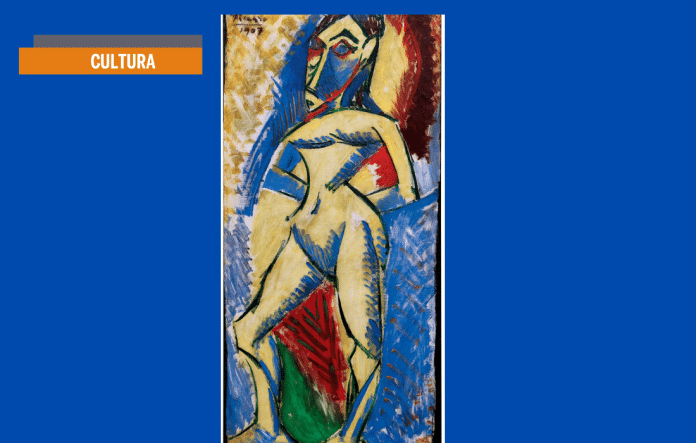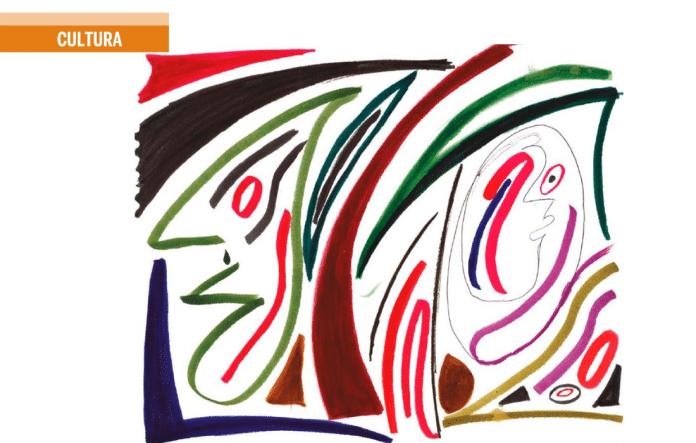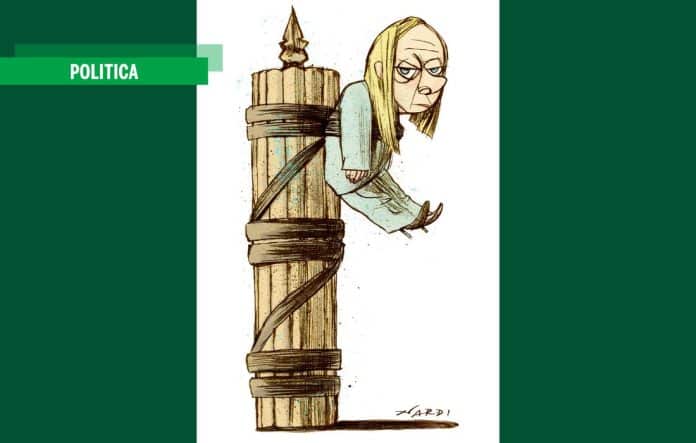I dati sulla natalità italiana ed europea sono ormai gli stessi da tanti anni. La popolazione è in netta decrescita, si fanno meno figli e di conseguenza diminuiscono gli “italiani”. È una tendenza che va avanti da tanti anni. Anche se apparentemente la riduzione della popolazione sembra poca cosa in realtà la riduzione percentuale nella fascia di giovani è più alta. Per recuperare la “popolazione persa” sarebbe quindi necessario che le donne in età fertile si dedicassero sostanzialmente solo a fare figli, cosa evidentemente impensabile e irrealizzabile.
Problemi analoghi affliggono la gran parte dei Paesi europei con l’Italia penultima superata solo dal Portogallo come decrescita demografica. Ma lo stesso problema lo troviamo negli Stati Uniti, in Cina, in Russia e più in generale in tutte le economie avanzate. I governi si trovano di fronte al problema che il tempo necessario per recuperare la popolazione mancante è lunghissimo, parliamo di decenni, sempre che le politiche di incentivazione a fare figli funzionino, cosa niente affatto scontata. Ma perché sarebbe necessario opporsi al calo demografico? La risposta degli esperti è la necessità di avere più persone in età lavorativa. Uno scopo materiale, di sussistenza economica e anche sociale visto che sono le tasse sul lavoro che pagano il welfare, le pensioni ma anche la sanità, il sistema di assistenza sociale sul territorio e tutto ciò che riguarda i bambini e i ragazzi, cioè la scuola e poi l’Università. La soluzione proposta è chiedere alle donne di fare più figli. Gli si chiede di tornare indietro nel tempo, di rinunciare, per lo meno in parte, ad una vita che sia anche di realizzazione personale per dedicarsi ad essere produttrici di figli. Quando ormai è chiaro a chiunque che l’immigrazione è la vera soluzione al problema con tempi di realizzazioni molto più brevi. Anche perché, per lo meno in Europa, c’è una fortissima “offerta” di immigrazione e c’è una enorme “domanda” di immigrati nell’economia. Perché allora non la si favorisce? Perché non si pensa a rendere possibile l’arrivo di coloro che vogliono costruire la loro vita in Italia e in Europa e invece si cerca solo di ostacolare violentemente queste aspirazioni, provocando tragedie quotidiane?
L’Homo sapiens è comparso nell’Africa orientale circa 300mila anni fa e poi, circa 70mila anni fa ha iniziato a spostarsi e ha “colonizzato” il mondo intero. In questa migrazione originaria durata decine di migliaia di anni, la selezione naturale darwiniana conseguenza dell’adattamento ai diversi ambienti naturali, ha determinato una variabilità grandissima dei tratti somatici: il colore della pelle, degli occhi, l’altezza, la forma del viso e degli occhi, il colore dei capelli, la muscolatura. Le generazioni si sono susseguite e insieme all’adattamento dei caratteri somatici si sono sviluppate lingue e culture diverse, sono state inventate religioni e sono state inventate storie di origine diverse tra loro. I diversi gruppi di homo sapiens, nel corso di decine di migliaia di anni, hanno dimenticato la loro origine comune. E probabilmente hanno iniziato a pensare di non essere più tutti uguali.
La storia è costellata di azioni e pensieri che sostengono la superiorità di una determinata etnia rispetto ad un’altra, pur essendo la diversità soltanto l’esito di selezione naturale ed evoluzione culturale.
Una quantità incommensurabile di esseri umani ha subito le violenze più terribili per una presunta superiorità affermata da qualcuno rispetto a qualcun altro che sarebbe stato “meno uguale degli altri”. E questo non ha riguardato solo etnie diverse tra loro. Anzi forse dobbiamo pensare che la prima diversità che è stata pensata come qualcosa di “meno” è stata quella tra uomo e donna e tra uomo e bambino.
La donna deve essere pensata inferiore perché… non è uomo. Il bambino finché non diventa adulto viene pensato inferiore perché… non è adulto.
Diversità insanabile per la donna che per di più ha la possibilità e capacità di fare figli. Forse dobbiamo pensare che sia questa prima “diversità” che ha fatto impazzire i maschi della specie e gli ha fatto teorizzare una superiorità astratta dell’uomo sulla donna. Questa superiorità sul diverso è stata poi traslata a tutti gli altri diversi, a tutti quelli che non sono identici, che non fanno parte dello stesso gruppo, quelli fuori dai confini, i barbari, quelli che non parlano come noi, non pensano come noi, non hanno il nostro stesso dio o addirittura non hanno affatto un dio.
Non voglio addentrarmi in discorsi troppo complessi ma è significativo che le politiche regressive della destra – e il governo attuale conferma in pieno questa “regola” – si accaniscono sempre contro le donne, contro i giovani e contro gli immigrati.
Così come le tre grandi religioni monoteiste sono accomunate dal non aver mai accettato un’uguaglianza tra uomo e donna perché la donna è pensata inferiore, costola di Adamo. E quindi la sua libertà deve essere sempre limitata.
Accettare l’esistenza del diverso significa riuscire a fare un pensiero non razionale: che il diverso da sé sia un essere umano anche se non lo capiamo. Accettare che ci possa essere un rapporto con questo diverso da noi anche se apparentemente non ci si capisce per nulla. Accettare che ci possa essere un futuro comune anche se il nostro modo di vivere è del tutto diverso. Accettare che c’è un’origine comune, che ci può essere un presente comune e che ci possa essere un futuro comune in cui la nostra esistenza significa l’esistenza degli altri e viceversa. Che ci sia in altre parole un vita tua, vita mea.
Avere fiducia che ciò che non si conosce sia simile a noi. Avere la fantasia sufficiente per pensare questa possibilità.
Il pensiero razionale occidentale, il logos, oggi prevalente nel mondo, ha chiuso gli occhi sul diverso, si è chiuso nei confini della polis e poi della nazione. Le religioni hanno stabilito che la donna deve fare figli da donare al pater familias, cui chiedere di accettarli e non ucciderli, la donna deve essere al suo servizio per soddisfare le sue necessità, quelle della famiglia e quelle della nazione che si definisce “patria”, la terra dei padri. È il padre, il maschio razionale, che definisce la nostra identità, la nazione che definisce la nostra cittadinanza, il credo religioso che stabilisce la nostra “umanità”. Gli “altri”, quelli fuori dal confine, non sono. Non ci può essere uguaglianza né quindi fiducia e viceversa. Bisogna credere invece di pensare, credere che ci sia il male dentro e fuori di noi, dentro e fuori dai nostri confini. Quello dentro di noi deve essere controllato con il credo religioso. Quello fuori di noi deve essere individuato e contenuto, obbligato a non nuocere alla tranquillità apatica della nostra società, al non doversi mettere in crisi di fronte al nuovo che non si conosce e non si capisce. In una recente presentazione del libro Welfare per le nuove generazioni è stato ricordato che da sempre nella storia si dice che i giovani di oggi non siano altrettanto “bravi” di quelli di un tempo. Ed è così anche oggi. Chi è più vecchio se la prende con i più giovani. Perché sono diversi, perché parlano linguaggi diversi e nuovi, perché forse pensano in modo diverso. Perché in fondo sono incomprensibili.
In quella presentazione è stato anche detto quanto sia fondamentale dare loro fiducia. Perché saranno loro che costruiranno un mondo migliore e un’umanità migliore di quella di oggi. Perché è la storia che ci dice questo: c’è un’evoluzione lenta, complicata, terribile e poi veloce e meravigliosa, affascinante, che con tempi lunghi e poi con accelerazioni, con sterzate che riportano indietro e idee che travolgono e accelerano in avanti, l’umanità ha costruito e sta sempre costruendo un mondo che sia sempre meglio di come è.
So che può apparire un pensiero ingenuo in questo momento tragico per il mondo. Ma è anche vero che se guardiamo al passato vediamo che il mondo attuale è per molti versi migliorato. E però va visto che questo non basta e non basterà mai. Non esiste la società ideale così come non esiste un punto di arrivo nella realizzazione personale. La ricerca personale è continua così come la ribellione all’ingiustizia, al negativo del mondo e dell’essere umano non ha mai fine. È un divenire infinito in cui siamo tutti protagonisti ma in particolare lo sono i giovani. Perché l’ambizione di tutti i giovani, sempre, è quella di ribellarsi al costituito e cambiare il mondo. Dobbiamo avere sempre fiducia nel diverso da noi. La storia è costellata da tragedie ma è anche costellata da imprese straordinarie, dalla genialità di “giovani” che hanno cambiato il mondo e il corso della storia. Così come è straordinaria ogni storia personale. Nessuno può e deve essere considerato poco importante. L’esistenza di ognuno è importante per gli altri. Vanno pensate soluzioni che siano impossibili per il pensiero attuale ma che siano possibili per un pensiero futuro. Io penso che così come era impensabile una unione europea soltanto un secolo fa, oggi dobbiamo pensare che la soluzione del problema economico e di identità dei Paesi europei è immaginare una nuova Europa che abbatta i propri confini e abbracci il Mediterraneo per realizzare una Unione Europa-Africa.
Che si pensi e poi si realizzi una Politica che immagini un mondo nuovo e affermi quella unica origine comune di esseri viventi che, ad un certo punto, hanno deciso di migrare, di andare incontro al nuovo perché avevano fiducia nel futuro anche se assolutamente sconosciuto.