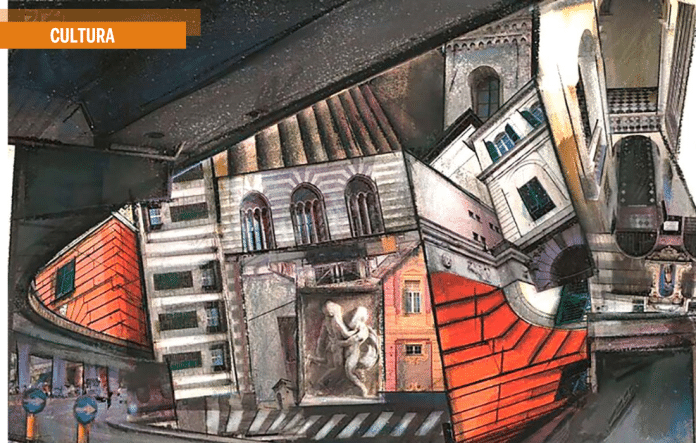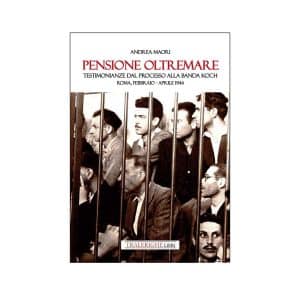Come è noto Maurizio Molinari è il direttore di uno dei principali quotidiani italiani, La Repubblica. Per l’esattezza, il secondo per numero di vendite in Italia, sebbene in crisi da anni, con un crollo delle copie vendute che ha subito un’accelerazione dall’arrivo di Molinari nel 2020. Sempre lui, Molinari, è direttore editoriale del Gruppo Gedi (che possiede La Repubblica), di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann e tra i principali gruppi editoriali del Paese. Al di là della carta stampata, Molinari è una presenza fissa in Tv. Dalle reti pubbliche a quelle private, le sue opinioni arrivano nelle case degli italiani praticamente ogni giorno. Come quando arrivò a esigere pubblicamente le scuse di una collega, la giornalista Lasorella, colpevole di aver messo in discussione la veridicità della notizia rimbalzata su tutti i media sui presunti 40 bambini decapitati da Hamas durante la strage compiuta il 7 ottobre. Notizia, quella della decapitazione di bambini, diffusa dalla stessa Repubblica e rivelatasi una fake news.
Pochi mesi fa ha pubblicato l’ultimo dei suoi tanti libri: Mediterraneo conteso. Perché l’Occidente e i suoi rivali ne hanno bisogno. Pubblicato con Rizzoli, storica casa editrice acquisita nel 2015 dal Gruppo Mondadori (controllato dal 1991 dalla Finivest, alla cui presidenza c’è Marina Berlusconi, figlia di Silvio); prima della cessione le rispettive quote di mercato erano del 14% e del 28%. Non proprio le briciole del mercato editoriale.
Molinari gira lo “stivale” per presentare il suo ultimo libro e per partecipare a dibattiti che hanno al centro delle riflessioni la congiuntura che ci troviamo ad affrontare.
Il 15 marzo arriva all’Università Federico II di Napoli, che quest’anno festeggia gli 800 anni di storia, per una discussione che vede tra i presenti anche il rettore dell’ateneo, Matteo Lorito.
Alcune decine di studenti e studentesse organizzano una contestazione: cartelli e cori all’indirizzo di Molinari, accusato di aver sposato la propaganda di Israele e, conseguentemente, di aver schierato La Repubblica, che pure è considerato quotidiano di punta del “progressismo”, a sostegno del genocidio in corso a Gaza.
Cosa tra l’altro sostenuta da un ex giornalista del Venerdì di Repubblica, Raffaele Oriani (Premio Stefano Chiarini 2024), che con una lettera aveva così motivato le sue dimissioni dopo 12 anni di collaborazione: «Questo massacro [a Gaza] ha una scorta mediatica che lo rende possibile. Questa scorta siamo noi. Non avendo alcuna possibilità di cambiare le cose, con colpevole ritardo mi chiamo fuori».
A quel punto, l’incontro salta. Secondo le parole dello stesso Molinari, che ricevono immediatamente enorme eco e il 16 marzo saranno pubblicate sul suo stesso quotidiano: “Con grande dispiacere ho scelto di rinunciare alla conferenza in programma […] in considerazione dei rischi per la sicurezza del pubblico causati da un ristretto gruppo di manifestanti”.
Come lui stesso scrive, dunque, non gli è stato impedito di parlare, ma ha deciso di non tenere l’incontro. Versione che, se qualcuno avesse voluto fare mezza domanda agli studenti, avrebbe visto confermata. E, anzi, avrebbe potuto aggiungere particolari: l’incontro era a invito – a proposito di restrizioni; gli studenti sono stati strattonati, spintonati e in alcuni casi presi a calcio dagli agenti presenti all’esterno dell’università; la proposta di incontro di Molinari era in realtà la proposta di ricevere una delegazione di soli due studenti “contestatori”, cui gli studenti hanno rilanciato chiedendo la possibilità di un dibattito collettivo, prontamente rifiutato. Alla luce della versione degli studenti, chi ha rifiutato il dialogo?
Nonostante tutto ciò, la narrazione che immediatamente viene diffusa è che gli studenti hanno impedito a Molinari di parlare, l’hanno privato della libertà di espressione.
Seguono le reazioni del mondo della politica. La ministra del Turismo Santanché che nel 2008 durante un comizio a Milano si era dichiarata “orgogliosamente fascista”, scrive che “i fascisti di sinistra continuano a manganellare la libertà di parola”. Forse per lei è una maniera di fare un complimento…
Il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida – la cui moglie, Arianna Meloni, sorella di Giorgia, qualche mese fa ha querelato un disegnatore, Natangelo, per una vignetta sul Fatto Quotidiano – si erge a paladino della libertà di espressione e addirittura sostiene che “la tolleranza del passato verso questi episodi ha portato al terrorismo”.
Posizioni riprese dal presidente del Senato La Russa, seconda carica dello Stato, orgoglioso del busto di Mussolini che tiene in bella mostra a casa, la cui lettera viene pubblicata su La Repubblica (ops!) lunedì 18 marzo e in cui sostiene che ciò che è successo a Napoli “richiama alla mente fatti e slogan degli anni ‘70 (“Fuori i fascisti dall’università” ecc.) […] che furono poi concausa della nascita del terrorismo”.
L’ex presidente del Consiglio Gentiloni (Pd), oggi commissario Ue all’Economia, su X parla di “Brutto episodio. Tira un’aria pericolosa”. A ruota la segretaria del Pd, Schlein: “è grave che qualcuno impedisca di svolgere iniziativa pubblica”. Per finire con Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana: “la censura non può avere cittadinanza negli atenei italiani”.
Il fatto che comporta una svolta qualitativa è, però, la presa di parola del presidente della Repubblica. Mattarella esprime con una nota la propria solidarietà a Molinari e aggiunge che “quel che vi è da bandire dalle università è l’intolleranza, perché con l’Università è incompatibile chi pretende di imporre le proprie idee impedendo che possa manifestarle chi la pensa diversamente”.
È “il mundo al revés” di cui parlava Eduardo Galeano.
L’intero arco politico parlamentare e la totalità delle istituzioni fanno passare Maurizio Molinari come “uno che non può parlare”. Uno dei volti del potere mediatico progressista (direttore del secondo quotidiano italiano, presenza fissa in Tv, pubblicato dalle principali case editrici italiane) una sorta di “senza voce”.
Per contro, gli studenti e le studentesse, sono etichettati come squadristi, violenti, intolleranti, ignoranti. E, ovviamente, antisemiti. Come dichiarato fin da subito dai presidenti delle Comunità ebraiche, che scrivono che Molinari sarebbe stato preso di mira “solo perché ebreo”. Diffamazione bella e buona.
A questi stessi studenti, sotto attacco da giorni, non viene concesso nemmeno il diritto di replica alle accuse.
La conferenza stampa che hanno convocato all’indomani della contestazione e delle parole di Mattarella viene disertata dai media. Il comunicato stampa che hanno inviato ad agenzie e redazioni non compare da nessuna parte, fatta eccezione per poche righe e qualche minuscolo trafiletto.
Gli stessi che si sono stracciati le vesti a difesa di Molinari, cui sarebbe stato impedire di parlare, non hanno evidemente più vesti da stracciare per gli studenti cui viene impedito di avere qualsiasi spazio mediatico per portare le proprie posizioni e difendersi da accuse a volte infamanti (come quella di antisemitismo).
A difesa del potere mediatico sì, a difesa dei veri “senza voce” anche no.
Per non parlare del fatto che, dall’ultradestra ai progressisti, salvo rarissime eccezioni, non si è alzata mezza voce a difendere il diritto al dissenso. Che viene dichiarato sacro quando potere mediatico e politico parlano di ciò che accade all’estero, ma che evidentemente qui da noi non è “sale della democrazia”, ma un vezzo tranquillamente sopprimibile.
Senza difesa del diritto al dissenso – che si difende non solo quando si è d’accordo con le posizioni espresse e i modi usati – non c’è argine agli attacchi a libertà individuali e collettive. Così, a poche ore dalla contestazione, il principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera già avvisa che “gli episodi che si sono ripetuti nelle Università potrebbero portare a bloccare, o quantomeno limitare, le contestazioni fuori dalle aule dove si tengono convegni e incontri che potrebbero innescare la protesta pro Palestina e contro Israele. […] Non potendo prevedere ogni protesta, sarà aumentata la sorveglianza prima dei convegni che potrebbero essere a numero chiuso o ad inviti. Per impedire di fatto l’accesso a chi potrebbe aver organizzato una manifestazione che possa portare all’interruzione dell’evento” (Corsera, 17 marzo).
Insomma, altro che “libero fischio in libera piazza”, espressione dell’ex partigiano socialista ed ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini.
L’Italia in cui viviamo oggi è un Paese in cui proteste e dissenso sono sempre più considerate alla stregua di un fastidio da marginalizzare. Il modello che si persegue da parte del blocco sociale al potere non è tanto l’eliminazione formale di questi diritti, quanto il loro sostanziale svuotamento. Così che, sulla carta, potremo continuare a dissentire e protestare, ma senza disturbare.
È la democrazia sognata dal potere politico, mediatico ed economico, quella in cui il conflitto viene espunto o imbrigliato. Così che di “democratico” rimanga solo il nome.
L’autore: Giuliano Granato è portavoce di Potere al popolo. Collabora con CanalRed diretto da Pablo Iglesias
Nella foto: frame del video delle proteste alla Federico II, Napoli, 15 marzo 2024