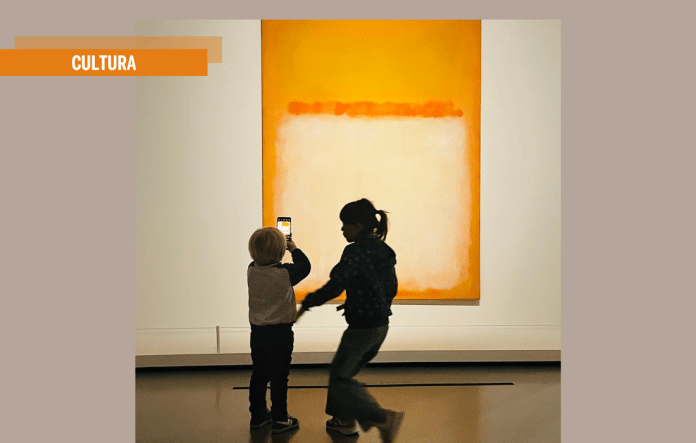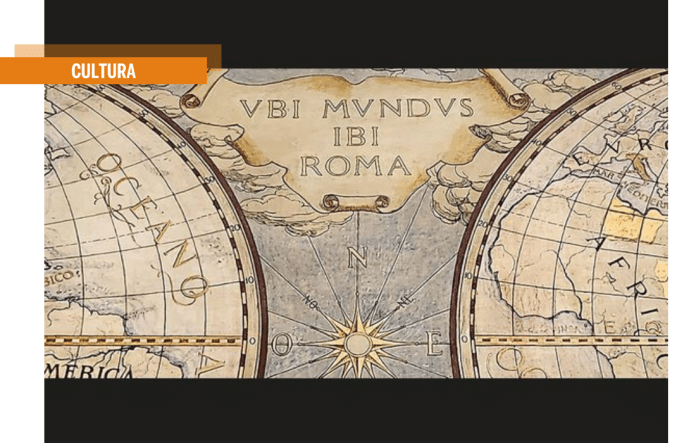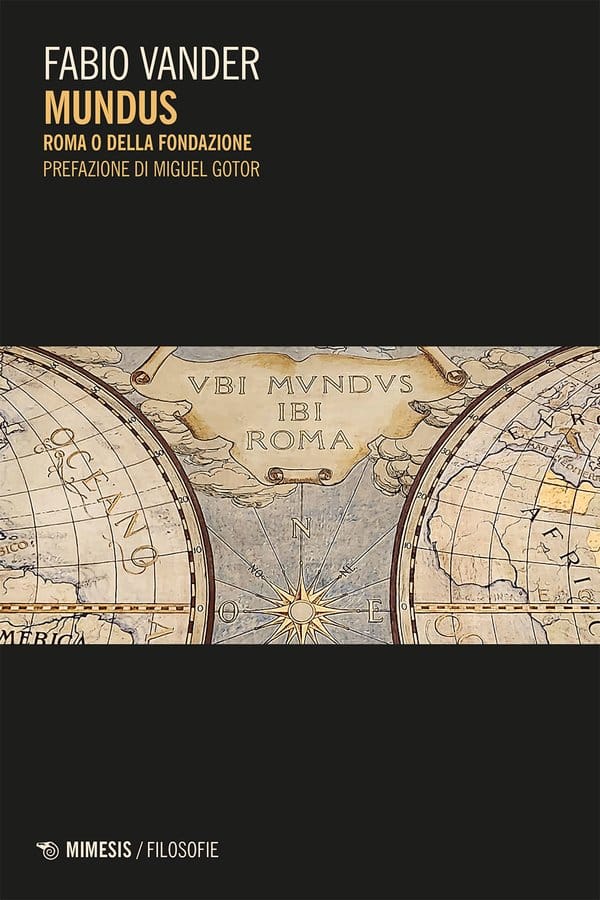Sguardi dal mondo è la personale del fotografo Riccardo Acerbi dal 15 al 23 marzo a Roma, Palazzo Velli (Piazza Sant’Egidio, 10). Pubblichiamo il testo critico della curatrice, Ludovica Palmieri.
Oltre cento fotografie, in bianco e nero, fanno vibrare le pareti di Palazzo Velli e accompagnano i visitatori in un metaforico viaggio attraverso diversi Paesi. Italia, Stati Uniti, Brasile, Inghilterra, Sud Africa, Paesi dell’Est Paesi, Canarie. Ognuno particolarmente rappresentativo nell’immaginario di Riccardo Acerbi artista, fotografo, viaggiatore, che ritrova in questi luoghi la Rappresentazione di un volto che ha amato.
Per Riccardo Acerbi, romano, classe 1962, attore e regista per professione, cresciuto davanti all’obiettivo, la fotografia rappresenta una naturale estensione dello sguardo. È stato dunque spontaneo per lui sviluppare precocemente una passione per lo strumento fotografico e adottarlo da autodidatta come principale mezzo di espressione.
Nella visione di Riccardo Acerbi la fotografia non ha una funzione descrittiva o documentaristica, quanto piuttosto emotiva. Le sue opere hanno poco a che vedere con le tradizionali fotografie di viaggio, perché raccontano i luoghi attraverso punti di vista inusuali, si potrebbe dire poco battuti, come gli itinerari che preferisce. Per Riccardo Acerbi viaggiare non significa percorrere percorsi canonici ma perdersi tra la folla, mischiarsi agli abitanti del luogo, entrare in empatia con lo stesso, capirlo e respirarlo, facendolo scorrere come ossigeno dentro di sé.
Le sue fotografie, immagini a tratti intime e silenziose, sono un’alternanza di ritratti, posati o rubati, paesaggi dalle inquadrature originali, dettagli di architetture o strade, momenti di vita. Nella maggior parte dei casi si tratta di foto in esterno. Strade, spiagge, edifici, paesaggi. Immagini che intendono cogliere il momento, una particolare situazione.
La loro singolarità risiede nella vivacità della visione dell’autore, specchio della sua libertà interna che lo svincola dall’obbligo di obbedire a dogmi, stereotipi o fredde regole accademiche. Le sue opere non hanno nulla di studiato o premeditato, sono figlie del momento, al cui altare l’artista è ben disposto a sacrificare la perfezione tecnica. Per cui non importa se un’inquadratura non è centrata o se la luce poteva essere migliore, quello che conta è mescolarsi alla realtà, vivere l’hic et nunc. In altre parole: nelle sue opere la sostanza prevale sulla forma, l’urgenza creativa e la passione si impongono sulla perfezione tecnica.
L’artista sceglie continuamente e seleziona una determinata porzione di realtà, in un processo velocissimo che rifiuta gli scatti multipli in favore di un romantico ritorno allo scatto unico, perché unico è il momento. Come se la purezza del suo sguardo si andasse a imprimere, senza filtri, direttamente sulla carta fotografica. In un processo creativo che conferisce alle immagini quella genuina freschezza che si respira nella mostra. A questa poetica del momento fa da contraltare la perfezione fragrante della stampa che genera un ossimoro, creando un corto circuito emozionale che rapisce lo spettatore.
Questo approccio schietto e sincero alla fotografia si riflette nel fatto che per ogni Paese emergono delle caratteristiche peculiari che non discendono da elucubrazioni teoriche ma, semplicemente dalla sua apertura mentale al mondo e all’accoglienza del diverso da sé. Per cui, come nei rapporti d’amore, l’adattamento all’altro avviene in modo impulsivo ed immediato, senza bisogno di regole o convenzioni.
In mostra sono presenti anche due installazioni video che, realizzate sempre con la macchina fotografica, si pongono in naturale continuità con le immagini. Il primo video, Man at Work, Brazil, 2021, dedicato al Brasile, è esasperatamente rallentato e presenta le attività che un pescatore compie ogni mattina, come togliere la plastica dalla spiaggia o sciogliere la rete. Il video procede senza colpi di scena, in un’esaltazione della normalità e un elogio alla lentezza che ricorda la filosofia zen, ripresa in maniera magistrale da Wim Wenders nel suo ultimo film. Il principio alla base è quello tratto dalla cultura buddhista del saper cogliere la felicità nelle piccole cose, in linea con il concetto di Ikigai molto popolare ultimamente. Termine che, composto da due parole traducibili con “vivere” e “ragion d’essere” o “qualità”, identifica la pienezza esistenziale nella consapevolezza del proprio scopo e nel metterlo in pratica quotidianamente, in un’azione che nello stesso tempo appaga se stessi e contribuisce al benessere altrui.
La seconda installazione video: People, 2010-24, seppur diversa dalla prima, è legata alla mostra dal medesimo cordone ombelicale, per usare le parole dell’artista, che è la potenza dello sguardo. Ovvero, la capacità di cogliere la bellezza attraverso la connessione profonda con ciò che ci circonda. In questo caso, l’opera deriva dal montaggio di una selezione di video brevi, di pochi secondi, in cui l’artista, nel riprendere impercettibili movimenti, è come se offrisse ai visitatori la possibilità di entrare nel suo processo creativo volto a cogliere l’attimo. L’opera esprime quell’esigenza di immediatezza che diventa ancor più urgente nei ritratti, in cui lo scopo dell’artista è quello di riuscire a restituire in video l’espressione del soggetto nell’istante immediatamente antecedente lo scatto.
Tutte le opere di Acerbi, seppur appartenenti a periodi diversi, riconducibili ad un arco temporale compreso tra il 2010 e il 2023, sono in bianco e nero. Una scelta distintiva per l’artista, nonché indispensabile per mettere a fuoco la scena, spogliandola da dettagli chiassosi che rischierebbero di distogliere l’attenzione dell’osservatore dal focus della stessa. La mostra è voluta e prodotta da Alberto de Marinis, esperto ed appassionato d’arte che da anni sostiene e supporta come mecenate l’attività di vari artisti.
In apertura, Riccardo Acerbi, Italia, Milano, 2019
Per fotografare devi vivere.
Ci sono tanti luoghi, tante situazioni, tante persone e tanti volti che trasmettono emozioni.
A volte mi piacerebbe dare una voce a coloro che compaiono nelle foto,
sperando che quella voce arrivi anche a chi guarda le mie immagini.
Io abito a Roma, il volto da me più conosciuto e amato.
La passione e non l’esigenza mi ha sempre accompagnato quando metto la macchina fotografica al collo,
pronto per quell’emozione improvvisa…
Quel momento dello scatto diventa una scena viva, reale
e quando tolgo l’occhio dal mirino sembra già passato tutto,
però io sono ancora lì e al prossimo scatto non ci penso, tanto arriva.
La vita è come un lungo film e il mio ogni tanto si prende una pausa per fermare l’attimo.
Riccardo Acerbi