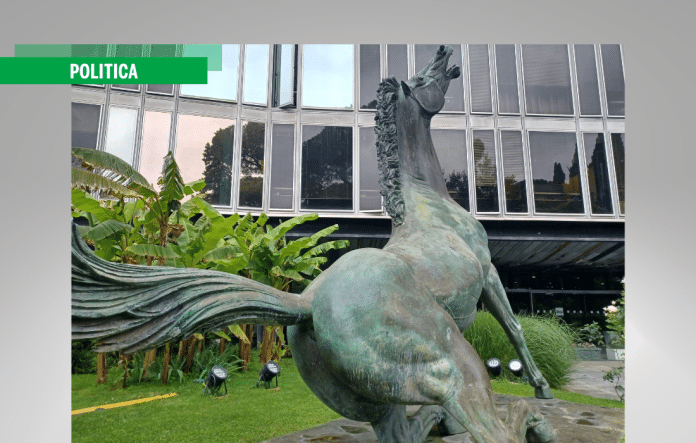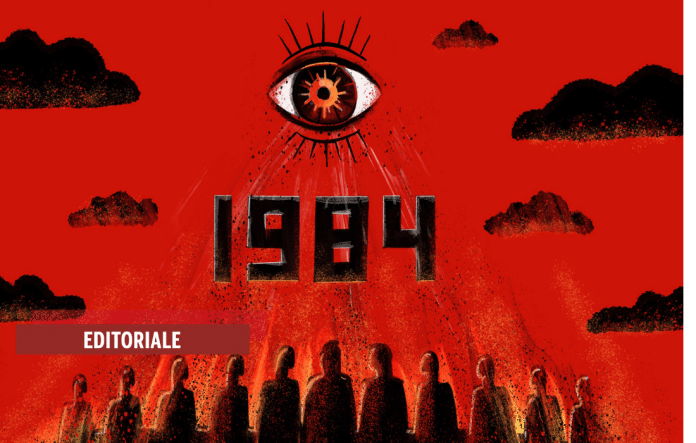Psichiatria, giustizia e politica sono chiamate ad affrontare un problema antico, ma adesso sempre più urgente, nel clima creatosi dopo l’efferato omicidio della psichiatra Barbara Capovani ad opera di un suo ex paziente. Come curare e dove accogliere gli autori di reato i quali si trovino in uno stato tale di mente da escludere, per infermità, secondo gli articoli 88 e 89 del Codice penale, la capacità di intendere e volere? Nonostante la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2015 e l’apertura delle Rems (Residenze per le misure di sicurezza) il problema è ancora aperto e tutto il sistema rivela delle crepe, come dimostrano i dati sulle liste di attesa per le Rems e quelli sempre più preoccupanti dei detenuti che sviluppano una patologia psichiatrica nelle carceri. Per non parlare poi della mancanza di risorse e di personale dei Dipartimenti di salute mentale che dovrebbero garantire assistenza territoriale per coloro che sono in libertà vigilata.
In questo scenario arrivano le due proposte di legge presentate di recente alla Camera. Una, di cui è firmatario il deputato Alfredo Antoniozzi di Fratelli d’Italia, lascia intatti i due articoli del Codice penale sul vizio totale e parziale di mente ma restringe la non imputabilità solo per gli autori di reato affetti da psicosi, considerando imputabili invece tutti quelli con disturbo di personalità. L’altra, decisamente più drastica, presentata da Riccardo Magi (+Europa) abroga i due articoli del Codice e considera tutti gli autori di reato con patologie psichiatriche imputabili e quindi tali da essere sottoposti a giudizio e ricevere una pena. È chiaro quindi che se da queste proposte di legge uscisse un testo poi approvato dal Parlamento, cambierebbe tutto il sistema delle misure di sicurezza così come è impostato adesso. Ed è facile ipotizzare che si aprirebbero ancora di più le porte delle carceri a persone malate di mente.
Ma andiamo per ordine, cercando di ricostruire la storia di questo travagliato rapporto tra giustizia, psichiatria e politica. La legge 180/78, determinando la chiusura dei manicomi, non aveva toccato la questione dei cosiddetti “folli rei”, che rimanevano confinati negli ospedali psichiatrici giudiziari. Bisogna attendere la legge 81/2014 per assistere alla chiusura progressiva degli Opg luoghi che in alcuni casi erano dei lager dove le persone ristrette a volte passavano tutta la loro vita (gli “ergastoli bianchi”).
Nel 2015 sono state aperte le Rems, strutture che accolgono sia i non imputabili, i “prosciolti”, sia coloro che sono in attesa di giudizio, i “provvisori”. È il sistema del “doppio binario”: una persona giudicata non imputabile viene sottoposta a misure di sicurezza perché giudicata pericolosa socialmente. Rimane poi la vasta platea dei detenuti che sviluppano patologie mentali in carcere (i “rei folli”) e che, secondo l’art. 148 del Codice penale una volta dovevano essere inviati negli Opg per osservazione e che adesso rimangono nei penitenziari. Le attuali 31 Rems, la cui gestione interna è esclusivamente di competenza sanitaria, sono in affanno, ospitano circa 600 persone e per via del numero chiuso molti rimangono fuori. Secondo i dati dell’ultimo rapporto di Antigone, l’associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, a dicembre 2022 erano 404 persone in lista d’attesa. La Società italiana di psichiatria nel congresso di fine maggio a Cagliari ha parlato di 700 persone “ad alta pericolosità sociale” a piede libero.
Su questi temi negli ultimi anni la Corte costituzionale si è pronunciata con due sentenze importanti. Con la sentenza 99 del 2019 la Consulta ha sancito un principio fondamentale: la salute psichica in carcere è equiparata alla salute fisica, per cui se la detenzione risulta incompatibile con le condizioni di salute della persona ristretta allora è possibile la cosiddetta detenzione domiciliare “in deroga” o “umanitaria”. La seconda sentenza, la 22 del 2022, ha richiamato la necessità di una riforma per risolvere l’inadeguatezza della disciplina sulle Rems.
Arriviamo quindi alle due proposte di legge depositate negli ultimi mesi alla Camera. Il testo di quella di Fratelli d’Italia è il frutto di una collaborazione con lo psichiatra Giuseppe Nicolò, che ha coordinato nell’interlocuzione con Antoniozzi vari dipartimenti di salute mentale. Lo stesso Nicolò è direttore del dipartimento della Asl 5 di Roma, è il curatore dell’ultima edizione del manuale diagnostico Dsm e all’inizio di maggio è stato nominato coordinatore vicario del tavolo tecnico della salute mentale istituito dal ministro Schillaci. La proposta di legge definisce la non imputabilità solo «per chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era in evidente condizione di grave alterazione delle condizioni psichiche, di tipo psicotico, e del comportamento tale da escludere completamente la capacità di intendere e di volere». Nel mirino dell’estensore della proposta di legge, come si legge nella relazione introduttiva, ci sono i disturbi antisociali di personalità che non sono «espressione sic et simpliciter di un disturbo mentale». Andrebbe così superata, secondo Antoniozzi, la storica sentenza della Corte di Cassazione del 2005 che invece aveva ammesso la non imputabilità, in quel caso, per un grave disturbo di personalità. Nella premessa al testo di legge si sostiene che gli psichiatri in Italia nella formulazione dei loro giudizi non possono «far riferimento a principi condivisi e chiari, come in tutti i Paesi civili» ed emerge un retroterra culturale sulla natura umana con riferimenti al pensiero cristiano giudaico (l’uccisione di Abele). Per gli autori dei reati con disturbi psichici imputabili rimane solo una possibilità: «l’espiazione in carcere». Certo, nei luoghi di detenzione si prevede un potenziamento «dell’offerta psicoterapica e farmacologica» e si sancisce il diritto costituzionale alla cura ma tra le righe si intravede il senso fortemente punitivo del provvedimento, tanto che Il secolo d’Italia annuncia la proposta di legge con il titolo: “Una riforma per garantire giustizia alle vittime”.
Il retroterra culturale della proposta di legge Magi appare diametralmente opposto, anche se va ben oltre, quanto a interventi su tutto il sistema. Il testo, si legge, nasce da una elaborazione collettiva a cui hanno partecipato vari soggetti, tra cui la Società della ragione, l’Osservatorio sul superamento degli Opg, il coordinamento delle Rems e dei Dsm, Magistratura democratica. La proposta di legge prevede che tutti gli autori di reato con vizio totale e parziale di mente siano imputabili – abrogazione quindi degli articoli 88 e 89 -, la dizione “persona inferma di mente” viene sostituita con “persona con disabilità psicosociale” e si propone la riconversione delle Rems come articolazioni dei dipartimenti di salute mentale delle Asl. Sono previste anche norme per definire «misure per evitare la carcerazione per il detenuto con disabilità psicosociale» sulla base della sentenza della Consulta del 2019 e anche norme perché il detenuto riceva in carcere cure adeguate. Franco Corleone, tra i promotori del testo, ex commissario per il superamento degli Opg e adesso garante dei detenuti a Udine, spiega il cuore della riforma: «Chiunque commetta un delitto, questo non può essere attribuito alla malattia. È lui che lo compie. Poiché ci sono molti malati che non compiono reati o crimini, il giustificazionismo rispetto all’origine del delitto in realtà non aiuta la consapevolezza e neppure quindi una risoluzione terapeutica della malattia, che indubbiamente esiste». Lo slogan ai tempi della legge 180 era “La libertà è terapeutica”, con tutte le conseguenze, visto che, a detta di molti psichiatri, non si sostenne poi la ricerca scientifica sulla psicopatologia. Adesso le parole chiave sono “La responsabilità è terapeutica”. Che cosa accadrà a queste persone? Il “diritto al giudizio”, continua Corleone, prevede «un’attenuante specifica per le condizioni del soggetto, in modo che non ci sia un giudizio persecutorio, ma correlato alla situazione. L’idea poi è di proporre a queste persone immediatamente un percorso di misure alternative. Quindi rimane la condanna ma in strutture adatte individualmente al soggetto perché lo spettro del disturbo mentale è molto vasto».
A proposito di strutture, qual è la situazione delle Rems? Franco Scarpa, ex direttore dell’Opg di Montelupo fiorentino, è responsabile della Rems di Empoli, partita nel 2020: «Le Rems dovranno modificarsi – dice -. Oggi sono tutte uguali, cioè non c’è differenza nei percorsi di accesso. Chi prima finiva nell’Opg oggi finisce nella residenza e invece per il futuro bisognerebbe pensare a Rems differenziate per livelli di gravità di patologia, a seconda della diagnosi, e anche per tipologia di reato che può richiedere in certi momenti un intervento specifico intensivo». Rispetto alle proposte di legge presentate, visto che si occupa anche della salute mentale delle carceri nell’Asl Toscana centro (Sollicciano, Prato), lo psichiatra sottolinea: «Bisogna che cambi molto nell’organizzazione del carcere per poter dare adeguati interventi di cura alle persone. Altrimenti si ricreano gli Opg in carcere».
Le carceri, appunto. Nei principali istituti di pena sono state create le articolazioni per la tutela della salute mentale (Atsm), sezioni a prevalente gestione sanitaria, sono 32 e ospitano attualmente, secondo il rapporto di Antigone, 247 pazienti. Ma il disagio psichico è diffuso in tutta la popolazione carceraria: nel 2022 le diagnosi psichiatriche gravi ogni 100 detenuti erano 9,2 (quasi il 10%), il 20% dei detenuti assumeva stabilizzanti dell’umore, antipsicotici o antidepressivi e il 40,3% sedativi o ipnotici. Ogni 100 detenuti le ore di servizio degli psichiatri erano in media 8,75, quelle degli psicologi 18,5. Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone, dipinge un quadro allarmante: «Le persone non imputabili vanno in Rems, quando trovano posto. Ma dei cosiddetti sopravvenuti, cioè coloro che sviluppano un disagio psichiatrico quando sono detenuti, se ne deve occupare il carcere. E allora occorre mettere risorse e impegno almeno su due temi». Primo: la maggioranza dei detenuti ha un disagio di tipo sociale e quindi c’è più bisogno di educatori che di «dargli delle goccine». Il secondo aspetto riguarda invece coloro che hanno davvero patologie mentali. «La situazione – continua Marietti – va gestita da un punto di vista psichiatrico, con una precisa presa in carico, queste persone non si possono “neutralizzare” dando loro dosi massicce di psicofarmaci o mettendole in isolamento. E poi va valutato, sulla base della sentenza della Corte costituzionale del 2019, se la permanenza in carcere è compatibile con la malattia. Ma purtroppo questo è difficile da attuare. Ci sarebbe bisogno di un servizio territoriale che però manca e la persona rimane in carcere». Nel 2018, a cavallo di due governi (Gentiloni e Conte1) ci fu la possibilità di potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti di pena quando si mise mano alla riforma dell’Ordinamento penitenziario. Ma vennero stralciate proprio le proposte sulla tutela della salute mentale.
Eppure il problema, si torna sempre lì, è quello della cura. Tiziana Amici, psichiatra in una azienda ospedaliera a Roma, ha fatto anche perizie sull’infermità di mente di autori di reato. I parametri sono quelli forniti dal manuale diagnostico del Dsm, quello maggiormente utilizzato dalla psichiatria, importato ormai da decenni dagli Stati Uniti. Nel testo, spiega la psichiatra, sono inclusi i disturbi di personalità, alcuni dei quali possono presentare in alcune occasioni sintomi cosiddetti psicotici per i quali non è facile stabilire sia se fossero presenti al momento del fatto sia in presenza di questi fare una diagnosi differenziale con vero e proprio disturbo psicotico. «Lo psichiatra – afferma Amici – deve stabilire se le alterazioni psicopatologiche del reo abbiano un nesso di causalità con il reato, non è la diagnosi di per sé che fa incapace un reo. E naturalmente conta molto il background, la formazione dello specialista nel comprendere se si tratta di un soggetto manipolativo e scaltro, oppure no. È chiaro che se uno si basa solo sul comportamento questo può risultare difficile». I percorsi di cura dei rei malati di mente, continua la psichiatra, dovrebbero essere differenziati «al fine di intervenire in maniera mirata per non compromettere gli interventi su pazienti che potrebbero essere limitati da coloro che hanno diagnosi meno gravi ma difficilmente trattabili». Bisognerebbe puntare sempre verso la cura, è possibile anche per chi ha il disturbo antisociale di personalità? «La cura sì, magari con un programma serrato, un progetto di vita pensato in un certo modo… Può darsi che chi ha un disturbo antisociale poi non delinqua più. Dove sta scritto che devono delinquere a vita?». Il nucleo del problema, sintetizza Tiziana Amici, è questo: «Se sei malato e hai fatto un reato, ma pure se non l’hai fatto in conseguenza della tua patologia, dovresti essere curato».